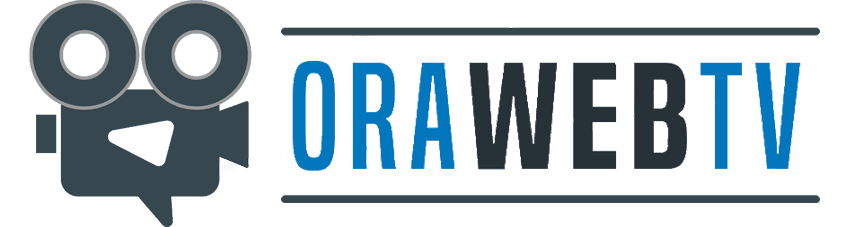IL REGIME TOTALITARIO RUSSO GLI HA IMPEDITO DI RECARSI A STOCCOLMA PER RITIRARE,IL PIU’ IMPORTANTE PREMIO ASSEGNATO ALLE PIU’ PIU’ PRESTIGIOSE PERSONALITA’ DEL MONDO,CHE FANNO LA STORIA DEL PROGRESSO UNIVERSALE.
BORIS PASTERNAK
Boris Leonodovič Pasternak (Mosca, 1890 – Peredelkino, 1960) è uno dei più grandi scrittori della letteratura russa. Cresciuto in una famiglia di coltissima borghesia ebraica (il padre era pittore, la madre concertista), Pasternak si dedicò in un primo momento alla musica, poi alla filosofia, per esordire infine come poeta nel 1914, con Il gemello nelle nuvole. Vicino dapprincipio al futurismo, nelle successive raccolte si distacca tuttavia da tale movimento, maturando una visione profondamente spiritualista e prossima al cristianesimo. Gli stessi orientamenti si ritroveranno nel suo capolavoro Il dottor Živago, la cui prima edizione mondiale uscì in Italia nel 1957. L’opera, pur non essendo apertamente anti-comunista, proponeva una lettura della storia sovietica assai distante da quella marxista ufficiale, tanto che le autorità ne vietarono la pubblicazione in patria e gli impedirono di ritirare il premio Nobel.
Pasternak Boris Leonidovič. – Scrittore russo (Mosca 1890 – Peredelkino, Mosca, 1960). Vicino ai futuristi, esordì con le poesie (Il gemello nelle nuvole”, 1914), imponendosi presto come il più interessante lirico russo della sua generazione. In un linguaggio dominato dal sentimento, modulò ora temi intimi vivificati da accostamenti imprevisti, ora temi patetici riportati a dimensioni quotidiane. Il suo primo racconto pubblicato fu Detstvo Ljuvers (1922; trad. it. L’infanzia di Ženja Ljuvers, 1960). P. lavorò poi segretamente al celebre romanzo Doktor Živago (pubbl. in trad. it., Il dottor Živago, nel 1957, e nell’originale russo negli Stati Uniti nel 1961), affresco della storia russa vista attraverso le tormentate vicende di un intellettuale.
VITA E OPERE
Figlio di un noto pittore e di una pianista di talento, dopo studî di musica, diritto e filosofia (seguì i corsi di H. Cohen a Marburgo) si avvicinò al gruppo futurista “Centrifuga”, esordendo come poeta sotto il segno dello sperimentalismo linguistico nella già citata raccolta Bliznec v tučach. Dopo la raccolta Poverch bar′erov (“Oltre le barriere”, 1917) s’impose con i versi di Sestra moja žizn′ (“Mia sorella la vita”, 1922). La sua vocazione di poeta denso ed ermetico, originalissimo nella descrizione della natura, fu confermata da Temy i variacii (“Temi e variazioni”, 1923), mentre meno felici sono i poemi di carattere narrativo ed epico (Devjat′sot pjatyj god “L’anno 1905”, 1927; Spektorskij, 1931), nei quali P. tentò la via di un impegno ideologico estraneo alla sua più autentica ispirazione. Nel frattempo aveva pubblicato il primo racconto, il già citato Detstvo Ljuvers, poi compreso nella raccolta Rasskazy (“Racconti”, 1925). In Ochrannaja gramota (1931; trad. it. Il salvacondotto), insolita autobiografia ricca di riflessioni teoriche e filosofiche, rievocò gli incontri con gli scrittori e gli artisti che più influirono sulla sua formazione (Rilke, Skrjabin, Majakovskij). A disagio nel clima di sempre più rigido controllo ideologico, dopo il volume di liriche Seconda nascita”, 1932) P. si dedicò per alcuni anni alla traduzione (da Shakespeare, Goethe, von Kleist, poeti georgiani), tornando a pubblicare proprî versi durante la guerra “Sui treni del mattino”, 1943; “La vastità terrestre”, 1945). Negli anni successivi lavorò segretamente al romanzo Doktor Živago. Scritto in una prosa lirica di grande suggestione, il romanzo valse a P. un’immediata notorietà in Occidente, ma le polemiche e gli attacchi cui fu sottoposto in URSS costrinsero lo scrittore a rifiutare il premio Nobel assegnatogli nel 1958. Nello stesso anno comparvero in Occidente (“Saggio autobiografico”) e le poesie di “Quando rasserena”, entrambi tradotti in it. in Autobiografia e nuovi versi (1958). Oltre a numerose edizioni dei suoi versi (Poesie, 1957; Tutti i poemi, 1969), in Italia sono comparse varie raccolte di suoi racconti (Disamore e altri racconti, 1976), saggi (La reazione di Wassermann, 1970; Quintessenza, 1990) e lettere (Lettere agli amici georgiani, 1976; Lettere, 1983); è del 2009 La nostra vita, antologia a cura di L. Avirovic degli scritti di Boris, del fratello minore Aleksandr e del figlio dello scrittore, Evgenij (questi ultimi inediti), in cui è magistralmente tratteggiata la storia di una famiglia aristocratica sullo sfondo della Russia prebolscevica.
POESIE
I TRENI DEL MATTINO
Boris Pasternak
Nel luglio del 2019 è uscita la prima traduzione integrale italiana di Boris Pasternak, Sui treni del mattino, a cura di Elisa Baglioni. Proponiamo una selezione di testi.
***
Una casa modesta, ma un sorso di rum
e il grog nero di un brogliaccio.
Una reggia in cambio di un bugigattolo
per la soffitta – un sontuoso palazzo.
Ogni traccia delle domande, dei passi
e delle onde della veste è svanita.
Chiusa nella grata del lavoro
la volta dell’aria è colma di mica.
La voce, imperiosa come un tributo,
fonde ogni cosa senza eccezioni.
Nella sua gola stagnata
cola il metallo dei cucchiaini.
Cos’è la gloria per lui e l’onore,
la rinomanza e un posto al mondo,
quando il respiro della fusione
parola allega a parola?
Darà alle fiamme per quell’attimo arredo,
amicizia, ragione, coscienza, usi.
Sul tavolo il bicchiere non finito,
il secolo non consumato, il mondo dimenticato.
Lingotti di rime, come cera di indovini,
ogni attimo cambiano aspetto.
Benedirà il respiro dei bambini
col loro vapore nelle camere da letto.
Dal ciclo L’artista
*
Sui treni del mattino
Ero fuori Mosca quest’inverno
ma sotto gelo, neve, tormenta
sempre, quando serviva,
per impegni me ne andavo in città.
Uscivo in quell’ora in cui
in strada non si vede a un palmo,
e spargevo il crepitio dei passi
per l’oscurità del bosco.
Si facevano incontro al passaggio a livello
i salici bianchi di un terreno incolto.
Sopra il mondo si levavano costellazioni
nella fossa fredda di gennaio.
Abitualmente dietro i cortili
il treno postale o il quaranta
mi rincorreva, mentre andavo
per quello delle sei e venticinque.
A un tratto le rughe scaltre della luce
riunivano i tentacoli in un cerchio.
Il fanale correva di gran mole
lungo il viadotto tramortito.
Nel caldo afoso del vagone
mi abbandonavo interamente
a uno slancio di innata debolezza
che avevo succhiato col latte.
Attraverso le peripezie passate
gli anni di guerra e di miseria
in silenzio riconoscevo della Russia
i tratti irripetibili.
Contenendo l’adorazione
osservavo e veneravo.
C’erano donne, studenti, fabbri,
gente proveniente dai villaggi.
Non una traccia del servilismo,
in loro, impressa dal bisogno,
le notizie e i malesseri
portavano come signori.
Assiepati in gruppi, come in un carro,
in tutta la varietà delle pose,
bambini e ragazzi leggevano
d’un fiato, come ingranaggi avviati.
Mosca ci incontrava nelle tenebre,
che viravano verso l’argento,
liberandoci della duplice luce
uscivamo fuori dal metrò.
La gioventù premeva al parapetto
e, al suo passaggio, m’investiva
di sapone fresco al ciliegio
e di pan pepato al miele.
1941
*
Di nuovo la primavera
La partenza del treno. Il terrapieno nero.
Come rintraccerò la strada al buio?
Un tratto irriconoscibile,
benché solo un giorno sia stato lontano.
Sulle traverse si smorza lo stridore della ghisa
d’un tratto salta fuori una nuova bizzarria.
Parapiglia, dicerie di comari.
Quale diavolo le ha sobillate?
Chissà dove ho udito i frammenti
di questi discorsi la stagione dell’anno passato?
Ah, forse, oggi nuovamente
sarà uscito di notte un ruscello dal bosco.
Come tempo addietro,
l’argine ha mosso i ghiacci e s’è gonfiato.
È, in verità, un nuovo prodigio,
è, come un tempo, ancora primavera.
È lei, è proprio lei,
è il suo incantamento, la sua meraviglia.
È la sua giubba imbottita oltre il salice,
le spalle, lo scialle, il busto e la schiena.
È come Snegurka sull’orlo del dirupo.
È su di lei che dal burrone dal fondo
scorre senza sosta il delirio frettoloso
di un chiacchierone scriteriato.
È di fronte a lei, allagando le barriere,
che affonda nel fumo acquoso una rapida,
come una lampada di una cascata sospesa,
è inchiodata col sibilo alla scarpata.
Coi denti che battono per il raffreddore
scorre nello stagno e dallo stagno in altra conca
il fiotto gelato oltre la proda.
Il discorso della piena è il delirio dell’essere.
1941
Dal ciclo Peredelkino
*
Una fiaba terribile
Cambierà ogni cosa intorno.
La capitale sarà rimessa in piedi.
Dei bambini destati lo spavento
non sarà perdonato nei secoli.
Non si potrà dimenticare la paura
che ha solcato i volti.
E il nemico dovrà pagare
per questo cento volte tanto.
Il suo fuoco sarà ricordato.
Sarà messo in conto il tempo,
in cui fece quel che voleva,
come Erode a Betlemme.
Verrà un nuovo secolo, migliore.
Scompariranno i testimoni oculari.
Dei piccoli mutilati le pene
non si potranno dimenticare.
1941
Dal ciclo Poesie sulla guerra
IL DOTTOR ZIVAGO
Quando pubblica Il dottor Zivago, l’opera che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Boris Pasternak (1890-1960) ha già alle spalle una lunga attività di scrittore che lo ha portato a vincere il Premio Nobel per la letteratura nel 1958, ma che fu costretto a rifiutare dalle autorità del suo paese. Nato a Mosca da una famiglia di artisti (padre pittore e madre pianista), l’attività poetica di Pasternak, il quale si dedica anche allo studio della filosofia e alla musica, avviata nel 1914 con i versi del Gemello nella nuvola, era poi proseguita con numerose raccolte (Oltre le barriere, Sorella mia la vita, Temi e variazioni, Sui treni mattinali, e con due ampi poemi storici: L’anno 1905 e Il luogotenente Schmidt, entrambi del 1927, cui si era affiancata la raccolta di poesie Il salvacondotto del 1931.
Ma è con Il dottor Zivago che Pasternak ottiene il successo, scegliendo il genere del romanzo, con l’obiettivo di comporre un grande affresco della Russia e dell’Unione Sovietica dei primi decenni del Novecento. Il protagonista, il medico Jurij Zivago, passa attraverso le vicende più significative del suo paese (la prima guerra mondiale, la rivoluzione, la guerra tra i comunisti rivoluzionari e le truppe fedeli allo zar), ma il suo punto di vista non è quello dell’eroe combattente a lungo celebrato dalla letteratura sovietica. Lasciata infatti Mosca nei giorni difficili che seguono l’entusiasmo della rivoluzione, Zivago si trasferisce con la famiglia in un paesino sugli Urali, dove è più coinvolto dall’amore per una giovane donna, Lara, che dagli avvenimenti storici. La lotta in corso, tuttavia, lo stravolge: catturato da una banda partigiana, deve abbandonare tutto. Al suo ritorno non troverà più la famiglia, trasferitasi all’estero, e anche il rinnovato amore per Lara, sarà di breve durata. Tornato sol a Mosca, Zivago crea una nuova famiglia, dalla quale fuggirà, morendo ancora giovane, in totale solitudine.
Pur intrecciando la storia del suo paese con la storia d’amore di Zivago, Pasternak non è tanto interessato ad esprimere un giudizio sugli avvenimenti storici (e neppure una condanna della rivoluzione sovietica), quanto a mostrare il significato di una vita individuale dentro i travolgimenti della storia e le difficoltà di vivere in una dimensione privata e in una dimensione pubblica. A tal proposito è significativo ciò che afferma lo stesso Zivago:
<<L’epoca non tiene conto di me, mi impone ciò che vuole. Permettete dunque anche a me di ignorare i fatti>>.
Alla sua uscita Il dottor Zivago venne letto soprattutto in chiave politica, suscitando accese polemiche da parte dei critici marxisti, e diventò presto un’occasione di scontro tra i fautori e i detrattori dell’intera esperienza politica dell’Unione Sovietica. l’estraneità di Zivago alle vicende politiche, che suona come una condanna della stessa storia umana e dell’impegno a cambiarla, e ancora di più la visione spirituale della vita che circola in tutto il libro suscitano ancora oggi discussioni. In realtà la grandezza del romanzo di Pasternak non va cercata nel suo significato ideologico, come ha sottolineato nel 1958 Franco Fortini, il quale pur riconoscendo gli squilibri strutturali della narrazione, che parte in un modo e si sviluppa in un altro, ha definito Il dottor Zivago “un libro vivente, con passaggi di grandissimo respiro, con almeno un personaggio indimenticabile: quello di Lara. Un libro che non rientra o rientra malamente, nelle categorie tradizionali o in quelle dell’avanguardismo di ieri e di oggi, e dunque un libro che non si cessa di rileggere per sorprenderne il segreto difficile”.
Questo segreto può essere ricondotto al lirismo delle descrizioni dagli echi cechoviani e alla struttura tragico-drammatica di alcune situazioni del romanzo, che per alcuni rappresentano un difetto. Al di là delle polemiche, che hanno coinvolto perlopiù la critica letteraria italiana, occorre individuare nel Dottor Zivago una grande narrazione che, pur scavando nella vita degli uomini e nel rapporto con il tempo, come nei romanzi ottocenteschi, non ne segue fedelmente il modello. Pasternak infatti persegue piuttosto l’ideale di un grande ‘poema in prosa’, nel quale le scene vengono accostate e spesso accavallate l’una all’altra, con un procedimento più poetico che narrativo. Senza dubbio Il dottor Zivago è l’espressione simbolica della vita di Pasternak
INTERVISTA ALLA TRADUTTRICE DEL DOTT. ZIVAGO
“Quello lascialo sempre entrare”: Pasternak il poeta fondamentale del ’900. Intervista alla traduttrice del “Dottor Živago”
Boris Pasternak è l’artista centrale del Novecento. Lo è per l’opera, ovviamente. Pasternak è tra i poeti più grandi del secolo – basti leggere il poemetto Le onde – e uno dei prosatori più delicati. Il salvacondotto e soprattutto Il dottor Živago si sono impresse come opere indelebili, per quanto imperfette, perché ci sembra che, dal cuore della narrazione, ci sia svelato il segreto ultimo del vivere. Pubblicato, attraverso un escamotage da ‘spionaggio’ editoriale, da Feltrinelli nel novembre del 1957 – la vicenda è ricostruita dettagliatamente da Paolo Mancosu in Živago nella tempesta, Feltrinelli, 2015 – “Živago” va ben al di là del romanzo, come ha ricordato proprio Feltrinelli a Pasternak in una lettera rivelativa: “Živago ha impartito una lezione indimenticabile. Ora so che ogni volta che non saprò come andare avanti potrò tornare a Živago e imparare da lui la più grande lezione di vita. Živago sarà sempre accanto a me quando queste cose mi sembreranno perse per sempre, per aiutarmi a ritrovare i valori semplici e profondi della vita” (5 settembre 1958). Boris Pasternak non è il poeta più grande del Novecento – non c’è gerarchia nell’assoluto, ma più vasti di lui sono Saint-John Perse, Thomas S. Eliot, Rainer Maria Rilke – e non è il più grande romanziere – sono insormontabili James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka, Thomas Mann, William Faulkner. Eppure, è l’artista decisivo del Novecento, il più emblematico. Pasternak, che è stato nel cuore della Storia fino a udirne l’ossessivo rimbombo, incarna il poeta che evade dalla Storia, che è ben al di là delle cronologie e delle grammatiche del tempo. Come scrive Angelo Maria Ripellino – che riteneva, con una certa giustizia, che le poesie fossero la quintessenza di Pasternak e lo ‘Živago’ un’opera ‘minore’ – il massimo interprete di Pasternak in Italia, “Pasternak si ritrasse sin dagli inizi in una sua gelosa solitudine… e negli anni tumultuosi della rivoluzione si tenne ancora in disparte, diffidando dei temi politici e di quella poesia tribunizia in cui s’era invece tuffato Majakovskij con tutta l’anima. […] Egli passava nel folto delle battaglie, che avrebbero mutato la Russia, come un sonnambulo, destandosi a tratti per annotare con voce assonnata, non le gesta del popolo, ma i prodigi del cosmo”. Falciato dalla Storia, ma invitto – nel 1958, dopo aver ricevuto il Nobel per la letteratura, che rifiuterà, accusato di “tradimento nei confronti del popolo sovietico”, scrive, con candida fermezza, all’Unione degli scrittori, “mi potete fucilare o deportare, potete fare quello che volete, vi perdono in anticipo” – Pasternak attraversa tradizioni e uomini – allievo di Aleksandr Skrjabin, amico di Rilke, passò la Seconda guerra a difendere l’Occidente traducendo Shakespeare e Goethe – con la pazienza di un geniale testimone, costellato da versi memorabili (“frequentando il futuro nella vita di ogni giorno/ non si può non incorrere, infine, come in un’eresia/ in un’incredibile semplicità”), consapevole che il tempo e le oscurità passano, falangi di falene impazzite, ma la poesia resta, “sempre eguale a se stessa, più alta di ogni Alpe d’altezza celebrata”, come disse, sonnambulo, a Parigi, nel 1935, “essa giace nell’erba, sotto i nostri piedi, e bisogna soltanto chinarsi per scorgerla e raccoglierla da terra; essa sarà sempre troppo semplice perché se ne possa discutere nelle assemblee; essa rimarrà sempre la funzione organica dell’uomo”. Ora, 60 anni dopo, abbiamo, finalmente, una nuova traduzione, definitiva, del Dottor Živago (Feltrinelli 2017, pp.632, euro 19,00), quella compiuta da Serena Prina – già uscita in una ‘edizione speciale’ del cinquantesimo, nel 2007 – straordinaria traduttrice di Dostoevskij, di Lev Tolstoj, di Michail Bulgakov, di Nikolaj Gogol’, insomma, tra le grandi interpreti dei classici russi in Italia. Per me, da par mio, è ‘la neve di Pasternak’, vezzeggiativo che le ho affibbiato quando l’ho invitata al dialogo.
Parto in quarta. Angelo Maria Ripellino ritiene ‘Živago’ l’opera meno riuscita di Pasternak. Il vero Pasternak è nelle poesie (alcune delle quali, come si sa, per altro, stanno in appendice al romanzo). Lei concorda con questa opinione? Come si colloca ‘Živago’ nella grande tradizione del romanzo russo, quali i modelli principali?
“Parto dall’ultima di queste sue domande, per ricordare come l’inizio di Živago sia una diretta citazione dell’incipit della Guardia Bianca: il figlio (in Bulgakov i figli) al funerale della madre, con tutte le implicazione che quest’immagine potente poteva avere nella Russia di fine secolo (per Pasternak) e di una Russia al cospetto della rivoluzione (per Bulgakov). Živago si inserisce dunque prepotentemente, e consapevolmente, in quella tradizione di romanzi che si interrogano su ‘Dove va la Russia?’, tra i quali non posso non citare Le anime morte di Gogol’. E questa domanda a proposito di ‘dove va la Russia?’ per Pasternak, grande poeta, si fonde con il suo interrogarsi su ‘dove va la lingua russa?’. A parer mio Živago rappresenta il contributo, in prosa, a un ragionamento sul destino della poesia nel ’900”.
Poi. Che tipo di cambiamenti sostanziali ha operato rispetto alla ‘canonica’ traduzione di Zveteremich? Che linguaggio è quello del Pasternak prosatore?
“Quando Zveteremich, con grande coraggio e intuizione, insistette con l’editore Feltrinelli e contribuì in modo sostanziale alla decisione di pubblicare Živago, si trovò ad affrontare la traduzione di un’opera estrememente complessa con pochissimo tempo a disposizione. Le vicende che seguirono sono note. La primissima traduzione venne revisionata dalla Olsufieva e da Socrate, al quale si deve la traduzione delle poesie di Živago, e solo successivamente, negli anni ’90, Zveteremich poté ritornare sul testo in occasione della pubblicazione del romanzo nei ‘Meridiani’ Mondadori. Ciascuna di queste fasi fu naturalmente accompagnata da un ‘passaggio’ redazionale, e tra il testo originario e il lettore si sono progressivamente interposte varie voci: il risultato è un testo ‘perfetto’, levigato e scorrevole ma, almeno in qualche punto, non del tutto coincidente con lo spezzettarsi della frase pasternakiana (soprattutto nella seconda parte del romanzo), dove il testimone della rivoluzione quasi non trova più parole. Per quel che mi riguarda, ho avuto dalla mia il tempo (e quindi la possibilità di affrontare anche la traduzione dell’ultimo capitolo del romanzo, dove sono raccolte le poesie di Živago) e una redattrice di grande sensibilità, Annalisa Agrati. Tra il testo russo e il lettore c’è dunque una sola voce e la possibilità di cogliere il variare delle sue intonazioni senza subire interventi esterni. E di intonazioni, in Živago, ce ne sono davvero tante”.
Tra la prosa del Salvacondotto e quella di ‘Živago’ pare esserci, davvero, in mezzo, un mondo, una rivoluzione. Come influisce, a suo avviso, la storia nella scrittura di Pasternak?
“In Živago c’è la grande Storia, che si intreccia alla storia dei suoi personaggi, all’incrociarsi e allo smarrirsi dei destini in un’epoca inquieta. Ma, come ho accennato, c’è anche la storia di una lingua, soprattutto letteraria.
Leonid Pasternak, ‘Boris Pasternak mentre scrive’, 1919
Si parte dalla lingua anticorussa del canto funebre che apre il romanzo, si passa attraverso pagine gogoliane, a citazioni dirette di Puškin, Tolstoj, Tjutčev, Blok, si approda all’impatto con la nuova lingua sovietica, fatta di acronimi e apparente dinamismo, si sprofonda nell’afasia di un poeta che sembra non trovare più parole. Il tutto si intreccia alla lingua della natura e dell’amore tra Jurij e Lara, nella quale si manifestano le immagini caratteristiche della poesia pasternakiana. L’ipotesi finale proposta da Pasternak è quella di un ritorno a una lingua primigenia, conservatasi nel profondo della Russia e della quale nel romanzo è portatrice la figlia abbandonata di Lara e Živago. Il poeta non poteva certo immaginare cosa sarebbe invece successo alla lingua russa nel giro di pochi decenni”.
Nella Nota lei definisce Živago uno “jurodivyj che in silenzio attraversa mezza Russia, e che poi in silenzio siede in disparte nei salotti”. Lo jurodivyj è una figura canonizzata dalla letteratura russa: ce la spieghi.
“Il protagonista si chiama Jurij Andreevič e il romanzo ha inizio alla vigilia della festa del Pokrov, dell’Intercessione della Vergine, che si celebrava il primo (14) ottobre per festeggiare la comparsa della Madre di Dio al beato Andrej Jurodivyj. È Pasternak stesso, quindi, a sottolineare con forza il collegamento profondo tra il suo protagonista e, appunto lo jurodivyj, il cosiddetto ‘folle in Cristo’, colui che rinunciava a un ruolo sociale integrato in cambio della possibilità di denunciare gli abusi e le ipocrisie della società”.
Divago. Qual è il russo che le ha dato più gioia tradurre? Perché? E poi: perché la letteratura russa?
“Quando si parla di gioia nel tradurre si esclude Dostoevskij (il più amato), perchè lì c’è solo passione e tormento e fatica. Quindi direi Gogol’, con il suo genio assoluto, l’umorismo travolgente, il suo riso tra le lacrime. Perché il russo? Forse perchè un mio vicino di casa, un pianista russo emigrato, Il’ja Grinshtein, veniva a sentir musica con mio padre, e per ricambiare si offrì di insegnare il russo ‘alla bambina’. Così mi insegnò l’alfabeto, ogni pomeriggio salivo al piano di sopra, leggevo La signora col cagnolino e non capivo una parola, ma lui si beava della mia lettura, mentre la vecchia zia preparava il tè col samovar e la Russia mi entrava nel sangue. O forse perché una volta i ragazzini avevano il tempo di leggere, e quando si comincia a leggere i russi, non si può più smettere”.
Ultima. Che valore ha, oggi, la testimonianza poetica di un autore come Pasternak?
“Le risponderò raccontando un episodio forse poco noto su Pasternak e Bulgakov. Quando quest’ultimo, malatissimo e quasi morente, accettò di incontrare il poeta, i due rimasero a lungo a conversare, da soli. Poi Pasternak se ne andò, e la moglie di Bulgakov ricorda che Michail Afanasevič le disse: ‘A quello, lascialo sempre entrare’. Non ci fu un secondo incontro, pochi giorni dopo Bulgakov morì. Ma Pasternak è rimasto davvero un autore che bisogna sempre ‘lasciar entrare’”.
MIA SORELLA ,LA VITA
In questo tempo di protratta incertezza, confinamenti e solitudini amplificate la poesia può forse offrire uno spiraglio, può aiutare a restituire il senso che fugge, ricondurre il caos degli elementi a un ordine universale. Alcune poetiche ci riescono più di altre. E al loro interno alcuni libri ci riescono con maggiore forza. La raccolta Mia sorella la vita, pubblicata quasi un secolo fa (1922) e riproposta integralmente in italiano dalla casa editrice Passigli [Mia sorella la vita], è tra questi. Considerato un caposaldo dell’opera poetica di Boris Pasternak la raccolta è concepita alla vigilia della rivoluzione. Prima che il movimento storico delle masse si incagliasse nella sua terribile cristallizzazione, Pasternak ne fotografa il divenire rivoluzionario: Mia sorella la vita “esprime lo stadio della rivoluzione più vicino al cuore e alla poesia – l’alba della rivoluzione e il suo erompere, quando essa riporta l’uomo alla sua vera natura e vede lo stato con gli occhi della legge naturale”. Scrive il poeta in una lettera a Brjusov nel 1922. L’esistente è mutevole e iridescente, colto dai raggi del sole che illuminano il velo d’acqua steso sulla sua superficie; la natura è in rivolta; “un acquazzone di luce” è l’intera raccolta, secondo Marina Cvetaeva. Pasternak si mette in ascolto, (in)vita ad accogliere ogni accadimento nel senso etimologico di “cadere verso”: movimento in divenire e esperienza della caduta. C’è il sussurro di Rainer Maria Rilke nella convinzione che tutto valga la pena di essere vissuto e di essere attraversato, che la meraviglia porti con sé lo spavento. Del resto i versi conclusivi della Decima elegia di Rilke riassumono questo modo di sentire vicino a Pasternak: “la pioggia che cade su terra scura e primavera.// E noi che pensiamo la felicità/come un’ascesa, ne avremmo l’emozione/ quasi sconcertante/di quando cosa ch’è felice/cade.”
Pasternak rompe gli argini della soggettività per fondersi con gli abissi siderali, con il midollo vibrante della natura, persino quando racconta le vicende private della storia d’amore con Elena Vinograd. Il poeta si lascia smembrare come un Orfeo: non c’è andamento ragionativo, né progressione narrativa, ma continui frammenti in cui possiamo specchiarci solo frangendoci o riflettendo l’esterno; dentro lo specchio appare il giardino, i rami rotti, il caos come suggerisce la poesia dal titolo Lo specchio. In quegli anni Pasternak è vicino alle poetiche futuriste, che rifiutano la convenzionale rappresentazione della realtà e ricercano nuovi mezzi espressivi. Lo stile delle sue prime raccolte è spesso associato all’oscurità di senso e all’indecifrabilità. Sono difficili da comprendere se proviamo con la ragione, ma si sa che in Russia molte cose non si comprendono “con il senno” [Tjučev, La Russia non si intende con il senno]. Succede perché la poesia, non solo in Russia, muove i corpi, evoca il contatto, esige l’ascolto.
Alcune poesie si schiudono davanti ai nostri occhi, come la penultima della raccolta, rivelando l’intero percorso che la vita riserva. Due azioni al modo infinito si impongono e aprono la composizione: “amare” e “andare”; il movimento che generano è caotico e scomposto. In gioventù l’amare e l’andare producono ostacoli e inebriamento, “le fronde ti urtano la faccia”, i baci fanno perdere la strada. La terza strofa indica un primo passaggio di maturità, arriva la consapevolezza dello scorrere del tempo, scandito dalla presenza di ogni cosa, oggetti celesti e terreni, persone, parole (o loro assenza), figure dell’immaginazione. Il mondo spaventa per i suoi cambiamenti, intima al silenzio. Con la maturità si ripensa al passato, “racimolare tra le loro spine/ i fatti degli anni”, subentra la stanchezza della vecchiaia dovuta al caldo o forse al freddo del corpo che si avvicina alla morte. Ma il movimento continua attraverso il canto e il processo del morire. Si continua a cantare fino a tornare alle mani di lei (del primo amore? della vita? della natura?) e fino all’ultima parola del componimento che in russo è prošalsja ( tradotto con “accomia tandomi”). Infine il congedo, un poco cerimonioso, da una vita che nasce come sorella.
Amare – andare – non si tace il tuono,
pestare angoscia, non conoscere scarpe,
spaurire i ricci, ripagare col bene
il male dei mirtilli avvolti in ragnatele.
Bere da fronde che ti urtano in faccia,
e rimbalzando striano l’azzurro:
“questa è l’eco che fanno?” – e verso la fine,
perdere per via dei troppi baci la strada.
Come a suon di marcia, vagare pieni di lappole.
Apprendere al tramonto che il sole è più vecchio
di certe stelle e certi carri con l’avena,
di Margherita e della locandiera.
Perdere lingua e abbonamento al fortunale
di lacrime negli occhi di valchirie,
e, nell’afa, a tutto cielo ammutolendo,
l’alberatura del bosco affogare nell’etere.
Stesi, racimolare tra le loro spine
i fatti degli anni, come pigne di pini:
lo stradone; la nostra scesa alla Taverna;
albeggia e noi geliamo, mangiamo pesce.
E nel cadere, cantare: “Canuto,
andavo e caddi spossato. Un tempo
la città si ingozzava di gramigna,
a bagno in lacrime di mogli di soldati.
All’ombra di aie lunghe e illuni,
di luci di spacci e di fiasche,
di certo anche lui, il vecchio,
finirà per tirare le cuoia”.
Così cantavo, cantavo e morivo.
Tanto morivo, quanto ritornavo
alle mani di lei, come un boomerang,
accomiatandomi – se ben ricordo.
La voce italiana di questa raccolta è di Paola Ferretti. La traduttrice non si limita di inseguire una presunta letteralità ma intende riportare la poesia al suo livello extra-semantico, mettendo in campo l’invenzione lessicale, sonora e retorica, cercando in italiano, come nell’originale, la densità di senso per mezzo del tessuto sonoro, la condensazione ritmica che, nelle preziose traduzioni di Ripellino, appare più diluita. La traduzione di Ferretti potrebbe rappresentare una meta-riflessione sul tradurre poiché si coglie una specifica poetica, una scelta di modo e di metodo. E tra le tante strategie messe in atto, è interessante sottolineare un determinato scarto tra l’originale e il testo tradotto: in russo la discendenza dei componimenti dalla dimensione orale è evidente nella presenza di parallelismi e anafore che, al pari della griglia metrico-rimica, costituisce l’ossatura del dispositivo di memorizzazione nella misura in cui i segmenti ricorrenti diventano appigli della memoria; nella versione italiana, se il rigido schema rimico-metrico salta, si riducono notevolmente i procedimenti “formulari”. Attraverso tali scelte la traduttrice sembra esprimere l’impossibilità di restituire la dimensione orale dei componimenti, forse suggerendo la natura eminentemente scritta della traduzione di poesia nella cultura contemporanea, il suo legame con la cultura del libro e, di riflesso, con la cultura alta; o forse ricordando il percorso di trasformazione della poesia occidentale verso la dimensione scritta (o di una parte di essa), e con essa di una sua costola, la traduzione, in contrasto con la tradizione russa, in cui la poesia, almeno per tutto il Novecento, ha coltivato la sua dimensione orale e oracolare.
IL SALVACONDOTTO
Si potrebbe giudicare questo libro superfluo e non essenziale se lo si paragona alla grandezza della prosa del “Dottor Zivago” ed all’innegabile suggestione racchiusa nei versi di Pasternak. Il lettore può quindi inoltrarsi nell’opera dell’autore ed apprezzarla quanto merita, anche se privo di questo salvacondotto. Ma spesso è in ciò che a prima vista appare superfluo che si nascondono tesori inaspettati, sono quindi felice di aver letto queste pagine. Poiché, se è vero che l’opera, una volta prodotta, ha una sua vita autonoma, alla quale il lettore in qualche modo partecipa e alla quale contribuisce, è anche indubbio che per il vero appassionato di letteratura è di vitale interesse venire a conoscenza di quel vero mistero (e insieme miracolo) che è la storia della formazione di una voce poetica, dei percorsi attraverso i quali si è formata, delle passioni di cui si è nutrita, soprattutto all’origine, e degli incontri da cui ha tratto ispirazione. “Il salvacondotto” dà l’opportunità di apprendere tutto ciò dalla stessa voce di Pasternak: non si può quindi certo definire un’autobiografia nel senso più stretto del termine, quanto una riflessione pubblica, la presa di coscienza di uno scrittore che rievoca le proprie origini spirituali e culturali, e che permette ai lettori di ripercorrere insieme a lui le prime tappe del proprio percorso formativo.
Il libro ha inizio con un incontro e si conclude con un commiato. In entrambi i casi si tratta di un grande poeta. Il primo è Rainer Maria Rilke (alla memoria del quale il libro è dedicato) che Pasternak nel 1900, a dieci anni, incontra durante un viaggio in treno. Rilke, nel suo secondo viaggio in Russia, si sta recando a far visita a Tolstoj e, nella memoria del piccolo Boris, si fissa come l’immagine di “un tale avvolto in una nera mantella”, accompagnato da una donna alta “forse sua madre o forse una sorella maggiore” (si tratta in realtà di Lou Andrea-Salomè). Il secondo è Vladimir Majakovskij e il 14 aprile 1930, il giorno del suo suicidio, rappresenta anche la data conclusiva del “Salvacondotto” (che verrà pubblicato l’anno successivo). Dall’osservatorio privilegiato che questo libro rappresenta sull’origine della creatività di Pasternak, si apprende innanzitutto che il suo percorso formativo inizia dalla musica, prosegue con la filosofia e trova infine nella poesia gli strumenti espressivi più adatti. E forse, in parte, è questo il segreto del continuo dispiegarsi del suo linguaggio tra armonia e pensosità, tra la tentazione della dolcezza e l’esigenza dell’esattezza rigorosa. “Più di tutto amavo la musica, più di tutti in essa amavo Skrjiabin”, e ancora: “Ne dissero molte, ma l’essenziale è che, pur se avessero detto il contrario, non sarei riuscito a concepire la mia vita senza la musica”. E sarà proprio Skrjiabin ad indirizzare il giovane Pasternak verso gli studi filosofici. Nel frattempo l’influenza di Bely e Blok lo spinge verso la letteratura: “Udivo spesso il sibilo d’una tristezza, che non era nata con me. Aggredendomi alle spalle, quel sibilo mi atterriva e mi colmava di pietà. Veniva dalle cose quotidiane e ora minacciava d’intralciare la realtà, ora scongiurava d’essere associato all’aria viva, che nel frattempo s’era spinta assai lontano. Nel volgermi indietro consisteva ciò che si chiama ispirazione”. “Il salvacondotto” è anche un libro di luoghi, non certo un resoconto di viaggi, ma una sorta di omaggio ai luoghi dell’anima, tra tutti, due: Marburgo, scelto da Pasternak come sede degli studi universitari, e Venezia, meta di uno dei suoi viaggi e luogo dell’incontro con l’arte italiana. I capitoli che concludono la seconda parte, dedicati al tempo da lui trascorso in questa città, costituiscono un libro nel libro; sono pagine in cui il lettore è costretto a rivedere la città attraverso gli occhi di Pasternak e ad aggiungere suggestioni inedite al proprio immaginario veneziano. Architetture, atmosfere, luoghi, scorci ed incontri che costituiscono una sorta di repertorio poetico: “Li chiamano palazzi, ma potrebbero esser detti castelli incantati, e tuttavia non c’è parola che possa dar l’idea di questi tappeti di marmo colorato, a strapiombo sulla laguna notturna, come sull’arena di un torneo medievale. C’è un singolare oriente, da albero di Natale, è l’oriente dei preraffaelliti. C’è l’immagine di una notte stellata secondo la leggenda dell’adorazione dei magi. C’è un eterno paesaggio natalizio: una superficie di noce dorata, spruzzata di paraffina blu. Ci sono le parole chalva e Caldea, magi e magnesio, India e indaco. Fra esse va compreso anche il colore della Venezia notturna e dei suoi riflessi acquei”. La terza e ultima parte del libro, vera miniera per chi ama la letteratura russa dei primi decenni del 900, è tutta dedicata a Vladimir Majakovskij. I due scrittori, coetanei (del 1890 il primo, del 1892 il secondo), si incontrano a Mosca nella primavera del 1914. Pasternak ne fa un ritratto che trasuda ammirazione e, soprattutto, profonda comprensione, delinea i tratti salienti del suo modo di essere, di agire e di vivere, che sono anche quelli del suo modo di concepire la poesia: “Più di ogni altro, Majakovskij era tutto nel suo manifestarsi. C’era tanto di espresso e di definitivo in lui, quanto poco ce n’è nella maggioranza, che di rado e solo per effetto di particolari sussulti esce dalle tenebre dei propositi non lievitati e delle congetture non inverate. Lui sembrava esistere all’indomani di una vita spirituale immensa, vissuta intensamente per ogni caso, e tutti ormai lo sorprendevano nell’intreccio dei naturali effetti di quella vita. Sedeva su una sedia, come fosse il sellino di una motocicletta, si protendeva in avanti, tagliava e inghiottiva rapidamente una cotoletta, giocava a carte, guardando di sbieco e senza muovere la testa, passeggiava maestosamente sul Kuznetskij, recitava con voce strascicata e sorda, come litanie, i brani più intensi composti da lui o da altri, si accigliava, cresceva, viaggiava e si esibiva in pubblico, e nel fondo di tutto questo, come nel guizzo rettilineo d’un pattinatore, s’intravedeva sempre un giorno tutto suo, antecedente a tutti gli altri giorni, il giorno in cui era stata presa quella rincorsa meravigliosa che lo faceva apparire così immenso e agile. […] Eppure la molla della sua arroganza era una timidezza assurda, e dietro la sua simulata volitività si celava un’abulia eccezionalmente ombrosa e incline a un’immotivata tetraggine. Altrettanto ingannevole era il meccanismo della sua blusa gialla. Che non gli serviva per lottare contro le giacchette filistee, ma conto il nero velluto del suo talento, le cui forme leziose, dalle nere ciglia, avevano cominciato a irritarlo ben prima di quanto accada a gente meno dotata”. Ammaliato dalla sua personalità, Paternak ripercorre negli ultimi capitoli del “Salvacondotto” tutta la vicenda poetica ed umana di Majakovskij, fino a regalarci la testimonianza “in diretta” dei tragici avvenimenti del 14 aprile 1930, culminanti nell’ultima immagine del corpo morto del poeta, destinata a restare a lungo impressa nell’anima del lettore: “Giaceva sul fianco, il viso rivolto alla parete, accigliato, grande, nascosto fino al mento dal lenzuolo, con la bocca socchiusa, come in sonno. Voltando fiero le spalle a tutti, anche così disteso, anche nel sonno, sembrava slanciarsi caparbiamente chissà dove e allontanarsi. Il suo volto mi riconduceva ai tempi in cui aveva detto di sé “bello, ventiduenne”, perché la morte aveva ossificato la mimica, che raramente le capita di serrare tra i suoi artigli. La sua era un’espressione con cui dà inizio e non si mette fine alla vita. Era imbronciato e indignato”.