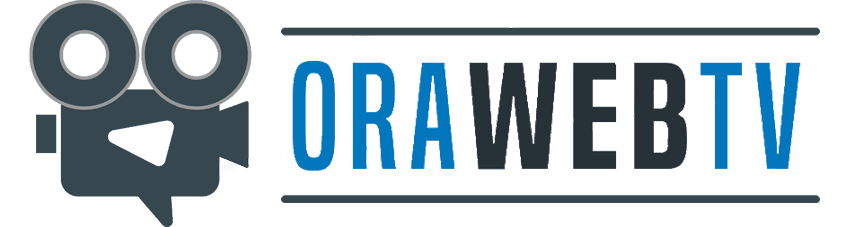Tra le voci più alte della poesia italiana del XX secolo viene ritenuto Eugenio Montale, personalità molto originale e intensamente attiva, con l’originalità di un linguaggio potente, frutto delle geniali risorse della profondità del suo pensiero, sempre vibrante di tensione conoscitiva che alimenta la potenza della sua fantasia lirica, capace di tendere all’apertura di uno spiraglio di luce gnoseologica che illumini il buio del mistero, in cui è imprigionato senza possibilità di riuscire a dipanare l’intreccio di invisibili trame ontologiche di cui ogni sillogismo della ragione rivela la sua impotenza perforatrice.
Nato a Genova il 12 ottobre 1896 da un’agiata famiglia della media borghesia, dedita al commercio, compiuti gli studi delle scuole medie inferiori, non riesce a frequentare l’istituto tecnico per motivi di salute, per cui dovette da autodidatta provvedere alla propria istruzione, leggendo i maggiori autori italiani e stranieri e i più convincenti filosofi moderni, incominciando anche a prendere lezioni di musica, progettando una sua carriera di baritono. Dopo la prima guerra mondiale, combattuta anche da lui come ufficiale di fanteria, rinuncia definitivamente alle ambizioni sceniche e si dedica totalmente al lavoro letterario. Coltiva prioritariamente la poesia e nel 1919 scrive la sua prima poesia, che è già un capolavoro, per la sua desolata visione del mondo: “Meriggiare pallido e assorto”, in cui emerge una originale struttura organizzativa dei versi, che, pur rimanendo legata a simmetrie classiche, produce una incantevole sinfonia musicale che non lascia alcuna pausa disarmonica, ma fluisce con un tambureggiare travolgente di ritmi inediti, mai conosciuti prima. Nel 1922 si reca a Torino, dove si lega di amicizia a Solmi, Debenedetti, Gobetti, collaborando con “Tempo Presente”, ”Rivoluzione Liberale” e al gobettiano “Baretti”, che gli pubblica nel 1925 ”Ossi di seppia”, accolto come grande voce di un vero poeta, abile nell’essere riuscito ad innestare sul vasto repertorio delle strutture classiche, arpeggi consonantici e metriche profondamente collegate con note di gusto iterativo e scontato, poderose vibrazioni assonanzate e con un rinnovato vigore versificatorio, idoneo ad avvolgere in un’orchestrata e travolgente musicalità la sua condizione interiore di uomo e di poeta che discioglie nella parola la triste meraviglia dell’uomo isolato da un alto perimetro di muro, che gli impedisce di immaginare altre realtà o di oltrepassarlo, per accostarsi visivamente al magma impenetrabile di un mondo diverso, sigillato ontologicamente nel guscio del mistero che acceca l’umanità, sia per la declinazione filosofica di una concezione negativa e inutile dell’esistenza, che per la creazione di versi supremi ed efficacissimi, per tradurre in agile comunicazione verbale e poetica una tematica di difficile fruizione, incarnata in un agile gioco di metafore, come il nudo osso di seppia, o “il muro torto” o la dolorosa attesa del “varco” che, nel buio della sua emarginazione gnoseologica, rischiari la cecità della vita umana. L’ammirazione e la stima suscitata negli ambienti culturali più accreditati, facilitano l’assunzione di un impiego a Firenze presso la casa editrice Bemporad, e nel 1929, dove rimarrà per vent’anni, viene chiamato alla direzione del Gabinetto Viesseux, da cui sarà allontanato nel 1938, per essersi rifiutato di aderire all’iscrizione del partito nazionale fascista. Perciò, per sopravvivere, è costretto alla collaborazione di giornali e riviste per pochi soldi. Dopo la pubblicazione de “Le occasioni”, nel 1939, riesce ad entrare nel comitato redazionale di Solaria, Nel 1944, dopo la liberazione di Firenze dalle truppe antifasciste e naziste, aderisce al Partito d’Azione, ma presto se ne stacca a causa della repulsione della politica, ritenuta responsabile di sanguinose divisioni sociali, per l’egoistica conquista e gestione assoluta del potere.
Sempre indeciso sull’indirizzo da dare alla propria vita “pratica”, il poeta arriva fino ai 30 anni senza un lavoro fisso; nel 1927 finalmente venne assunto come redattore presso la casa editrice fiorentina Bemporad. Dovette quindi trasferirsi a Firenze, dove nel 1929 venne nominato direttore della Biblioteca del Gabinetto Vieusseux fino al 1938, quando fu allontanato dall’incarico per il rfiuto di aderire al regime dittatoriale, come già spiegato.
Questi anni sono caratterizzati da una straordinaria intensità di rapporti umani e culturali. In questo periodo si situa anche l’inizio del rapporto affettivo con Drusilla Danzi, che sarebbe divenuta ben presto la compagna e poi la moglie di Montale.
Dopo la Liberazione, Montale partecipò (per gli affari culturali) al Comitato di liberazione nazionale e aderì, ma per poco, al Partito d’Azione (unica e breve partecipazione attiva alla vita politica).
Nel 1948 si trasferisce a Milano, dove lavora come redattore del “Corriere della Sera”; l’attività giornalistica prima, poi come redattore della pagina letteraria, continuando quasi fino alla morte, sopraggiunta nel 1981. Nel 1950 esce il suo terzo volume di versi “La bufera e altro”
Gli ultimi anni sono prodighi di riconoscimenti nazionali: nel 1961 riceve la laurea in Lettere “honoris causa” dall’Università di Roma e nel 1962 dall’Università di Milano, la nomina a senatore a vita nel 1967 e altri riconoscimenti internazionali fra tutti, il premio Nobel assegnatogli nel 1975. Il Premio a Montale, suscitò aspre polemiche animate dai sostenitori della poesia di Montale, i quali presero di mira Salvatore Quasimodo (Nobel nel 1957, non gradito dai detrattori personali del poeta siciliano, accusato di provincialismo), preferendo l’assegnazione ad Ungaretti, mentre giudicarono tardivo l’importantissimo riconoscimento al poeta genovese, già stimatissimo a livello internazionale. Qualche voce di critico, fuori da riferimenti tematici e stilistici, riconobbe la superiorità assoluta della poesia di Montale, solo perché il poeta, come redattore culturale del più letto e autorevole quotidiano italiano, avrebbe potuto garantirgli una maggiore diffusione e un più vasto apprezzamento delle sue opere, talvolta mediocri. Ne nacque una schermaglia mediatica e epistolare che si attutì, ma non sedò le polemiche ancora aleggianti. Al doloroso sentimentalismo meridionalistico e intimistico del poeta siciliano, veniva contrapposta la superiorità dell’impegno universale del razionalismo montaliano, continuamente tormentato da un immedicabile male di vivere universale, che coinvolgeva essere animati e inanimati, destinati ad essere logorati dall’inesorabile fluire del tempo, giustiziere impietoso di illusioni, di anelate certezze e del disfacimento dell’armonia sprigionantesi in molti aspetti del mondo vegetale e animale, ingredienti eterni di parametrazione del disorientamento, delle insoluti incertezze del sentimento del vuoto e del nulla, in cui gradualmente affondava ogni terrestre creatura, nella vana attesa di un qualche squarcio baluginante che potesse giustificare la “divina indifferenza” per il cieco e disperato destino del mondo e poterne percepire un frammento di comprensione e giustificazione dell’insignificante storia dell’umanità.
LE OPERE
L’itinerario poetico di Montale è segnato da un’evoluzione che dal sublime della prima stagione, in cui il poeta registra la condizione umana prigioniera dell’immersione nella bellezza del creato, alla seconda e terza fase, in cui all’emersione nella memoria di figure femminili di immensa grazia, suscitatrici di una malinconica gioia di averle accanto nella dolorosa solitudine della propria esistenza, alle disumane stragi e devastazione di ogni valore positivo travolti dalla bufera della guerra e dalla ferocia delle dittature che avevano soffocato ogni respiro vitale dell’uomo e sgozzato ogni filamento umanitario nella desertificazione del cuore umano dilaniato dai bombardamenti e dai roghi umani del lager, giunge nelle raccolte dell’ ultima fase creativa all’abbassamento comico-prosastico, e talvolta anche cinico e totalmente vuoto, particolarmente quando osserva che “la storia è maestra di niente e, quando in “Satura”, all’indecifrabile ospite della sua vita, non ha da offrire più magistrali e sublimi schegge armoniose di certezze poetiche e razionali, ma solo “storte sillabe”, cioè parole prive di alcun significato, perché non è riuscito a “varcare la muraglia” che gli ha impedito di percepire ogni lemure di conoscenza.
Con una schematizzazione estrema possiamo individuare il tema fondamentale della poesia dell’autore di Clizia nell’insanabile crisi del rapporto fra l’uomo contemporaneo e il reale effimero e abbagliante di menzogna, falsità, illusioni e inganni metafisici, stroncando crudelmente l’ansia lacerante della creatura umana, sempre in inutile attesa del segnale che” il mondo oltre guardi”. In tale condizione di precarietà conoscitiva, Montale, con tonalità meno romantiche, prosegue sul sentiero cieco leopardiano, con cui si mescolano inconsciamente le teorie filosofiche preminenti in Europa, banditrici dell’insignificanza e della inutilità dell’esistenza, l’aridità di affetti e il nulla, che, tuttavia, non si dissolve totalmente, ma lascia sommersa un sorso di resistenza nell’attesa illusoria che possa accadere “qualcosa di impreciso e di imprevisto” e rinverdisca il distorto e infranto ramoscello sventolato davanti agli occhi offuscati.
Il disagio, il “male di vivere”, è dunque il filo rosso che unisce, pur attraverso varietà di modi, toni, situazioni poetiche, la prima stagione, che ha inizio con la raccolta “Ossi di seppia”, all’ultima stagione.
LA POETICA
La poesia di Montale nasce da una lucida disperazione esistenziale, nata da una concezione della vita come tragico esilio, invulnerabile mistero, condanna alla solitudine in un paesaggio desolato di ascendenza eliotiana, una impenetrabile incomunicabilità, dove le cose si raggrumano nella rassegnata fissità a popolare e vivere in una ragnatela di incertezza, in attesa della morte come traguardo di scomparsa nel nulla e di annientamento dell’essere.Ogni sforzo per evadere dal vicolo chiuso dell’io si rivela vano e anche la poesia si scopre come solitaria esperienza senza alcun orizzonte di gioia. Nella storia della nostra letteratura tale poetica del negativismo esistenziale evidenzia un tormento di emblematica impotenza dell’intellettuale moderno di fronte agli enigmi della natura e all’indecifrabilità razionale della storia. Unica scelta alternativa dell’angoscia esistenziale viene indicata da Montale nella “divina indifferenza della statua sonnolente nella calura del meriggio, o della nuvola che veleggia euforica nella rotta del cielo azzurro, sospinto da un lieve vento che la sospinge lontano dal grido del fallimento e dell’affondamento dell’uomo negli ingannevoli intrighi della natura, o del falco che si allontana dal cimitero della sconfitta umana, in cerca di altri approdi più appaganti della sua famelicità. Al poeta non rimane che essere indifferente alla vita, solo se riuscirà a distruggere le radici stesse della poesia, che lo sciolgano dall’ostinata e segreta adesione al destino crudele delle altre creature., a cui non può che contrapporre la filosofia delle inaspettate “occasioni” della vita che aprano varchi alle illusioni e al sogno, devastati dalla spietatezza della ragione. Sono recuperi di serene memorie lontane, colloqui virtuali con i lemuri di creature morte, le immersioni nel collinare paesaggio ligure, quell’angolo delle “Cinque Terre, accarezzate dalle placide onde del mare azzurro e incontaminato, carezzevoli e sorridenti figure femminili, la ricomparsa ombra di un amuleto, che apra il mistero delle cose da raccontare l’ultima verità al poeta che lo interroga per scoprire una resina di certezza sotto il veli della componente elegiaca del canto, non come efficace effusione patetica, ma come amalgama della tastiera del dramma, attraverso un linguaggio che predilige un lessico scabro ed essenziale, privo di lusinghe melodiche e cromatiche, ma con una ritmica scansione priva di eloquenza e di rotondità, con l’invenzione di immagini nuove, vigorose e realistiche e dense di suggestine simbolica.
OSSI DI SEPPIA
La raccolta “Ossi di seppia” comprende testi elaborati tra il 1920 e il 1925 (con la sola eccezione di “Meriggiare pallido e assorto”, che, come già detto, risale al 1916), in parte già apparsi in rivista.
Questa la struttura della raccolta: fra la poesia di apertura (In Limine, “sulla soglia”, in latino) e quella di chiusura (Riviere) si collocano quattro sezioni intitolate Movimenti (tredici componimenti), ”Ossi di seppia” ( ventidue), “Mediterraneo” (un poemetto in nove parti), “Meriggi” e “Ombre” (quindici componimenti).
In Ossi di seppia Montale evidenzia gli strumenti lirici di una poesia antieloquente e dal contenuto di elementi espressi con una visione negativa dell’esistenza: il poeta non ha nessuna verità o certezza da rivelare, ma si limita a registrare la sua profonda angoscia di oscillare nel vuoto di un mondo disarmonico, dominato dal “male di vivere”, appunto, che trova espressione in celebri metafore, quali camminare lungo un muro ”che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia”, essere imprigionati in una rete, essere legati da una catena; talvolta si intravede una possibilità di salvezza. Ma è una possibilità suggerita, vaga, più una percezione inconscia e indefinibile che, per certi versi, ma con le ben chiare differenze, ma in cui per associazione virtuali, potrebbe essere apparentato con l”Infinito” di Leopardi. Montale non vuole e non può darci la formula risolutiva; nessuna certezza positiva, ma solo “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”, cioè l’indicazione della finitezza temporale dell’uomo e il male di vivere che il poeta, angosciato, non vorrebbe vivere.
Gli Ossi di seppia che danno il titolo alla raccolta, e cioè le conchiglie di certi molluschi, presenze inaridite e scheletriche, appaiono emblematici di questa poetica dello “scabro ed essenziale”.
I motivi che attraversano la raccolta sono : il paesaggio, l’amore, l’evasione, la fuga, l’impossibilità di approdare ad una qualche truciolo di certezza e verità cosmica.
Il linguaggio poetico rivela una realtà sbriciolata e sfuggente, ma risulta preciso, penetrante, razionalmente ritagliato, spolpato fino all’osso, con una simmetrica selezione verbale e lessicale, ad un elementare associazione di nudi elementi linguistici, forieri dell’immediatezza penetrante del messaggio. Ogni oggetto poetico è designato dalla parola con assoluta precisione, legato a un solo significato. Essenziale e non ridondante è lo strumento linguistico, e a tal fine Montale ricorre sia a termini tecnici che dialettali e aulici. La caratteristica preminente della lingua degli Ossi è l’asciuttezza lessicale: i vocaboli prescelti si presentano nell’opera una sola volta.
Notevole, secondo la totalità dei critici, fu il contributo di D’Annunzio nella strutturazione metrica, soprattutto per l’uso degli sdruccioli, la rima ipermetra, l’assonanza. La metrica degli Ossi non è una metrica rivoluzionaria. I metri tradizionali sono frequenti, settenari, novenari, endecasillabi. Gli Ossi risentono anche di altre molteplici letture, come La Divina Commedia e le rime petrose di Dante Alighieri. Da Pascoli, Montale eredita non pochi modelli metrici e lessicali e motivi, quali la presenza dei morti e l’ostilità della natura. Ma ben scandite risultano nella poesia montaliana le tracce dei simbolisti francesi e soprattutto di Verlaine.
Anche nella seconda raccolta, “Le Occasioni”(pubblicata nel 1939) permane il motivo fondamentale della “disarmonia” e del dolore esistenziale, ma cambiano alcuni elementi: il paesaggio non solo non è più ligure, ma toscano (il poeta si è trasferito nel frattempo a Firenze).
Se negli Ossi il poeta dialogava solo con il mare (tema principale della prima raccolta) o con un generico Tu, ora cerca interlocutori reali, concreti (ma per lo più fisicamente assenti); l’interlocutrice prediletta è una figura femminile.
Nell’opera di Montale la prima fase è negativa e distruttiva: egli non ritrova un oggetto nella cui realtà possa aver fiducia. La seconda fase è relativamente positiva.
Gli Ossi esprimono la consapevolezza del “male di vivere”, mentre nelle Occasioni domina la ricerca di ciò che può costituire un’eccezione alla negatività, all’assurdo del reale: la ricerca insomma del “fantasma che ti salva”, che è qui un “fantasma” femminile, quello di Clizia, una sensibile e luminosa Beatrice, che il poeta amò profondamente e fu ispiratrice di importanti sue poesie, conforto salvifico di anni difficili per il poeta, che nel 1938 tornò in Inghilterra a causa delle leggi antisemitiche, introdotte anche in Italia da Mussolini, per aggraziarsi le simpatie dell’alleato tedesco. Il poeta, partito da posizioni di assoluta negatività esistenziale, si appiglia alla graziosa dolcezza della figura e l’eleganza comportamentale, che diventa un appiglio di certezza e di positività nella vita e nella poesia montaliana, che, in tanti componimenti, addolcisce l’asprezza
La valenza simbolica degli oggetti si accentua e si assolutizza nella compostezza e sicurezza del pellegrinaggio interiore del poeta, che la considera il suo “visiting angel”, che improvvisamente appare nella memoria di un dolce e sereno breve tempo trascorso insieme. I versi ispirati dalla donna possono essere considerati testimonianze altissime di intensa nostalgia lirica, ma anche di recupero di momenti memoriali di divina trasparenza morale. Ma accanto a questo tema sublime e realisticamente revisionato, vengono arricchiti con più netta, anche più realistica, ma con lirica, mirando ad una solidità psicologica, da contrapporre alla precarietà e alle contraddizioni di una lacerante esistenza. Nascono da questa ansia le liriche più alte del volume, impegnate nella ricerca del recupero esistenziale: “Dora Markus”, “La casa dei doganieri”, “Notizia dell’Amiata”, componimenti in cui balenano “fantasmi di salvezza”, figure di donne amate, paesaggi disegnati nello spazio azzurro, come librati su trasparenti veli nuvolari da favola, reminiscenze dell’idillio sereno, per il velo magico che insiste etereo sullo stato d’animo velato di amarezza e di pena. Perciò le figure femminili che sono convocati nella raccolta, dietro le serene apparenze, celano un’ansia tormentosa: Dora Markus cerca scampo alle avanzanti e laceranti inquietudini del presente in un amuleto: Liuba, di origine ebrea, resiste alla persecuzioni della sua famiglia, portando con sé, il “gatto del focolare, come amuleto, ma è sempre prigioniera della bruciante solitudine in una fase cieca e tempestosa. I gorghi dell’esistenza hanno inghiottito la donna de “La casa dei doganieri” e consuma i giorni atroci nella inesorabile corrosione del tempo tra le vecchie mura della casa che sorge solitaria a strapiombo sul mare, dove lei e il poeta si abbandonarono una sera alla chimera della gioia e alla felicità. La seconda raccolta ricorda le fasi drammatiche della storia autobiografica risonante di elegia, in uno stile elegiaco, come respiro sempre ansimante di immanente e inconsolabile dolore. Successivamente, partita Clizia per sempre, ma mai eclissata nel ricordo, è la poetessa Maria Luisa Spaziani ad entrare nella vita di Montale, che egli affettuosamente chiama Volpe. In effetti, la poetessa rappresenta il contrario di Clizia, in quanto donna più sensuale e concreta e influì sul temperamento timido e scontroso di Montale, facendogli assaporare le gioie del corpo. Ma è Drusilla Danzi, il più duraturo amore del poeta. Conosciuta in una biblioteca svizzera, continuò ad amarla tacitamente, riconoscendone l’importanza che la piccola donna “Mosca” ebbe per il poeta sempre incerto e nella vecchiaia zoppicante, con versi di una rara capacità comunicativa, che innalzano la piccola donna a prezioso strumento di vera illuminazione razionale, in quanto le riconosce che le pupille vere, con cui guardava la profonda verità delle cose, anche se offuscate da una noiosa miopia erano le sue, A Drusilla, Montale dedica i XIII componimenti di “Xenia”, che nell’umiltà e nella devozione totale del suo amore, viene innalzata dal poeta a nobilissima figura di donna innamorata e sempre fedele compagna anche nelle difficoltà e verso cui il poeta esprime una dolce gratitudine.
Nella terza raccolta: “La Bufera e altro”(1956) si riflette la condizione storica esterna, scandita nella nuova produzione poetica che si va facendo sempre più plumbea: il regime dittatoriale si è inasprito e all’orizzonte si addensano minacciose nuvole di guerra, le stesse che dominano la terza raccolta.
A differenza degli Ossi e delle Occasioni, La bufera e altro appare una raccolta non unitaria ma varia per tempi di composizione, temi e intonazione poetica.
Il primo nucleo di versi più unitario del primo è il gruppo di componimenti di Finisterre, quindici poesie fortemente influenzate dalla congiuntura bellica e pubblicate a Lugano nel 1943. Sono componimenti, in cui si intrecciano temi della sua critica vicenda esistenziale e quelli della tragedia della guerra e dall’opacità dei giorni del poeta, infarciti di crudele pessimismo, in cui tambureggiano nella mente le torture e i lamenti di una umanità, infilzata dalle bombe e dalle stragi come mansueti agnelli brutalmente sacrificate. Non c’è in questo volume alcuna presa di posizione politica e civile, inconciliabile con il suo pessimismo, ma risuona un incoercibile afflato di umana partecipazione all’angoscia delle vittime, la sua nobilissima moralità che ha orrore di ogni catastrofe bellica e di ogni logica partitica, da tempo rifiutata con disprezzo per le lotte intestine tra i partiti, innalzando barriere tra “uomini di chiesa o d’officina”, una eloquente metafora della visione divisoria delle contrapposte ideologie, tese a trasformare le creature umane in nemici, pronti ad uccidere i fratelli, come i due fratelli, vittima e carnefice, che dissero “andiamo ai campi” che segnò l’avvio di una fraterna guerra infinita che quotidianamente continua a degenerare e ad operare come una purga inarrestabile senza un perché. Montale costruisce un linguaggio che, a differenza delle prove precedenti si scioglie in una misurata frequenza di nodi simbolici e una fitta tessitura di richiami analogici, sfociati in una potente discorsività efficace ed incisiva, ma senza l’eliminazione totale di oscure e indecifrabili asimmetricità ermetiche, che successivamente lo stesso Montale ha chiarito ai critici. Per la prima volta la storia entra con tragica violenza nella poesia montaliana: la seconda guerra mondiale diventa cupo sottofondo delle liriche di Finisterre. La guerra non provoca una nuova visione della realtà da parte del poeta, ma semplicemente conferma e accentua il rapporto critico e disarmonico con la realtà, concepita come “assurda, irrazionale e non interpretabile”. Il tema dei morti, di parziale ascendenza pascoliana, ha grande spazio nella raccolta.
L’attenzione poetica di Montale rimane dunque legata saldamente alla permanente condizione umana, prima e più che agli eventi storici. L’ispiratrice delle poesie di Finisterre è ancora Clizia, che riprende e accentua la sua connotazione metafisica orientata in senso religioso (si è detta ”Cristofora”, “portatrice di Cristo”, cioè colei che si fa mediatrice tra terra e cielo).
Nel dopoguerra compare un’altra figura femminile, assai diversa, che Montale stesso definisce ”molto terrestre” e immanente: è la Volpe, nella quale dobbiamo identificare la poetessa Maria Luisa Spaziani (con cui Montale ebbe una relazione). In lei non è più riconoscibile alcuna prospettiva di salvezza: la donna è piuttosto una sorta di “antibeatrice”, che affievolisce la iniziale ossessione di etica purezza.
Da “Satura” a “Quaderni di quattro anni”
La produzione degli ultimi decenni
SATURA—QUADERNO DI QUATTRO ANNI—DIARIO DEL ’71 E DEL ‘72
Nel 1971, dopo 15 anni, inspiegabili, di silenzio, Montale pubblicò un quarto volume di versi, intitolato “Satura”, composto di vari argomenti. Il termine proviene dal latino arcaico “Lanx satura”strutturato in 4 sezioni:Xenia I-Xenia 2(un piccolo canzoniere d’amore per la moglie morta) e Satura I e Satura II. Le prime due sezioni sono composti da versi brevi, dedicati alla moglie morta, individuata con il termine Xenia, altra parola latina che significa “Dono per gli ospiti” che si offrono agli ospiti quando lasciavano la casa”, quasi a sottolineare il vero amore che dal 1936 legava la donna al poeta, sposata solo nel 1963 per accontentare il desiderio della compagna esemplare di una vita, ritenuta come ospite prezioso e insostituibile nella stanza della sua vita angosciata di poeta, sempre pronta e attenta a sostenerlo nei suoi vacillamenti fisici e interiori di anziano poeta spesso distratto sulla scena del mondo che Lei guidava per non farlo inciampare, anche se le sue pupille cieche erano più penetranti delle sue, logorate sui libri) Uno dei componimenti si intitola “Ho sceso conte milioni di scale dandoti il braccio”una delle più belle liriche d’amore mondiali, in cui il poeta, con dolcezza e umiltà sentimentale e linguistica, innalza a livelli immortali l’insuperabile sentimento per una rifondazione della famiglia e per indicare il vero senso della vita.
Gli anni sessanta e settanta, costituiscono lo sfondo della seconda stagione poetica montaliana.
Le poesie delle altre sezioni sono impregnate di acre tono satirico verso una società neocapitalistica, in cui si avvicendano contraddittorie e squallide mode culturali ed ideologiche, antesignane dei coevi anni del terrorismo e del tramonto dei più autentici valori della vita, contrapposti ai temi dell’affetto coniugale, con un linguaggio semplice, privo di cromature o “storture letterarie, in cui alcuni critici vollero individuare i segni inequivocabili della decadenza senile.
In realtà, anche con le raccolte successive, come “Quaderno di quattro anni” e “Diario del ’71 ve del’72, il poeta evidenzia più marcatamente le straordinarie risorse tecnico-stilistiche dii Montale che mostra un occhio aperto sotto le apparenze della prosasticità di una diversa società avviata a dissacrare, nel più anemico squallore dell’opaca e cieca vita privata, il laccato segreto della mascherata sociale. La nuova lingua è usata dal poeta è una fresca lingua, come strumento idoneo ad esprimere la progressiva desertificazione dell’io e la consapevole disperazione di chi ha consumato totalmente il divorzio dal proprio tempo storico, Montale fu anche un raffinato prosatore, eccellente saggistica e scopritore di talenti, memorialista, giornalista e acuto scopritore di talenti nel volume “La farfalla di Dinard” e “Auto da fè”, dove espresse il suo limpido moralismo la demistificazione dei feticci della civiltà tecnologica e l’asservimento dell’uomo alla cultura dei disvalori della società industriale. Egli fu anche un esperto traduttore dei poeti stranieri e, soprattutto meritorio nella scoperta e nel lancio di grandi scrittori come Italo Svevo, suscitando nel 1924 “Il Caso Svevo”, già ignorato o stroncato dalla critica e, tra gi altri, il poeta siciliano, Barone Lucio Piccolo di Calanovella, cugino dell’autore de “Il Gattopardo”, Tomasi di Lampedusa che tra le pareti di Villa Piccolo scrisse gran parte del suo capolavoro e diverse pagine nel Palazzo signorile della stagione estiva……..
Dopo la seconda guerra mondiale e i primi difficili tempi della ricostruzione, lo sviluppo capitalistico e il progresso tecnologico danno vita a una società di massa, a cui Montale guarda con un distacco aristocratico e nostalgico.
In questa crisi ideologica, il poeta, nel rimpianto dei vecchi valori che appaiono ormai irrimediabilmente perduti, rivolge alla sottocultura dominante uno sguardo scettico.
Il mondo che incontriamo in Satura, è ormai ridotto a detriti, a scorie, e il negativo è ancor più forte in quanto ormai dilagante. Il titolo Satura, per ammissione dello stesso Montale, ha più significati:
allude alla vena satirica che percorre la raccolta; e allude pure al sintagma latino “satura lanx”, che stava a indicare prima “ un piatto pieno di cibi diversi”; e poi anche un genere letterario caratterizzato dalla varietà di metri e di temi.
Delle quattro sezioni che comprendono la raccolta (Xenia I. Xenia II, Satura I, Satura II), le prime due costituiscono un piccolo canzoniere scritto in occasione della morte della moglie.
Il poeta rende omaggio alla moglie: compagna affezionata e discreta, rimasta finora quasi completamente assente. Xenia è termine latino che indica i doni fatti a un ospite nel momento in cui lascia la casa che lo ha ospitato.
Il mutamento linguistico
In questa nuova stagione poetica il linguaggio di Montale si trasforma, lo stile viene rovesciato: il lessico tende al basso, al prosastico, e può essere definito grosso modo un lessico quotidiano. Lo stile si fa quello della conversazione quotidiana, antilirico all’abbassamento tematico e lessicale si oppone una gabbia metrica e ritmica tradizionale, raffinata, molto sorvegliata, con una predilezione per le forme estreme; i versi tendono ad essere o molto brevi o superiori all’endecasillabo, le immagini brevi e affilati, capace di perforare e demolire gli inganni mistificatori dei potenti. Il destino dei poeti a volte sembra quasi quello di essere travisati. Passano una vita a esprimere, coi loro versi, i propri dubbi e sentimenti, e poi la storia li tramanda non per quello che credevano e sostenevano di essere, ma per tutt’altro. Così in parte è avvenuto anche con le poesie di Eugenio Montale. Lo scrittore genovese è stato uno dei più grandi poeti della letteratura italiana del Novecento. Tutta la sua poetica è contrassegnata dall’incertezza, dall’incapacità di cogliere il senso profondo dell’esistenza, che si intuisce appena ma sfugge di continuo. È, insomma, un poeta del dubbio, contrapposto alle certezze che invece mettevano in campo, poco prima di lui, autori come Gabriele D’Annunzio Un punto fermo, suo malgrado Eppure, lui così dubbioso e incerto, è ormai divenuto l’unico punto fermo dei programmi scolastici di letteratura italiana. Montale negli ultimi anni è diventato il cardine dei programmi dell’ultimo anno delle scuole superiori. La cosa ha fatto sì che gli studenti all’esame ripetano incessantemente le solite quattro o cinque frasi imparate sul testo («linguaggio scarno ed essenziale» è un’espressione che ritorna con una frequenza da far tremare i polsi) senza riuscire a cogliere il senso delle parole del poeta genovese. Così, poco per volta, il messaggio di Montale muore, perso nello studio mnemonico che è quanto di più distante si possa pensare per una poesia che è invece da scoprire verso per verso, semplice nel linguaggio quanto poco intuitiva nel senso. E non è un caso che, quando la prova scritta di italiano alla maturità ha presentato una poesia non scelta tra le solite di Ossi di seppia, gli studenti siano rimasti fulminati dai versi di Montale. Perché – libero dal pesante fardello della parafrasi, delle figure retoriche e delle richieste dell’insegnante (che dovrebbero essere mezzi, e non fini) – è tornato a parlare in maniera potente ai giovani e più in generale alle persone dotate di una certa sensibilità. Per questo, ci piace qui riproporre alcune delle maggiori poesie del premio Nobel ligure, introducendole solo con qualche brevissima nota storica e stilistica e lasciando però spazio alle parole dello stesso Montale. Perché se ne possa gustare la musicalità e la profondità senza troppi preconcetti e tecnicismi
I limoni
da Ossi di seppia, 1925
di seppia è la principale delle raccolte poetiche di Montale, pubblicata per la prima volta ne Gli Ossi 1925, a neppure trent’anni di età. In questo libro l’uomo, come d’altronde la stessa poesia, è visto in maniera negativa. La sua esistenza è quasi quella di un relitto, visto che – come un osso di seppia – è abbandonato sulla terra, inaridito ed inutile. Le cose semplici
I limoni sono, qui, il simbolo dell’esistenza umana e della poesia montaliana. Una poesia che si rivolge verso le cose semplici (al contrario di quanto fanno i “poeti laureati”) e che cerca di cogliere il significato dell’esistenza, risultando però sconfitta. Questo significato infatti sfugge, lasciando una profonda tristezza solo in parte mitigata dal giallo festoso dei limoni. Per questo gli agrumi sono un ottimo esempio di cosa intendeva Montale per il correlativo oggettivo. Cioè un oggetto, o una situazione, che è in grado di simboleggiare, in un certo senso aprirci la strada verso una sensazione particolare. In più, qui si trovano anche riferimenti a Pascoli (quando parla delle piante dei poeti laureati) e a Leopardi (quando, nel finale, richiama Il Dialogo della Natura e di un Islandese).
Il testo della poesia
I limoni
Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi
fossi dove in pozzanghere
mezzo seccate agguantano i ragazzi
qualche sparuta anguilla:
le viuzze che seguono i ciglioni,
discendono tra i ciuffi delle canne
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.
Meglio se le gazzarre degli uccelli
si spengono inghiottite dall’azzurro:
più chiaro si ascolta il sussurro
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove,
e i sensi di quest’odore
che non sa staccarsi da terra
e piove in petto una dolcezza inquieta.
Qui delle divertite passioni
per miracolo tace la guerra,
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza
ed è l’odore dei limoni.
Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s’abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità.
Lo sguardo fruga d’intorno,
la mente indaga accorda disunisce
nel profumo che dilaga
quando il giorno più languisce.
Sono i silenzi in cui si vede
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata Divinità
MaCultura. “Eugenio Montale, il grande Maestro della Poesia” di Carmelo Aliberti l’illusione manca e ci riporta il tempo
nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.
La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta
il tedio dell’inverno sulle case,
la luce si fa avara – amara l’anima.
Quando un giorno da un malchiuso portone
tra gli alberi di una corte
ci si mostrano i gialli dei limoni;
e il gelo dei cuore si sfa,
e in petto ci scrosciano
le loro canzoni
le trombe d’oro della solarità.
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
da Ossi di seppia, 1925
Ossi di seppia è divisa in varie sezioni, una delle quali, quella centrale, prende proprio lo stesso titolo dell’intera opera. Ad aprire questa sezione è il componimento che forse più di tutti chiarisce gli ideali poetici di Montale e il ruolo che egli dà alla poesia.«Qualche storta sillaba»: Secondo il poeta, le liriche non possono chiarire la realtà, né svelarne il segreto. L’unica cosa che possono fare è dare «qualche storta sillaba e secca come un ramo». La chiusa è, infatti, celebre: i (nuovi) poeti possono dire solo una cosa, ciò che non sono, ciò che non vogliono.Eppure, per sottolineare l’impotenza della poesia, Montale sceglie una via quasi classica. I suoi versi sono di misura diversa, certo, ma si chiudono con delle rime (lo schema è ABBA, CDDC, EFEF). C’è la forte consonanza della lettera “R”, vi sono anafore, enjambement ed altro ancora. E dunque: la poesia userà pure “storte sillabe”, ma storte solo fino a un certo punto.
Il testo della poesia
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
perduto in mezzo a un polveroso prato.
Ah l’uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l’ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!
Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
Meriggiare pallido e assorto
da Ossi di seppia, 1925
Come anticipato, Montale fu il principale promotore, in Italia, del correlativo oggettivo, cioè di quella tecnica poetica elaborata daT.S. Eliot secondo cui una certa emozione poteva essere provocata solo dalla presenza di determinati oggetti, così come un cavolo può esistere solo in presenza di terra ed acqua.Già il titolo della raccolta poetica, Ossi di seppia, era di per sé un correlativo oggettivo, ma in molti dei suoi componimenti questa tecnica ricorre in abbondanza. Come in Meriggiare pallido e assorto, in assoluto una delle sue poesie più famose, soprattutto per la conclusione che evoca i «cocci aguzzi di bottiglia”. La poesia venne scritta probabilmente nel 1916, in un caldo pomeriggio d’estate. Ed evoca quel tipico paesaggio ligure, brullo, secco, che ben si adattava a quello che Montale intendeva comunicare. Anche qui, tra l’altro, si sente di nuovo l’eco di Leopardi, in particolare delle pagine dello Zibaldone che sono ricordate come il Giardino del dolore.
Il testo della poesia
Meriggiare pallido e assorto
Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
Nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
a sommo di minuscole biche.
Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.
E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
Spesso il male di vivere ho incontrato
da Ossi di seppia, 1925
La più pessimistica delle poesie montaliane è “Spesso il male di vivere ho incontrato”, che, come molte di quelle contenute in Ossi di seppia, trae il suo titolo dal primo verso. Qui in due sole strofe il poeta riesce infatti a sintetizzare la sua concezione tragica della vita, dominata dal male di vivere. Il sollievo dal dolore Questo male ci attanaglia. L’unico modo per trovare una parziale via di scampo, l’unico momentaneo sollievo arriva nella divina Indifferenza, che scaturisce dalla visione di qualcosa (il falco, la nuvola, la statua) che per un momento ci sottrae al dolore. Probabilmente la lirica fu scritta nel 1924, ma gli echi che solleva sono molto antichi. A parte l’amato Leopardi, a cui si deve attribuire la prima espressione del “male di vivere”, qui è infatti forte l’influsso di Democrito ed Epicuro. L’imperturbabilità tanto agognata deriva proprio da quella filosofia, dalla saggezza degli antichi.
Il testo della poesia
Spesso il male di vivere ho incontrato
Spesso il male di vivere ho incontrato
era il rivo strozzato che gorgoglia
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.
Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
da Xenia II, 1967
Il pessimismo e le immagini scelte da Montale non sempre lo rendono un autore che piace ai più giovani. Ottimisti – o comunque pessimisti non nel senso filosofico del poeta – e legati a un immaginario ormai distante da quello naturalistico, gli studenti tendono a volte a farsi poco coinvolgere dalle liriche di Montale, così legate a un senso di dolore e inadeguatezza che non è proprio degli ardori giovanili. La perdita della moglie. Fa eccezione, però, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, poesia della vecchiaia con cui, in toni sommessi, Montale cercava di descrivere il dolore per la perdita dell’amata moglie Drusilla Tanzi. Una donna molto miope, che però sapeva vedere più in là dello stesso poeta. La poesia, d’altro canto, è semplice, quasi in prosa, ed usa un linguaggio colloquiale. Una scelta che si contrappone all’inizio iperbolico («un milione di scale»), ma che riesce a scatenare anche nel cuore del lettore moderno un senso di grande compassione.
Il testo della poesia
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.
IL DISCORSO DI EUGENIO MONTALE
AL PREMIO NOBEL 1975
II premio Nobel è giunto al suo settantacinquesimo turno, se non sono male informato. E se molti sono gli scienziati e gli scrittori che hanno meritato questo prestigioso riconoscimento, assai minore è il numero dei superstiti che vivono e lavorano ancora. Alcuni di essi sono presenti qui e ad essi va il mio saluto e il mio augurio. Secondo opinioni assai diffuse, opera di aruspici non sempre attendibili, in questo anno o negli anni che possono dirsi imminenti il mondo intero (o almeno quella parte del mondo che può dirsi civilizzata) conoscerebbe una svolta storica di proporzioni colossali. Non si tratta ovviamente di una svolta escatologica, della fine dell’uomo stesso, ma dell’avvento di una nuova armonia sociale di cui esistono presentimenti solo nei vasti domini dell’Utopia. Alla scadenza dell’evento il premio Nobel sarà centenario e solo allora potrà farsi un completo bilancio di quanto la Fondazione Nobel e il connesso Premio abbiano contribuito al formarsi di un nuovo sistema di vita comunitaria, sia esso quello de Benessere o del Malessere universale, ma di tale portata da mettere fine, almeno per molti secoli, alla multisecolare diatriba sul significato della vita. Intendo riferirmi alla vita dell’uomo e non alla apparizione degli aminoacidi che risale a qualche miliardo d’anni, sostanze che hanno reso possibili l’apparizione dell’uomo e forse già ne contenevano il progetto. E in questo caso come è lungo il passo del deus absconditus!
Ma non intendo divagare e mi chiedo se è giustificata la convinzione che lo statuto del premio Nobel sottende; e cioè che le scienze, non tutte sullo stesso piano, e le opere letterarie abbiano contribuito a diffondere o a difendere nuovi valori in senso ampio «umanistici». La risposta è certamente positiva. Sarebbe lungo l’elenco dei nomi di coloro che avendo dato qualcosa all’umanità hanno ottenuto l’ambito riconoscimento del premio Nobel. Ma infinitamente più lungo e praticamente impossibile a identificarsi la legione, l’esercito di coloro che lavorano per l’umanità in infiniti modi anche senza rendersene conto e che non aspirano mai ad alcun possibile premio perché non hanno scritto opere, atti e comunicazioni accademiche e mai hanno pensato di «far gemere i torchi» come dice un diffuso luogo comune. Esiste certamente un esercito di anime pure, immacolate, e questo è l’ostacolo (certo insufficiente) al diffondersi di quello spirito utilitario che in varie gamme si spinge fino alla corruzione, al delitto e ad ogni forma di violenza e di intolleranza. Gli accademici di Stoccolma hanno detto più volte no all’intolleranza, al fanatismo crudele, e a quello spirito persecutorio che anima spesso i forti contro i deboli, gli oppressori contro gli oppressi. Ciò riguarda particolarmente la scelta delle opere letterarie, opere che talvolta possono essere micidiali, ma non mai come quella bomba atomica che è il frutto più maturo dell’eterno albero del male.Non insisto su questo tasto perché non sono né filosofo, né sociologo, né moralista.
Ho scritto poesie e per queste sono stato premiato, ma sono stato anche bibliotecario, traduttore, critico letterario e musicale e persine disoccupato per riconosciuta insufficienza di fedeltà a un regime che non potevo amare. Pochi giorni orsono è venuta a trovarmi una giornalista straniera e mi ha chiesto come io ho distribuito tante attività così diverse. Tante ore alla poesia, tante alle traduzioni, tante all’attività impiegatizia e tante alla vita. Ho cercato di spiegarle che non si può pianificare una vita come si fa con un progetto industriale. Nel mondo c’è un largo spazio per l’inutile, e anzi uno dei pericoli del nostro tempo è quella mercificazione dell’inutile alla quale sono sensibili particolarmente i giovanissimi.
In ogni modo io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà. Ma non è il solo, essendo la poesia una produzione o una malattia assolutamente endemica e incurabile.
Sono qui perché ho scritto poesie: sei volumi, oltre innumerevoli traduzioni e saggi critici. Hanno detto che è una produzione scarsa, forse supponendo che il poeta sia un produttore di mercanzie e le macchine devono essere impiegate al massimo. Per fortuna la poesia non è una merce. Essa è una entità di cui si sa assai poco, tanto che due filosofi così diversi l’uno dall’altro come Croce, storicista idealista, e Gilson, cattolico, sono d’accordo nel ritenere impossibile una storia della poesia. Per mio conto, se considero la poesia come un oggetto ritengo ch’essa sia nata dalla necessità di aggiungere un suono vocale (che è la parola) al martellamento delle prime musiche tribali. Solo molto più tardi parola e musica poterono scriversi in qualche modo e differenziarsi. Appare la poesia scritta, ma la comune parentela con la musica si fa sentire. La poesia tende a schiudersi in forme architettoniche, sorgono i metri, le strofe, le cosiddette forme chiuse. Ancora nelle prime saghe nibelungiche e poi in quelle romanze, la vera materia della poesia è il suono. Ma non tarderà a sorgere con i poeti provenzali una poesia che si rivolge anche all’occhio. Lentamente la poesia si fa visiva perché dipinge immagini, ma è anche musicale: riunisce due arti in una. Naturalmente gli schemi formali erano larga parte della visibilità poetica. Dopo l’invenzione della stampa la poesia si fa verticale, non riempie del tutto lo spazio bianco, è ricca di «a capo» e di riprese. Anche certi vuoti hanno un valore. Ben diversa è la prosa che occupa tutto lo spazio e non dà indicazioni sulla sua pronunziabilità. E a questo punto gli schemi metrici possono essere strumento ideale per l’arte del narrare, cioè per il romanzo. È il caso di quello strumento narrativo che è l’ottava, forma che è già un fossile nel primo Ottocento malgrado la riuscita del Don Giovanni di Byron (poema rimasto interrotto a metà strada). Ma verso la fine dell’Ottocento le forme chiuse della poesia non soddisfano più né l’occhio né l’orecchio. Analoga osservazione può farsi per il Blank verse inglese e per l’endecasillabo sciolto italiano. E nel frattempo fa grandi passi la disgregazione del naturalismo ed è immediato il contraccolpo nell’arte pittorica. Così con un lungo processo, che sarebbe troppo lungo descrivere, si giunge alla conclusione che non si può riprodurre il vero, gli oggetti reali, creando così inutili dopponioni; ma si espongono in vitro, o anche al naturale, gli oggetti o le figure di cui Caravaggio o Rembrandt avrebbero presentato un facsimile, un capolavoro. Alla grande mostra di Venezia anni fa era esposto il ritratto di un mongoloide: era un argomento très dègoûtant, ma perché no? L’arte può giustificare tutto. Sennonché avvicinandosi ci si accorgeva che non di un ritratto si trattava, ma dell’infelice in carne ed ossa. L’esperimento fu poi interrotto manu militari, ma in sede strettamente teorica era pienamente giustificato. Già da anni critici che occupano cattedre universitarie predicavano la necessità assoluta della morte dell’arte, in attesa non si sa di quale palingenesi o resurrezione di cui non s’intravvedono i segni.
La vera poesia è simile a certi quadri di cui si ignora il proprietario e che solo qualche iniziato conosce. Comunque la poesia non vive solo nei libri o nelle antologie scolastiche. Il poeta ignora e spesso ignorerà sempre il suo vero destinatario. Faccio un piccolo esempio personale. Negli archivi dei giornali italiani si trovano necrologi di uomini tuttora viventi e operanti. Si chiamano coccodrilli. Pochi anni fa al Corriere della Sera io scopersi il mio coccodrillo firmato da Taulero Zulberti, critico, traduttore e poliglotta. Egli affermava che il grande poeta Majakovskij avendo letto una o più mie poesie tradotte in lingua russa avrebbe detto: «Ecco un poeta che mi piace. Vorrei poterlo leggere in italiano». L’episodio non è inverosimile. I miei primi versi cominciarono a circolare nel 1925 e Majakovskij (che viaggiò anche in America e altrove) morì suicida nel 1930.
Majakovskij era un poeta al pantografo, al megafono. Se ha pronunziate tali parole posso dire che quelle mie poesie avevano trovato, per vie distorte e imprevedibili, il loro destinatario.
Non si creda però che io abbia un’idea solipsistica della poesia. L’idea di scrivere per i cosiddetti happy few non è mai stata la mia. In realtà l’arte è sempre per tutti e per nessuno. Ma quel che resta imprevedibile è il suo vero destinatario. L’arte-spettacolo, l’arte di massa, l’arte che vuole produrre una sorta di massaggio fisico-psichico su un ipotetico fruitore ha dinanzi a sé infinite strade perché la popolazione del mondo è in continuo aumento. Ma il suo limite è il vuoto assoluto. Si può incorniciare ed esporre un paio di pantofole (io stesso ho visto così ridotte le mie), ma non si può esporre sotto vetro un paesaggio, un lago o qualsiasi grande spettacolo naturale. La poesia lirica ha certamente rotto le sue barriere. C’è poesia anche nella prosa, in tutta la grande prosa non meramente utilitaria o didascalica: esistono poeti che scrivono in prosa o almeno in più o meno apparente prosa; milioni di poeti scrivono versi che non hanno nessun rapporto con la poesia. Ma questo significa poco o nulla. Il mondo è in crescita, quale sarà il suo avvenire non può dirlo nessuno. Ma non è credibile che la cultura di massa per il suo carattere effimero e fatiscente non produca, per necessario contraccolpo, una cultura che sia anche argine e riflessione. Possiamo tutti collaborare a questo futuro. Ma la vita dell’uomo è breve e la vita del mondo può essere quasi infinitamente lunga.
[A voi, turba leggera,
Che d’ala passeggera
Trasvolate il mondo,
E d’un murmure soffio
L’ombreggiante verzura
Muovete dolcemente.
Io offro queste viole
Quei gigli e fior di campo,
E queste rose,
Queste vermiglie rose
Sì frescamente schiuse
E garofani insieme.
Col vostro dolce fiato
Trascorrete la piana
Ventilate questo nostro stare.