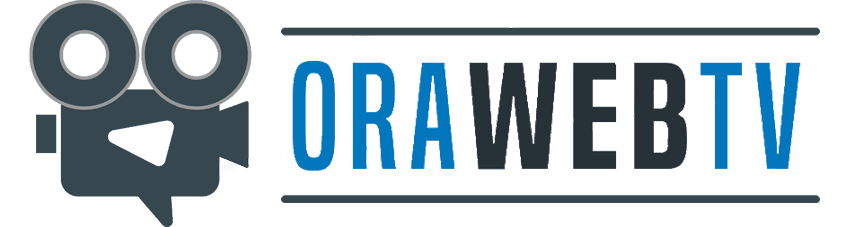Riceviamo dal Prof. Carmelo Aliberti e pubblichiamo integralmente il suo nuovissimo libro dedicato a Vincenzo Consolo. Una grande esclusiva della nostra Testata “OraWebTv” il testo scritto per Terzo Millennio da Aliberti sul grandissimo scrittore siciliano con prefazione della collega Francesca Romeo, giornalista e scrittrice. Buona lettura.
PREFAZIONE
di Francesca Romeo
“Traversare la Sicilia intera, visitare quelle città e quei paesi un tempo vitali per umanità e cultura, carichi dunque, ancora fino a pochi anni addietro, di volontà e di speranza (…)” scriveva Vincenzo Consolo in un articolo intitolato “Paesaggio metafisico di una follia pietrificata”. Ed è letteralmente con una traversata della Sicilia che inizia il viaggio del professore Carmelo Aliberti nell’universo mitopoietico di Consolo, fatto non solo di terra ma soprattutto di sangue e di anima. Sangue e anima che scorrono impetuosi impastandosi con la terra di ieri, di oggi, di domani. Caroselli di figure che si rincorrono in un teriomorfismo ancestrale. Luoghi che si sovrappongono. Anime che fuggono. Spiriti che restano. Esuli che ritornano. Aromi speziati di zolfatari, odori acri di sudore, colori, agrumi e “ombre misteriche, fantasmi innamorati scintillanti nel mattatoio delle zagare” come scrive Aliberti nelle primissime pagine. E lo fa in quel canto denominato “Il licantropo e la luna” in cui il saggista magistralmente ripone, in 165 versi di straripante bellezza, tutto lo splendore intrinseco di ciò che è il fascino e l’essenza del pensiero consoliano. Un saggio intenso, sibillino, impregnato di sostrati mitici e iconografie del reale, che diventa quasi un dialogo velato tra Aliberti e Consolo. Tra poeta e poeta. Tra scrittore e scrittore. Tra figli di una stessa Sicilia, nutrice e matrigna, amata e rimpianta, “pietrificata” ma anche viva, nel cui passato si muovono attualità sconcertanti e viaggiano innumerevoli “Ulisse” alla ricerca della propria perduta Itaca. Una Sicilia “ipotecata dalla letteratura, dal mito, dalla leggenda” come la definì Consolo in “L’idea della Sicilia”. Aliberti, con somma duttilità, riesce a sviscerare l’interiorità velata nelle pagine dello scrittore siciliano. Ne mette a fuoco i dettagli, i rumori, i pensieri, l’epochè di husserliana memoria, il dualismo ontologico e gnoseologico in cui la separazione e la trascendenza del mondo ideale rispetto al mondo sensibile implicano anche una separazione delle forme della conoscenza Ed è iniziando da “Nottetempo, casa per casa”, insignito del Premio Strega nel 1992, che Aliberti amalgama tutti gli ingredienti gravitanti nell’universo consoliano. In quella Cefalù degli anni Venti avvolta dai primordi del fascismo, pixellata da un ancestrale teriomorfismo, turbata da esotici esoterismi, convulsa dal “male catubbo”, il saggista scova i segni di “una apocalisse storica che rischia di essere ‘nuda crisi’, catastrofe senza rinnovamento, che diventa metafora per il presente” (pag. 19). Un criterio di verità che si manifesta attraverso antinomie che scavalcano il condizionato e danno luogo a premesse storiche in un ars combinatoria dalle sfumature escatologiche. Toccante l’analisi anamnestica delle due sorelle Lucia e Serafina, l’una preda di una “pazzia che prima ancora di essere assenza e distanza è urlo innaturale”, l’altra “col nome programmatico di chi non appartiene a questo mondo” (pag. 29). Entrambe figure immobili, pietrificate. Entrambe avvolte dall’incontro con la propria sofferenza. Iconografie del dolore che Consolo cesella e Aliberti estrapola nella potenza di una metamorfosi ovidiana, in cui il reale, generato dall’esperienza devastatrice, dà voce all’apoteosi della tragedia. Emerge il paradosso dell’incomunicabilità in quel rimando alla torre di Babele: simbolo del “caos, del disordine e della confusione”, principio dell’incomunicabilità, della finitezza umana. È il logos parola primigenia, concezione mitica, razionale, legge, struttura, armonia degli opposti. Consolo forgia parole, le incide sull’anima prima che sulla carta, le usa come bisturi per sviscerare non la psicanalisi dell’uomo, ma l’uomo dall’uomo e con esso tutta la cultura di un popolo, quello siciliano, con le sue glorie e le sue viltà, i suoi trionfi e le sue sconfitte, le sue contraddizioni eterne.
Da una dettagliata analisi narrativa a quella interpretativa della produzione consoliana, Aliberti attraverso una stesura colta di rimandi e citazioni, evoca una vertiginosa pluralità di status, di immagini, di sentimenti che convivono sotto diverse forme in un’anamnesi dell’essere e dell’esistenza che afferma e nega. E ancora “il destino d’ogni ulisside di oggi” come lo definiva Consolo stesso, il rapporto con la Sicilia, la memoria, il viaggio, l’emigrazione, le devastazioni, le stragi mafiose. Impossibile a questo punto per l’autore del saggio non ottemperare “Lo Spasimo di Palermo” (1998): “È il meno lineare dei libri di Consolo nell’ossessivo affollarsi di passato e presente, nella contrapposizione di storia e memoria, nel vano bisogno di confronto che il ricordo potrebbe offrire e che suscita, invece, un bruciante sentimento di patimento, di sofferenza, di spasimo appunto” scrive Aliberti. Un linguaggio scorrevole, profondo, espressivo quello del saggista che a tratti si palesa come un’opera nell’opera, con picchi aulici di vera poesia, come accade quando apre al lettore una finestra su “Catarsi”. Linguaggio che si fa cronachistico, netto, sciabolante, come quando descrive l’atto unico intitolato “Pio La Torre, orgoglio di Sicilia” (2009) e nel cui testo Aliberti individua “la fertile eredità lasciata da Consolo ai più giovani”. Un approccio indubbiamente caratteristico quello del saggista alle opere di Consolo in grado di generare armoniose perturbazioni emotive, di approfondire e chiarificare significati e significanti. Come il saggista ricorda, Consolo più volte affermò che ciò che maggiormente gli interessava era raccontare la storia, la Sicilia. Una storia filtrata però dalla lente dei vinti, cui lo scrittore siciliano dà voce. Particolare attenzione Aliberti pone all’ulissismo intellettuale di Consolo in cui il protagonista delle vicende omeriche e il suo viaggio diventano per l’autore metafora di ricerca su più dimensioni. La Sicilia come Itaca, sospirata meta ultima, “patria-matria” cui sempre anelare, ma che “può essere paragonata alla Troia incendiata di Omero, rappresenta anche l’incupirsi della visione consoliana, che coinvolge l’intera storia italiana” sottolinea Aliberti mentre si sofferma sul “negativismo storico” e la “necessità di testimoniare ”insieme al “silenzio narrativo dello scrittore”. In questo saggio l’autore migra tra i gli scritti di Consolo, respirandone i temi ricorrenti, i luoghi, le atmosfere di speranza e le unzioni deluse, le voci, le urla, le infamie morali, il senso nascosto delle cose. E, ancora, Aliberti apre scenari intonsi, esplora, scandaglia, interpreta, suggerisce. Un saggio in cui echeggiano tutti i tempi di Consolo, in cui gravitano tutti suoi personaggi come isole galleggianti degli Uros. Una corsa a ritroso. Un fuga verso l’infinito. Un varco che si apre al di là e al di qua della terra, del sangue, dell’anima. Un complesso in crescendo di concezioni ispirate ,devote, fondamentali, in cui il sensibile e l’intelligibile diventano punti essenziali del pensiero, delle parole. Quelle stesse parole che esistono e che Consolo definì essere “come biglie chiuse con un mistero dentro: bisogna aprirle”. Parole gravide di energia, di vibrazioni, che si manifestano in una travagliata maieutica del “dire”. Parole che Aliberti osserva, coltiva, raccoglie in una straordinaria attenta messe dell’universo consoliano: “ma solamente i poeti, ancora, posseggono l’oscuro segreto delle parole per dire, con la più alta dignità e più alta bellezza, della grande avventura dell’esistere, della vita” scrive Consolo.
dott. sa Francesca Romeo
(giornalista e scrittrice)
CAPITOLO 1
A VINCENZO CONSOLO
Poeta della storia
IL LICANTROPO E LA LUNA
Rime di Carmelo Aliberti.
Dedicate a Consolo, tra taglio saggistico e creatività melica di attica grazia
Critica in versi? E perché no! Carmelo Aliberti, docente di Italiano e Latino ha insegnato per un quarantennio nei Licei di Barcellona P.G. (Messina), dedicando un’intera vita, oltre che all’azione formativa dei giovani discenti, anche ad una intensa attività letteraria di diffusione e di promozione della Cultura in molti Comuni del messinese, in Italia e in Università straniere, dove è stato invitato, tra i relatori di vari Convegni su Tomizza, tradotto anche in croato, al Forum Tomizza di UMAGO, a quello sulla poesia italiana da Leopardi, a Quasimodo e Aliberti, in Francia, ancora sul problema delle frontiere negli autori europei (Francia), a quello recente su Poetica e Filosofia in Carlo Sgorlon, svoltosi all’Università di Udine, di cui sono in uscita gli Atti, a cura della Università organizzatrice.
È Cultore di Letteratura Italiana all’Università ed è stato insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte.
Le sue opere di saggistica letteraria e poesia sono state tradotte in 15 lingue. Ha fondato e cura la Rivista Internazionale di Letteratura TERZO MILLENNIO, diretta fino alla scomparsa dal Maestro Prof. Giorgio Barberi Squarotti, e ora dal prof. Jean Igor Ghidina, docente di Italianistica alla Blaise Pascal- Francia.
Dopo la recente “Letteratura e Società Italiana dal II Ottocento fino ai nostri giorni” in 6 volumi di circa 4000 pp. e il nuovo saggio su Michele Prisco, scelto da ARACNE, Editrice di Roma, ha pubblicato recentemente il romanzo “Briciole di un Sogno”. Le presenti “Rime dedicate a Consolo” sono edite dal Circolo Rhegium Julii di Reggio Calabria, di cui Aliberti è stato vincitore per la poesia inedita, che edita. Non è certo semplice essere valido sintetizzatore dell’anima isolana sonora e solare, favolosa e affabulante, tragica e favolista, terrigna e metafisica, orfica e orfana, polifonica e solitaria. Di questo, va dato invece totale merito all’Aliberti, e a questo suo “poemetto” il quale, con metafore scintillanti, epifanie semantiche improvvise insorgenze cromatiche e ossidriche combinatorie di segni, traccia storia e memoria del “suo oggetto” poetico (vale a dire lo scrittore Consolo per cui dimostra di avere ferma devozione), in contemporanea con una sorta di “autoritratto” per interposto “maestro”, con una desiderante trasfigurazione intellettuale e morale. Alla ripresa dell’operazione poetica, ma anche politico-culturale di Consolo (per rimandi o accenni, citazioni o allusioni), Aliberti affianca un tessuto di propria creatività, sorprendentemente sospesa tra taglio saggistico e melica voce, critica senz’altra attenuante e attica grazia. In filigrana, uno straordinario paesaggio isolano che sconfina con secoli di sangue, di separatezza, di luce e di lutto. Di nomi. Di luoghi. Di lacrime
CLAUDIO TOSCANI – Critico letterario
(da AVVENIRE)
CAPITOLO 2
IL LICANTROPO E LA LUNA
La teca verde dei Nebrodi
In cui fermentò il sangue e la speranza
della rorida ferita dell’aprile,
l’aorta frastagliata d’arenaria
con il santuario proteso ad inghirlandare
il seno della pomice e del cielo,
carrettieri, zolfatari, piscaturi,
femmine nere, picciotti disperati
fenici, greci, normanni e saraceni,
angioini pupari, santi banditi e verdurai,
ombre misteriche, fantasmi innamorati
scintillanti nel mattatoio delle zagare.
Licantropi che abbaiano alla luna
l’oro, le arance, il viola
distesi sui guanciali dell’azzurro
che tra scaglie palpitanti modula,
con le ombre metafisiche e i misteri,
“tra gli argini di malta e sabugina”,
una ferina incandescenza d’aria,
Militello, Capo d’Orlando, Barcellona,
Milazzo ubriaca di ciclamini,
Villa Piccolo, Pantalica, Milano,
Racalmuto, il Caos, Milano,
Sciascia, Lucio Piccolo, Nino Pino,
e dentro gli ipogei della tragedia,
Tu, con la bufera delle sillabe,
calde di onde, di suoni, di memoria,
prigioniero di Lunaria e del potere
s scandire nel diuturno esilio
i riti blasfemi dei baroni
reclusi in follie di possesso,
squarciati dall’Essere
e penzolanti al ramo dell’Avere.
Una lunga catena di amore e di odio,
di ferocia, di riscatti inesplosi, di sterminio.
A marzo nel tepore della notte
subliminata da mandorle e viole
dalle viscere infrante del Vulcano
brillano le luminarie a Salvatesta
risucchiate nel biviere di Alfarano
pronte a riesplodere sui lidi del Tirreno
nelle ferie d’agosto,
e rivoli di porpora ingrottati
straripano nel calice del Sole
a seminare eccidi sull’asfalto
per l’uva ,i pascoli, il sentiero,
per l’oro giallo, bianco e nero
Bronte, Mylae, Termini Imerese,
Fantina, Ragusa, Villafranca
Comiso, Melilli, Gibellina,
Mandrazzi nelle orge di vento della storia
con tetti e imposte mutilati
ospita nidi di ciaule e di gufi
che immobili negli anni attendono
l’eco di un piede umano
e poi lieti andarsene oltre le nubi,
consapevoli di aver atteso un’ombra invano.
Alla stazione nella notte stralunata
il proscritto vagola sui selciati ignoti
dove si frangono
i laceranti concerto dell’addio
dentro celesti cupole di libertà perdute,
mentre nell’anima straziata
vibra dentro piaghe violentate
la fragranza del pane dell’infanzia
e il licantropo squarcia le ansimanti ombre
-il fiato appeso al corno della luna-
con lo strozzato urlo dell’ucciso.
Ora il tempo inanella tra le dita
la necropoli dei vivi di Bafia
dove dentro le labbra spente delle mura
sfavillano incaute perle
di speranza in attesa
del precipizio dell’aurora
dalle vellose fessure delle Rocche
merlate sentinelle sull’abisso
tra Passo dei Lupi e Garamante.
Tu, ora emerso dai gorghi di Plumelia
con la fiaccola dentro l’alveo della mente
ti inoltri vacillando nel mio abbraccio
dentro le squillanti reliquie della storia
dove ancora ansimano nel cranio di pietra
gli echi mistici dei riti del Bosco
e mi sospinge con le tue creature
tra i lemuri superstiti del tempo
di questo nuovo secolo sospeso
alla ragnatela di ori ripugnanti
e mi chiedi
notizie di Filippo Damante
dell’Orante, du Muzzu, di ‘Nzunzù
delle favole antiche e delle streghe
che popolarono le laiche chiese e i querceti
che ancora denudano radici
alle sorgenti del Longano e all’Acqua Santa.
Tu mi chiedi ansioso disperato del dio
di quali dio confortò il dolore
di queste anime morte seppellite
sotto la nuda gleba di Piscopo
dove ancora “Nottetempo casa per casa”
i piccoli falò fremono
di silenzio, di pianto e di preghiera
per le stragi che i demoni dei forni crematori
compirono con il fuoco della cera umana
che hanno insanguinato l’Europa
e che ora altri mostri del potere
vogliono seppellire per sempre
con invisibili virus alleati.
Qui arresi tra le mura
nella tregua ai piedi del Maniero
i disertori di una inestinguibile paura
cercano un rifugio sicuro dal terrore
prosciugò anche il sangue nelle vene arse
tra ululati di sogni ed agonia
I semi incandescenti della parola
pietrificata nella malta e nel pantano,
dove solo le conchiglie lucescenti
si sottraggono alle menzogne della notte
restando invisibili in apnea nel fango
in attesa che le ronde della morte
varchino l’implacabile Acheronte
e le anime morte possano risorgere
nel teatro abbagliante del cielo.
Ora che immensi funghi atomici
aggrediscono con nuvole nere
la visione di uno spiraglio di vita
ora tu cerchi tra gli avelli
con la luminescente cecità di Omero
un flebile alito del cuore
che possa ridestare altra vita
per cancelli il ricordo
della violenza, dell’insania e dell’orrore
con la dolcezza della parola ripiumata.
E Voi, nuovi credenti della sacerdotessa Artemide
che vento e tempesta vi sospingano
verso i sarcofaghi porosi di Pantalica
a ritessere il velo delle Grazie,
mentre veleggiate tra gli imenei
zigrinati del sapere, non voltatevi indietro;
la città di Dite si gretola
dentro altri roghi di nubi tossiche,
e il pianeta già colmo di veleni
mostra segni incontrollabili
di agonia nel pianto delle statue
nelle epifanie rivelate a bimbi puri,
in tutti quelli che piangono
e nell’animo ardono della tua carezza melica,
nuovo Orfeo siciliano,
dolce cantore di felici memorie e di miti.
Predatore salvifico di simulacri mitici,
stritolato un tempo anche tu
dall’empia diaspora del corpo dentro
Ti resti vergine nella parola melica
l’isola perduta dell’infanzia,
inebriata dal fiume delle zagare
avvolta nell’afrore del basilico.
Già sul tuo etero mare
che ha ingoiato i tuoi lucenti occhi innamorati,
piovono le scintille limpide
di una nuova alba. I pesci già balzano
in geometrie d’amore. L’Orsa è tornata
a disegnare nel celeste velo
le sue perfette geometrie di un tempo,
il pescatore con le reti è sul molo
pronto e lieto di ripescare
il senso prezioso del lavoro,
la gioia perduta della vita.
CARMELO ALIBERTI (1 ed.2005- 2 ed.2020)
CAPITOLO 3
VINCENZO CONSOLO
Sesto di otto figli, nacque a Sant’Agata di Militello (Messina) il 18 febbraio 1933, da Calogero (1898-1962) e Maria Giallombardo (1900-1988).
Il padre, commerciante alimentare e poi piccolo imprenditore con la nascita della ditta ‘Fratelli Consolo Cereali’ nel 1939, trasmise al figlio i tratti di un’etica rigorosa, dimostrata anche contro la mafia, la quale nell’immediato dopoguerra veniva organizzando in tutta la Sicilia il controllo delle attività economiche. Anche evocando il celebre testo di Luigi Pirandello sulla propria nascita nella contrada del Caos, Consolo ricordò i luoghi d’infanzia, le sue origini e la sua prima educazione nel romanzo d’esordio, La ferita dell’aprile (Milano 1963), dedicato «con pudore» a suo padre, scomparso proprio in quell’anno. Iniziava una progressiva centralità della Sicilia nella sua personalità di uomo e di scrittore, di intellettuale al bivio tra saggistica e letteratura, in una contaminazione di ‘generi’ che ha sempre distinto le sue pagine e che trova in Leonardo Sciascia, maestro dell’ibridismo, un decisivo modello. La sua terra di origine si rivela come presenza «ossessiva», con un forte valore identitario, storico ma anche simbolico, che segna in parte il destino di uno scrittore «anfibio», tra terra e mare, tra passato e presente. Sicilia come luogo, tema, personaggio, persino struttura narrativa; quasi ad annodare, in una profonda corrispondenza e circolarità, i fili dell’amplissimo e diversificato corpus letterario dello scrittore, da La ferita dell’aprile al postumo La mia isola è Las Vegas: «tutti i romanzi, se ordinati in base alla cronologia dei fatti descritti o allusi, compongono, per momenti decisivi, una storia della Sicilia degli ultimi duecentocinquant’anni» Questa sicilianità «ostinata» e «implacabile» emerge spesso nella declinazione, tematica e metaforica, del viaggio, che è spostamento fisico ma anche attraversamento di tempi e luoghi, sfida all’ignoto e continua tensione verso un altrove; nella duplice direzione della partenza e del nostos che richiama il grande archetipo omerico, l’Odissea, il «poema in cui per la prima volta si apre davanti ai nostri occhi lo spazio mediterraneo» (in Di qua dal faro).
Eppure, «nella modernità, le colpe non sono più soggettive, ma oggettive, sono della storia. I mostri non sorgono più dal mare, dalla profondità del subconscio, ma sono mostri concreti, reali, che tutti noi abbiamo creato […] Itaca non è più raggiungibile. Come lo stesso scrittore osserva ne “Il viaggio di Odisseo”: «Questo lo scrittore oggi ha il compito di dire, di narrare». Nel tragico confronto tra passato mitico e desolato presente della sua terra, si ripropone la sofferta diaspora, e il doloroso ritorno, degli scrittori meridionali; la «dolorosa saggezza» e la «disperata intelligenza» di cui Consolo ragiona ne Le pietre di Pantalica. Gli anni della guerra per il giovanissimo Vincenzo trascorsero relativamente tranquilli fino al 1943, quando gli americani, in preparazione dello sbarco, diedero avvio a massicci bombardamenti che coinvolsero la zona di Sant’Agata, sulla linea strategica Messina-Palermo, e che costrinsero la famiglia Consolo a ‘sfollare’ in campagna, nella contrada di Vallebruca. Dopo le scuole medie all’istituto salesiano Guglielmo Marconi, l’assenza di scuole pubbliche di grado secondario lo condusse nel 1947 al primo allontanamento da casa, per frequentare il liceo-ginnasio salesiano Luigi Valli a Barcellona Pozzo di Gotto, a ottanta chilometri da Sant’Agata. Negli anni liceali si collocano i primi esercizi di scrittura, anche su suggestione di due letture che si rivelarono decisive: Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini e Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Nell’autunno del 1952 giunse il primo trasferimento, «traumatico», a Milano, per frequentare la facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica. Fu in quei primi anni universitari che conobbe Basilio Reale, l’amico Silo che lo introdusse alla casa editrice Mondadori.), e Lucio Piccolo, il «barone magico» delle Pietre di Pantalica: «grande poeta di sconfinata cultura, cugino e antagonista di Tomasi di Lampedusa. Fu lui a insegnarmi la vera letteratura, la poesia che furono miniere lessicali per me» (Fuga dall’Etna, Roma 1993, p. 18). Costretto a interrompere gli studi per assolvere gli obblighi del servizio militare (dapprima a Orvieto e poi a Roma), riprese il percorso universitario nel 1957, stavolta a Messina, per laurearsi quindi nel 1960 discutendo una tesi in filosofia del diritto dal titolo «La crisi attuale di diritti della persona umana».
Molti anni dopo, a Milano, in presenza della gran mole di Riccardo Bacchelli dice a se stesso che lui, così piccolo, non potrà mai diventare uno scrittore, gli manca il physique du rôle. Il padre ripeteva scherzosamente che, diverso com’era dagli altri figli, era un trovatello. Lo aveva ritrovato sulla vicina strada per San Fratello, antica colonia d’origine lombarda, in cui si parlava un dialetto incomprensibile, che per i siciliani della zona, raccontava Vincenzo, era diventato la cifra stessa della diversità, dunque motivo di scherno, di dileggio. Lui invece si sentiva a proprio agio, in quell’identità di sanfratellano. Lo faceva sentire in battaglia contro ogni autorità costituita, contro il codice linguistico dominante.
Cresce in una casa senza libri, ma a scuola è bravissimo. Quando dopo aver frequentato gli studi presso i salesiani e conseguita la maturità al liceo classico “Valli” di Barcellona P.G.(ME), esprime il desiderio di voler studiare lettere classiche, i suoi gli dicono che per carità, quella è materia da femmine. Per compiacerli, si laurea in Legge e si adatta persino a fare l’apprendista nello studio notarile di un cognato, a Lipari. Poi insegna diritto in un istituto superiore, ma si sente mancare l’aria.
È afflitto da una timidezza patologica. Scrivere per lui è una ragione di vita, ma si chiede se rifugiarsi nella letteratura non sia un “segno di babbìa”, di sciocca ingenuità, un modo per evadere dalla realtà. Ama la sua terra, tra le colline e il mare, con una adesione panica, e tuttavia avverte l’isola come una gabbia. Si chiede se “uscendo da questo pozzo scuro di Sicilia, riuscirei a sbloccare ogni cosa”. La ferita dell’aprile passa quasi inosservato, apre una stagione di crisi e dubbi crescenti.
Cerca e trova maestri, come Leonardo Sciascia, avvolto nel fumo delle sue Chesterfield, e il poeta Lucio Piccolo, cugino di Tomasi di Lampedusa, “il barone magico” che lo invita spesso nella sua villa di Capo d’Orlando, dove lo gratifica di monologhi ammalianti. Intanto matura una coscienza politica che resterà sempre vigile e risentita perché offesa. Ha sperimentato le prepotenze mafiose, assistito alle lotte contadine e alle repressioni poliziesche, è rimasto sconvolto dalla strage di Portella della Ginestra.
Nel 1967 la grande occasione: vince un affollatissimo concorso in Rai. Viene assunto come funzionario addetto ai programmi culturali e si trasferisce a Milano. Non è un’esperienza felice. Non sopporta le regole troppo rigide, le gabbie burocratiche, le imposizioni dall’alto. Ha duri scontri con la Direzione centrale, sperimenta sulla sua pelle quello che oggi si chiama mobbing.
Lo salva il giornalismo. Vittorio Nisticò lo invita a collaborare al battagliero quotidiano palermitano che dirige, “L’Ora”, che ha già al suo attivo tante battaglie civili, in primis contro la mafia trionfante di quegli anni. Nel 1975 si trasferisce a Palermo, fa il cronista con umiltà e dedizione, convinto che quello sarà il suo vero mestiere. Intanto fermenta, lentamente e tortuosamente, il progetto di romanzo che diventerà Il sorriso dell’ignoto marinaio: una rilettura delle vicende risorgimentali in una Sicilia squassata da tentativi rivoluzionari e rivolte contadine, molto lontana dall’agiografia tradizionale, che si interroga sull’uso mistificatorio della Storia, scritta troppo spesso dalle classi dominanti.
Ne è protagonista Enrico Pirajno, barone di Mandralisca, liberale illuminato, erudito, collezionista, appassionato studioso di scienze naturali, cultore di chiocciole e molluschi, che ha reso pubbliche le sue raccolte trasformando la sua casa di Cefalù in museo, quello stesso dove ancora oggi si conserva il meraviglioso ritratto di ignoto di Antonello da Messina da lui acquistato a Lipari.
A superare le incertezze di una stesura tanto travagliata è la moglie di Consolo, Caterina, che di nascosto da lui porta al libraio-editore Gaetano Manusé i primi due capitoli del romanzo, per una edizione d’arte arricchita da un’acquaforte di Renato Guttuso. Corrado Stajano ne scrive entusiasta su “il Giorno”: è più sottile e intenso del Gattopardo, è uno Sciascia poetico. Da Einaudi ci precipitiamo a scrivere a Consolo che ci interessa molto.
A questo punto l’uomo dei dubbi è obbligato a vincere le sue titubanze. In tre mesi finisce il lavoro, di getto. Stajano ha visto giusto. “Il sorriso dell’ignoto marinaio” si rivela un romanzo stupefacente, un poema in prosa sostenuto da una scrittura potente, musicale, fortemente ritmata, che fonde in una polifonia di voci un italiano “alto” e i dialetti, tradizione colta e materiali popolari. Ne nasce una vertiginosa pluralità di lessici, registri e toni, dove la parola è spinta verso un massimo di sonorità e splendore. Consolo ha lo stesso vorace enciclopedismo del suo amato Gadda, incrocia invenzione e documenti autentici, si abbandona alla vertigine della lista. Gode nel nominare le cose, la natura di casa che conosce così bene.
Così avverrà negli altri suoi libri, come la malinconica favola teatrale “Lunaria”, in cui la Luna cade su una contrada di una Palermo settecentesca, a simboleggiare la fine di tante cose. O in un altro romanzo corale e musicale, “Nottetempo, casa per casa”, Premio Strega 1992, in cui l’avvento del fascismo in Sicilia è colto attraverso l’arrivo a Cefalù di una stravagante comunità di cultori di riti esoterici, capeggiata da un moderno superuomo, l’inglese Aleister Crowley, profeta di una religione satanica, tra sesso e droga.
CAPITOLO 4
I PRIMI GRANDI ROMANZI
Il primo testo a stampa risale al 1957, Un sacco di magnolie, apparso a firma «Enzo Consolo» nella rivista La parrucca (poi in La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, Milano 2012, pp. 8-10).
Il suo esordio come romanziere è invece La ferita dell’aprile (cit.) che apparve nel 1963 per Mondadori nella collana «Il Tornasole» di Niccolò Gallo e Vittorio Sereni, con l’assistenza redazionale di Raffaele Crovi: «Mi sono ritrovato fatalmente nel solco sperimentale di Gadda e Pasolini, di D’Arrigo e Mastronardi. Non era ancora apparso all’orizzonte il Gruppo ’63, dal quale in ogni caso mi avrebbe tenuto ben lontano un forte senso di appartenenza alla tradizione letteraria» (Fuga dall’Etna, cit., p. 15).
Forse anche per quella coincidenza cronologica con le spinte avanguardistiche, il romanzo quasi sfuggì all’attenzione di critica e di lettori. Suscitò invece l’interesse di Sciascia, al quale Consolo aveva inviato il libro allegando una lettera nella quale gli dichiarava il suo debito come scrittore.
Era l’inizio di una salda e duratura amicizia, alla quale Consolo dedicò numerose pagine, molte delle quali raccolte nella sezione Intorno a Leonardo Sciascia del volume Di qua dal faro (cit., pp. 1161-1184). La ferita dell’aprile, «poemetto narrativo» costituisce un unicum nella carriera dello scrittore.
Nel racconto della vita di un paese siciliano e delle lotte politiche del dopoguerra, la narrazione in prima persona è impostata cronologicamente come diario di un anno scolastico e mette in scena i turbamenti dell’uscita dall’infanzia, nell’intreccio tra vicende personali dei protagonisti e storia d’Italia. Sin dall’esordio emerge con forza, nella scrittura, quella centralità della parola che ha connotato fortemente l’intera sua produzione, fino a consacrarlo come ‘autore difficile’, ‘enigmatico’:
«Mi ponevo […] sul crinale della sperimentazione, mettendo in campo una scrittura fortemente segnata dall’impasto linguistico» (in Adamo, 2006, p. 183). Quella stagione fu segnata anche dalla pubblicazione in Rinascita, del noto saggio di Pasolini, Nuove questioni linguistiche, apparso nel dicembre 1964, alla vigilia della pubblicazione del primo capitolo del Sorriso dell’ignoto marinaio. Nel 1964 prese a scrivere per L’Ora di Palermo, giornale allora diretto da Vittorio Nisticò; era l’inizio di una lunga collaborazione che lo impegnò fino al 1975 e poi ancora dal 1977 al 1991, e che vide Consolo anche titolare di una rubrica di successo, «Fuori casa», inaugurata nel dicembre 1968, come vedremo in “Esercizi di cronaca”, edito postumo da Sellerio.
Nel racconto Per un po’ d’erba ai margini del feudo (in L’Ora, 16 aprile 1966, inaugurava un nuovo modo narrativo, fondato sull’intreccio tra fiction e storia, racconto e documenti, che avrebbe poi preso corpo nel suo maggiore romanzo.
Nello stesso 1966 si collocano per Consolo viaggi significativi, come quello nella valle del Belice, che riporta nel racconto del 1984, Il drappo rosso con le spighe d’oro, e la trasferta a Parigi con Sciascia.
Nel 1967, l’anno nel quale Pasolini pubblicava in Nuovi Argomenti la prosa poetica di Lucio Piccolo L’esequie della luna da cui nacque lo spunto per Lunaria, Consolo vinse un concorso per la RAI. Interruppe quindi l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado e, nel gennaio 1968, prese servizio presso la sede di Milano, un trasferimento destinato a segnare la vita e l’opera dello scrittore.
Ad accoglierlo in azienda fu, tra gli altri, Caterina Pilenga, che aveva apprezzato il suo poco noto romanzo La ferita dell’aprile e che divenne compagna della vita, e moglie con rito civile dal 1986. Quel trasferimento, in quel «momento di acuta storia», fu una decisiva cesura, sulla quale spesso Consolo avrebbe riflettuto. Era una declinazione tragica del tema della sua protesta contro luoghi e tempi rispetto ai quali si sarebbe spesso sentito estraneo: la Milano di allora, l’«attiva, mercatora» città, e in particolare la RAI, «completamente ipotecata dal potere politico, dalla mafia partitica». Stabilitosi a Milano, Consolo prese a frequentare la casa sui Navigli della compagna di Vittorini, Ginetta Varisco, un cenacolo culturale animato tra gli altri da Carlo Bo, Italo Calvino, Paolo Volponi e Salvatore Quasimodo.
Intanto lesse, destinati a incidere il suo percorso di scrittura, Manifesto per un nuovo teatro di Pasolini, pubblicato in Nuovi Argomenti, e Appunti sulla narrativa come processo combinatorio di Calvino, apparso in ‘Nuova Corrente’.
In quel ‘caldo’ 1968 aveva anche inviato alla prestigiosa rivista Paragone, un racconto intitolato Il sorriso dell’ignoto marinaio: il primo capitolo del futuro capolavoro, che tuttavia non venne accolto dalla rivista e apparve in Nuovi Argomenti, per volontà di Enzo Siciliano, nell’ultimo numero della stessa annata. Nel 1975, Consolo intensifica l’attività giornalistica e dall’autunno del 1976 iniziò a collaborare anche con La Stampa e Il Corriere di Sicilia, il Corriere della sera e il Messaggero.
Era un lavoro che si prospettò infine come possibile impegno esclusivo: «Ho cercato di lasciare Milano nel 1975, perché non volevo più scrivere, non volevo più fare lo scrittore […].
Mi sono detto ‘farò il giornalista a vita’, perché mi sembra importante fare il giornalista, soprattutto in una città di frontiera com’era Palermo a quell’epoca» (in Pintor, 2006, p. 252). Era la vigilia dell’uscita del romanzo, che avrebbe fatto conoscere Consolo al grande pubblico.
Nell’autunno del 1975, infatti, all’insaputa dell’autore, apparve l’edizione Manusè del Sorriso dell’ignoto marinaio, per interessamento della compagna Caterina e di Sciascia, con un’acquaforte di Renato Guttuso. Dopo diverse proposte editoriali, e con un crescente interesse di pubblico e di critica, il romanzo apparve in versione definitiva nel 1979 per Einaudi, la casa editrice con la quale collaborava dal 1976 su proposta dell’amica Elsa Morante e dello stesso Giulio Einaudi.
Il romanzo richiama nel titolo il sorriso enigmatico raffigurato nel Ritratto di ignoto di Antonello da Messina.
L’intreccio prende corpo intorno a tre elementi, che si fanno nuclei narrativi: il fascino esercitato dalla preziosa tavoletta pittorica ammirata già nell’estate del 1949 presso la Casa-museo Mandralisca; l’interesse per la storia della rivolta contadina di Alcàra Li Fusi, dopo l’arrivo di Garibaldi; l’inchiesta sui cavatori di pietra pomice delle isole Eolie, ammalati di silicosi. La complessa architettura narrativa, più volte letta come anti-Gattopardo, pur con postazioni ideologiche e artistiche molto differenti, al centro di entrambi i romanzi è la Sicilia percorsa da aneliti garibaldini.
In tale prospettiva, Il sorriso rappresenta la ripresa del racconto storico siciliano, imperniato sull’epopea risorgimentale negli anni dello sbarco garibaldino: una tradizione «sempre critica, antirisorgimentale», che da Verga, attraverso De Roberto e Pirandello, arrivava a Sciascia e Tomasi di Lampedusa.
La trasposizione del tempo storico all’immediato presente, la riflessione sulla lingua e la stessa tessitura linguistica, impastata di dialetti e gerghi tecnici, sembrano confermare la natura più autentica della narrativa di un autore che «abdica, per così dire, alla sua condizione di letterato per divenire intellettuale, ‘politico’» (Letteratura e potere, 1979); la decisione di «non scrivere in italiano» era una forma di «ribellione alle norme» e alla storia.
La contaminazione linguistica fu definita la tecnica chirurgica del «trapianto»: il romanzo evoca le sperimentazioni novecentesche, il pastiche gaddiano o lo sperimentalismo pasoliniano, pur con una declinazione personalissima, a tratti neobarocca; in una raffinatezza strutturale, definita «costruzione a chiocciola», concentrica e labirintica, come la definì Cesare Segre (Segre, 1987).
CAPITOLO 5
GLI ANNI OTTANTA E IL DITTICO BAROCCO
DI LUNARIA E RETABLO
Anche sull’onda del successo del Sorriso, negli anni Ottanta Consolo intensificò l’attività di scrittura nella ricerca di nuove forme espressive, come mostrano i progetti ai quali lavorò: un singolare romanzo giallo, Morte del giardiniere (1981); il progetto di una inchiesta su una vicenda criminale degli anni Cinquanta (i frati estorsori di Mazzarino, primo nucleo narrativo di Le pietre di Pantalica). Dal citato poemetto in prosa di Lucio Piccolo, Le esequie della luna; nacque invece Lunaria, favola teatrale ambientata nella Palermo settecentesca che apparve nei «Nuovi Coralli» di Einaudi (Torino 1985) e che gli valse il premio Pirandello. Nella profonda tensione etica, la scrittura si sarebbe liberata dallo scavo della realtà autobiografica e storica proprio con Lunaria, che può anche leggersi come semplice allegoria della solitudine dello scrittore. Nella Palermo settecentesca si muove il malinconico Viceré Casimiro, che sogna la caduta della luna, turbato da fantasmi di una diversa realtà, in una visione che si fa presagio che s’invera. ‘Lunaria’ è decisamente di ispirazione fantastica, e risente del teatro barocco. Si moltiplicava, con Sciascia una salda amicizia, che lo spinse a pubblicare un articolo (Difficile mestiere scrivere da uomo libero, in Il Messaggero, 27 gennaio 1987), in difesa dello scrittore di Racalmuto travolto dalle polemiche suscitate da I professionisti dell’antimafia, apparso nel Corriere della sera il 10 gennaio 1987. In seguito all’insistente invito di Elvira Sellerio, nell’estate del 1987 Consolo raggiunse Palermo per lavorare a Retablo, che apparve (dopo l’anticipazione di alcuni capitoli in la Repubblica) nell’ottobre 1987, con cinque disegni di Fabrizio Clerici. Retablo riscosse grande successo di pubblico e gli valse il premio Grinzane Cavour e il premio Racalmare. L’opera segna per molti aspetti uno snodo all’interno della produzione di Consolo che, sensibile agli esiti della narrativa italiana e straniera (da Calvino a Manganelli, da Perec a Borges), pone al centro della narrazione romanzesca una stringente interrogazione sulla scrittura. Nella reiterata sovrapposizione tra storia e invenzione, persone e personaggi, Retablo, che richiama l’arte pittorica sin dal titolo, segue le vicende di un intellettuale e artista in fuga da Milano verso la Sicilia alla ricerca della matrice culturale e umana della donna che ama, Teresa Blasco (nella storia, la madre di Giulia Beccaria). Intorno al protagonista-pittore si dipana un intreccio tra letteratura e arti visive, ormai divenuto centrale nella scrittura di Consolo (Cuevas, Ut pictura: el imaginario iconografico en la obra de V. C., in Cuevas, 2005, pp. 63-77); fino a una immaginazione visiva che punta sulla centralità dei luoghi, in una personale geografia esistenziale. Retablo infatti è costruito sul modello odeporico, che richiama, per rinnovarla, la tradizione dei racconti del Grand Tour oltre che del modello classico del nostos, che utilizzò poi anche nelle narrazioni successive, nella opposizione geostorica Milano-Sicilia. Il 1989 segnò per Consolo il ritorno alla forma tragica, con un testo redatto insieme con gli amici Gesualdo Bufalino e Leonardo Sciascia, Trittico appunto, andato in scena al teatro stabile di Catania il 3 novembre 1989 per la regia di Antonio Calenda (poi in volume, Catania 1989). L’atto unico di Consolo, Catarsi, si accompagnava a La panchina di Bufalino e a Quando non arrivarono i nostri, rielaborazione drammaturgica di una novella di Sciascia.
CAPITOLO 6
LA TRILOGIA DEGLI ANNI NOVANTA
La sincera passione civile, declinata spesso nel segno della protesta, non si tradusse mai nella partecipazione attiva alla politica – nonostante i ripetuti inviti a una sua candidatura avanzati dal Partito comunista italiano (PCI) di Achille Occhetto – ma certo animò la sua scrittura, nella battaglia ingaggiata tra le parole e le cose.
All’indomani dell’assassinio del giudice Rosario Livatino, il 21 settembre 1990, in un acceso clima di rivendicazioni e polemiche, decise di dimettersi dalla giuria del premio Racalmare, che intanto era stato intitolato a Sciascia, scomparso l’anno precedente.
È nel segno di questa protesta che si inserisce anche lo studio e il racconto della Sicilia, che Consolo continuava a osservare e denunciare: l’isola tra mito e storia, la terra dalla quale idealmente non riuscì mai a separarsi, sul piano intellettuale e artistico, eppure nella quale non tornò mai a vivere.
È in questa prospettiva che può leggersi quella che sembra configurarsi quasi come trilogia: Nottetempo, casa per casa (Milano 1992), L’olivo e l’olivastro (ibid. 1994) e Lo spasimo di Palermo (ibid. 1998), sotto il segno del definitivo tramonto dell’utopia, nell’accentuazione di una dimensione simbolica della storia e della realtà.
Nel 1992 Nottetempo, casa per casa (cit.), che fu insignito con il Premio Strega, rappresentò un ritorno al romanzo storico, come già forse, in parte, Le pietre di Pantalica (Milano 1988), stratificato e multigenere, la cui struttura tripartita (Teatro, Persone, Eventi) rimandava ancora una volta al teatro.
Al progetto narrativo di Nottetempo Consolo lavorava almeno dalla fine degli anni Sessanta, quando aveva cominciato a raccogliere materiali e documenti sul risorgimento in Sicilia, sulla strage di Alcàra Li Fusi L’opera sembra segnare il secondo tempo di una ideale lunga storia della Sicilia, una fase successiva al Risorgimento del Sorriso e precedente agli anni Novanta di Lo spasimo di Palermo (1998). «In Nottetempo ho voluto far vedere come il fascismo fosse figlio della follia, la follia privata del protagonista e quella pubblica della Storia, il ricorso al satanismo che voleva distruggere il cristianesimo di una società malata: tutti segni oscuri e premonitori, come quelli che vediamo oggi con il ritorno a queste ridicole forme di esorcismo, questi fondamentalismi, questi revanscismi» (in Parazzoli, 1998, p. 28).
Continuava la sua forte militanza civile: le proteste contro l’elezione di Formentini a sindaco di Milano, o le dimissioni, all’indomani della nomina, il 10 settembre 1993, dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione del teatro stabile di Palermo, in polemica con il direttore artistico Pietro Carriglio, ritenuto «intellettuale organico alla DC di Salvo Lima». Questa forte militanza proseguì con maggiore libertà dopo il suo collocamento in pensione dalla RAI, nel 1993.
In seguito alla vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni politiche, Consolo aderì al Forum Manifesto democratico 1994, promosso da Cesare Segre, Raffaele Fiengo e Corrado Stajano. Intanto, il 25 giugno di quell’anno partecipò a un dibattito coordinato da Renato Nisticò da cui sarebbe nato il testo Fuga dall’Etna (cit.), nuova testimonianza di una sicilianità che trovò riconoscimento anche nella cittadinanza onoraria di Cefalù, cui seguì, nel 1996, la stessa onorificenza da parte del Comune di Santo Stefano di Camastra.
Ed è sempre la Sicilia al centro del volume del 1994, L’olivo e l’olivastro, che nel consueto superamento dei confini di ‘generi’ compiuto da Consolo, nell’intreccio tra poesia e prosa, narrazione e saggismo, che per alcuni richiama l’Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, si presenta come graffiante narrazione di viaggio. Il doloroso ritorno di Odisseo-Consolo verso l’Itaca-Sicilia è «un viaggio in verticale, una discesa negli abissi». Come Retablo, anche L’olivo e l’olivastro conduce il lettore attraverso la Sicilia di un presente degradato, che si confronta con il passato mitico.
Nel dicembre dello stesso 1994 ricevette per il complesso della sua opera narrativa e saggistica il premio internazionale Unione Latina da una giuria composta, tra gli altri, da José Saramago, Jorge Amado, Luigi Malerba. Pochi mesi dopo apparve il suo ultimo romanzo, Lo spasimo di Palermo (Milano 1998) che, riprendendo elementi de La ferita dell’aprile, segna come un ritorno all’autobiografismo.
La vicenda si svolge nell’anno delle stragi di Capaci e via D’Amelio, i tragici fatti del 1992 ai quali Consolo aveva già dedicato un testo-adattamento della Messa di requiem di Verdi: Dies irae. Requiem da questa Palermo (poi Requiem per le vittime della mafia), eseguita con musiche di vari artisti nella Cattedrale di Palermo il 27 marzo 1993.
La vicenda del protagonista-scrittore Gioacchino Martinez e del suo nostos ai luoghi dell’infanzia e giovinezza riscosse grande successo di pubblico e di critica (premio Monreale per la narrativa nel 1998; nonché, l’anno successivo, insignito con il premio Flaiano e il premio Brancati).
CAPITOLO 7
IL SILENZIO DELLO SCRITTORE
Gli ultimi anni di vita sono segnati per Consolo da una dolorosa afasia artistica, che si manifesta come ulteriore declinazione dell’impegno. Il mese successivo firmò la sua adesione al Manifesto in difesa della lingua italiana promosso tra gli altri da lui, nella convinzione che l’Italia «ha perso memoria di sé, della sua storia, della sua identità», e che «l’italiano è divenuta un’orrenda lingua, un balbettio invaso di linguaggi che non esprimono altro che merce e consumo» (Il lungo sonno della lingua, in Il Corriere della sera, 6 giugno 2000).Intanto, era ascoltato, letto e studiato all’estero: nel 2002 tenne un ciclo di conferenze negli Stati Uniti, mentre si avvicendavano convegni e volumi a lui dedicati: Siracusa, Siviglia e tre convegni all’Università di Valencia per iniziativa di Irene Romera Pintor, traduttrice di opere consoliane. Nel 2003 l’Università di Roma «Tor Vergata» gli conferì la laurea honoris causa in lettere. Mentre proseguivano le edizioni di romanzi e raccolte di saggi in Europa, negli Stati Uniti e in Canada, a settembre 2004 Consolo iniziò a lavorare a una raccolta di racconti, che apparve postuma nel maggio 2012, a pochi mesi dalla morte, con il titolo La mia isola è Las Vegas, a cura di Nicolò Messina. Mentre si arenava il progetto di una riduzione cinematografica dello Spasimo di Palermo, proseguivano adattamenti teatrali delle sue opere. Dopo la versione di Retablo al teatro stabile di Catania, Ugo Ronfani scrisse nel luglio 2010 l’adattamento del Sorriso dell’ignoto marinaio, andato in scena a Genova. Morì poco dopo, a Milano, il 21 gennaio 2012. Rifiutando cerimonie pubbliche in fede alla volontà dell’Autore, la moglie Caterina fece celebrare le esequie a Sant’Agata di Militello il 23 gennaio, dove fu seppellito nella cappella di famiglia.
CAPITOLO 8
VINCENZO CONSOLO, IL POETA DELLA STORIA
E LA METAFORA DELLA CONCHIGLIA
Il nome di Vincenzo Consolo è stato associato, ormai quasi definitivamente, a quelli di Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino, con i quali ha condiviso un lungo sodalizio intellettuale. Consolo è convinto che “non si possano scrivere romanzi perché ingannano il lettore”, perciò le sue creazioni narrative sono protese al setacciamento dell’ ovulo della parola, alle alchimistiche operazioni di orchestrazione lessemo – stilematica e sintattico – ritmiche al fine di far sprigionare dalla solfeggiata andatura del periodo, il soffio segreto dell’elegia. Infatti la sua prosa riecheggia di sonorità liriche, ricca di figure retoriche, allitterazioni, assonanze, paronomasie che, nello scandire i momenti evocativi della memoria e i temi scottanti dell’attualità, particolarmente della storia siciliana, si innalza ai vertici della poesia, con una chiarezza razionale di stampo illuministico.
Vincenzo Consolo nasce a S. Agata di Militello (Messina) il 18 febbraio del 1933 da padre borghese e da madre popolana. Visse l’infanzia durante gli anni della Seconda guerra mondiale, turbato dalle crudeltà del conflitto e dalla lotta partigiana, per cui insieme alla famiglia si trasferì in campagna, dove, tuttavia, continuò a riecheggiare l’eco dei bombardamenti, scompigliando anche gli incontri gioiosi dei bambini, compagni di gioco del nostro e vittime innocenti della guerra.
Tornato al paese natale, dopo lo sbarco degli alleati, le dolorose vicende di quegli anni fornirono allo scrittore il materiale per comporre il suo primo romanzo. Dopo aver frequentato gli studi presso i salesiani, consegue la licenza liceale al “Valli” di Barcellona P.G. (ME). Quindi si iscrive alla Cattolica di Milano dove, dopo essere stato costretto ad interrompere gli studi per far fronte alla leva obbligatoria, si laurea in Giurisprudenza a Messina con una tesi in Filosofia del diritto; svolge poi encomiabilmente l’apprendistato di notaio tra il paese natale e Lipari. Presto, però, prevale in lui la vocazione letteraria, sfociata nella composizione del suo primo romanzo “La ferita dell’aprile”. Il testo è ambientato negli anni della “guerra fredda” in un paese della Sicilia settentrionale, e narra le lotte politiche del Secondo dopoguerra, filtrate nel racconto in prima persona del protagonista, un ragazzo che studia in un istituto religioso in un paese di contadini e di pescatori, dove i “carusi” spiano la vita della piccola comunità patriarcale, attraversata dalla tragedia esistenziale.
Trasferitosi a Milano nel 1968, le acque del suo mare, tra le coste siciliane e le Eolie e il paesaggio e la storia delle vittime della civiltà contadina e dello stupro della tragedia siciliana, offrono le ragioni profonde della trama del suo capolavoro “Il sorriso dell’ignoto marinaio” (1976), con cui Vincenzo Consolo è conosciuto dal grande pubblico. La genesi del libro non è stata continua; infatti la stesura, per volere dell’autore, fu interrotta dopo i primi due capitoli che furono pubblicati, in edizioni numerate, con un’iscrizione di Renato Guttuso, ma l’attenzione suscitata, indusse Consolo a completare l’opera, con l’aggiunta di altre sette sezioni, dopo dieci anni, su pressante invito dell’editore Einaudi. Il romanzo presenta una struttura complessa ed è ambientato nella Sicilia degli anni 1856 – 1860, cioè negli ultimi anni del regime borbonico, a ridosso della spedizione dei mille e della rivolta contadina di Alcara li Fusi (maggio 1860), repressa nel sangue dai garibaldini, di Bixio. Il protagonista realmente esistito, é facilmente collegabile al contesto di una rigorosa storicità, in cui si dipana anche la vicenda del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il barone Enrico Piraino di Mandralisca, protagonista del romanzo di Consolo, e il principe Fabrizio Salina, protagonista del Gattopardo, sono entrambi aristocratici illuminati e assistono al passaggio dallo stato borbonico a quello unitario nazionale; al radicale pessimismo di don Fabrizio, di idee democratiche e patriottiche, ma lontano dalle vicende politiche e chiuso nelle sue ricerche scientifiche, si contrappone l’illusionistica speranza del Mandralisca, dapprima umbratilmente serpeggiante negli accadimenti ribellistici, ma progressivamente sempre più palese, fino all’epifania finale, paradigmata dalle epigrafi che scandiscono la tragedia dei martiri – eroi, innalzata e premessa ipotetica della redenzione della plebe siciliana. Il romanzo di Consolo è caratterizzato da due metafore fondamentali: “Il sorriso dell’ignoto marinaio”, ironico e pungente simbolo dell’apparente rifiuto aristocratico verso ogni forma di impegno, e la chiocciola, concretizzazione simbolica del labirinto della storia, dalle ampie entrate e dall’uscita sinuosa, speculare emblematicità del percorso delle vicende umane.
L’opera è caratterizzata da moduli narrativi complessi, espressi in terza persona e con proiezioni in spazi neutri, la “lettura e la “memoria”, redatte e osservate dal protagonista, con scene corali, ora inflesse in enigmatiche articolazioni, ora riflesse sui tabulati della tragedia, sono declinate con contrapposti regimi narrativi, connotati dalla lingua brillante del Mandralisca, e dalle molteplici inflessioni popolari, sopra cui si staglia la cesellatura linguistica dello scrittore che dispiega galassie paesaggistico – naturali e implosive oscillazioni emotive, in scansioni descrittive di aureo impianto lirico – semantico.
La scelta dei molluschi si traduce, come si è detto, in metafora della vita, in cui si condensano sia le tematiche del libro, che le strutture linguistiche e lessicali. Altro personaggio chiave è Giovanni Interdonato, come il Mandralisca realmente vissuto, protagonista gradualmente emergente da una sorta di baluginante ambiguità, fino alla chiarificazione del suo ruolo di mente nel movimento di liberazione della Sicilia. Dopo aver chiarito le corrispondenze semantiche tra il sorriso di costui, incontrato su una nave diretta dalle Eolie a Cefalù, i rapporti con il Mandralisca e con altri elementi della nobiltà siciliana destinata al declino, affiorano alla ribalta della storia i contadini della sua terra, protagonisti della sanguinosa rivolta di Bronte, tutti processati per strage, ma alla fine tardivamente assolti per interessamento dell’Interdonato, con segrete interferenze plasmatiche del barone Mandralisca, rivelatosi determinante nell’indicazione e decrittazione dei documenti apposti in appendice, che imprimono chiarezza alle iniziali sinuosità della progressione storico – narrativa. Enrico Mandralisca non è un nobile, ottusamente custode degli interessi di classe, è consapevole del nuovo corso della storia, non ripiega narcisisticamente nelle bolge della nostalgia, ma sostiene, con modalità correlate al sussulto degli eventi i rivoluzionari che intendono liberare la Sicilia dalle ataviche sedimentazioni di sudditanza, per renderli protagonisti del proprio destino esistenziale e storico. Il barone sa che la storia è una “scrittura continua di privilegiati” e vorrebbe raccontarne una dove i contadini sono i protagonisti della stessa, ma si accorge che la scrittura dei “cosiddetti illuminati” è sempre “un’impostura”, perché questi si rifanno alle idee astratte di Libertà, Eguaglianza, Democrazia, Patria, che i vinti non sono in grado di capire; solo quando essi conquisteranno da soli quei valori, i discendenti saranno capaci di definirli con parole nuove. Il nobile intellettuale conclude con il riconoscimento dell’inutilità della scrittura e della necessità assoluta dell’azione, perciò, ritiene utile lasciare tutti i suoi beni a favore di una scuola, per i figli dei popolani in modo che imparino a scrivere e narrare la loro storia, per poterne capire gli orrori e coscientemente lottare contro le sopraffazioni subite per conquistare la libertà.
Anche nel romanzo successivo “Retablo” (1987) il racconto scivola su diversi piani narrativi e quadri storici staccati, come le scene variegate di una narrazione continua. Si narra dell’impossibile amore di due protagonisti, il pittore girovago milanese in viaggio in Sicilia, Fabrizio Clerici, e il prete siciliano Isidoro, per due donne, da cui rimarranno sempre lontani. Lo sfondo è una Sicilia lontana, preziosa, agreste. La lingua è ben studiata, con la strategica posizione di lessemi e stilemi idonea ad omogeneizzare lo spazio tra sequenze descrittivo – narrative e pause sono re con l’elencazione paesaggistico – oggettuale, in un intrico d’espressioni secondarie e subordinate condensate in una ampia tavolozza di immagini, situazioni e frammenti realistici, riprodotti con spiralizzante bulinatura neo – post – barocca, che imprime al romanzo una virtuosistica e profondamente vitalistica unità, al di là degli apparenti oscillamenti strutturali e nominali.
“Lunaria” (1985) è un originale testo dialogato, sotto forma di favola destinata al palcoscenico che nella Sicilia del ‘700, riscopre il mito della caduta della luna. Il testo inizia nel primo Novecento, quando un anziano barone, in odore di irreversibile declino storico, scrive poesie in cambio di pane, ispirandosi soprattutto alla luna. Dopo anni, il manoscritto del barone, attraverso il ritrovamento di un giovane di Palermo, perviene a Consolo che lo rielabora in testo teatrale, dove mito, storia e poesia, risultano riplasmati sincronicamente nella metrica e nell’ambientazione epocale della Palermo settecentesca, governata da un vicerè. Il centro narrativo è caratterizzato appunto dalla “caduta della luna”, che richiama a “L’esequie della luna” di Lucio Piccolo e alle pagine leopardiane delle “Odi”. Ma in Consolo i ritagli testuali delle correlazioni si dispiegano nel ventaglio della teatralizzazione della vita che diventa ansia e vertigine, panico, terrore, di fronte all’eternità e all’iniquità fatuamente terapizzata dall’uomo con inganni e illusioni, che non cancellano il male della Storia. Per cui, alla fine, il vicerè, tra riecheggiamenti leopardiani e intonazione pirandelliana, è costretto, di fronte all’impossibilità della Materia a dischiudersi: “Non sono più il vicerè. Io l’ho rappresentato solamente (depone lo scettro, si toglie la corona e il mantello). E anche voi avete rappresentato una felicità che non avete. Vero re è il sole, tiranno indifferente. È finzione la vita, melanconico teatro, eterno mutamento. Unica solida la cangiante terra, e quell’Astro immacolato là, cuore di chiara luce, serena anima […] sipario dell’eterno”. Qui la lucreziana giostra dei mutamenti fonomenologici si fonde all’originario immobilismo aristocratico paradigmato dalla mobilità dei registri logico – strutturali, pirandelliani, e avvolti nell’angosciosa indifferenza del lirismo leopardiano. Il motivo della luna, rivela ora ingrediente logico del percorso narrativo consoliano; infatti, innalzato in aree di sublimità lirico – razionale in “Lunaria”, era già presente nella opera adolescenziale “Triangolo e luna”, distrutto dallo scrittore. A differenza degli scrittori citati, la luna, nell’opera di Consolo, oltre alla insita accezione semantico – filosofica, diventa anche occasione di polemica contro ogni forma di imbrigliante istituzione, anche linguistica, utilizzata anche con l’obiettivo di creare un linguaggio letterario originale. Con tale opera, ridotta a forma dialogica di livello alto, e perciò non teatralmente rappresentabile, Consolo ha inteso rappresentare il tramonto di una cultura e di una civiltà. Lunaria è uno dei testi più ricchi di suggestione della drammaturgia contemporanea e insieme un capolavoro della letteratura del Novecento. Questo è Lunaria, favola scritta da Vincenzo Consolo, vincitrice nel 1985 del Premio Pirandello, realizzata in prima nazionale da Daniela Ardini e Giorgio Panni nel 1986 e successivamente realizzata in molte versioni in Italia e all’estero. La storia. In una Palermo di fine Settecento, una mattina il Viceré si sveglia madido e tremante: ha sognato che la Luna è caduta dal cielo e, una volta raggiunto il terreno, si è spenta, lasciando nel cielo un buco nero. La giornata del Viceré prosegue nella sala delle udienze dove arriva Messer Lunato, uno strambo viaggiatore in mongolfiera. A conclusione dell’udienza i ministri srotolano una mappa sulla quale sono indicati i possedimenti vicereali sul quale il Viceré fa scorrere il suo scettro che inspiegabilmente si impunta su una estrema Contrada senza nome. A questo punto la scena si apre sulla Contrada senza nome, dove alcuni villani guardano sorpresi la Luna che sta per sorgere e che appare insolitamente grande e colorata di rosso scarlatto. Dopo un po’ la Luna ritorna ad essere bianca e luminosa, ma comincia a creparsi e falde di luna cominciano a piovere a terra. Un Caporale ubriaco intima ai villani di raccogliere i cocci di Luna e di metterli in una giara, quindi ordina ad uno di loro, Mondo, di andare dal Viceré per riferire l’accaduto e chiedere istruzioni sul da farsi. La scena torna quindi a Palazzo Reale, dove è riunita l’Accademia dei Platoni Redivivi per disputare circa la malattia, lo sfaldamento e la conseguente caduta sub specie pluviae della Luna. Tra loro arriva Mondo che racconta l’accaduto, portando con se una falda di Luna come prova. Posto il coccio in uno scrigno, Mondo viene congedato e ciascuno degli accademici esprime la propria opinione sull’accaduto. Finita la disputa, nell’Accademia deserta dalle ante di un armadio esce il Teatro delle Bizzarrie: geni, fate, folletti, astri, pianeti, allegorie; quindi i personaggi fantastici spariscono a mano a mano, lasciando solo la Luna. Nell’epilogo si torna nuovamente nella Contrada senza nome, dove uomini e donne vestiti di nero seppelliscono i resti della Luna nella fontana e, di li a poco, assistono alla ricomparsa in cielo della Luna che, pero, tra i due corni della falce mostra una macchia nera. Giunge allora il Caporale il quale, deluso di ritrovare la Luna al proprio posto, inveisce contro i villani; viene pero interrotto dal sopraggiungere del Viceré, il quale sale una scala a pioli e incastra nella Luna il pezzo mancante, decretando che da allora in poi la Contrada senza nome si chiamerà “Lunaria”. La lingua e lo stile. Dal punto di vista linguistico Lunaria accosta stili diversi: dal narrativo al dialogico, dal lirico-poetico al linguaggio scientifico o pseudo scientifico degli usato dagli Accademici. Inoltre Lunaria, pur nella sua brevità, si configura come un crogiolo di lingue e dialetti. Sono facilmente riconoscibili l’uso dell’italiano nei suoi diversi registri: da quello accademico-scientifico, a quello visionario, mimetico, letterario, lirico, popolare; l’uso del siciliano, del dialetto gallo-italico, dello spagnolo di Dona Sol e degli inquisitori, del latino nonché di latinismi vari. Il Viceré e ricorre saltuariamente a tutti questi idiomi, compreso il dialetto gallo-romanzo, ossia il sanfratellano, tanto che a Mondo risponde parlando nella sua stessa lingua. Interi brani di poesia e versi “nascosti” compaiono in Lunaria. Lo stile si avvicina alla poesia come mai prima era avvenuto: il testo pullula di anafore, allitterazioni, rime interne. Si assiste cosi a una sorta di tendenza mimetica per cui al tema dell’intima necessita per il mondo della poesia (simboleggiata dalla Luna) corrisponde uno stile che si fa poesia. Il linguaggio si presenta talvolta oracolare, la forma espressiva risulta nervosa, essenziale: la parola si fa incantatrice e trascina il lettore nella “poesia” della vita. La critica letteraria.
Cosi Cesare Segre: “Uno dei lavori più mirabili di Consolo, Lunaria (1985). In esso c’è un abbandono pieno all’invenzione. Invenzione tematica e invenzione formale. Il libro non è certo un romanzo, ma appartiene piuttosto a un “genere che non esiste”, a un conato di teatralità divertita fra entremes alla spagnola e teatrino delle marionette. Si sa che molta dell’elaborazione di Consolo è “letteratura sulla letteratura”.
Ebbene, in Lunaria la falsariga è costituita da un racconto di Lucio Piccolo, L’esequie della luna (1967), con cui Consolo si pone felicemente in gara, non dimenticando naturalmente Leopardi. Voglio evocare un aneddoto sintomatico.
Quando Consolo mi mise tra le mani il meraviglioso libretto, e io mostrai di riconoscerne alcune fonti, invece di chiudersi nell’enigma mi procuro la fotocopia dei testi cui più si era ispirato, lieto che io ripercorressi i suoi itinerari. Mai come in questo caso la letteratura cresce su se stessa, e se ne vanta. Il lettore deve partecipare, come in un gioco, all’invenzione dello scrittore”. La regia. Lunaria è sempre una favola, la favola della luna, che vuole far sognare il pubblico affascinato da sempre dall’astro poetico. Per Consolo la sua caduta “rappresenta l’allontanamento della poesia dal mondo”, poesia che è invece illusione necessaria contro la precarietà della storia e della vita (Scende la luna; e si scolora il mondo, aveva scritto Leopardi ne Il tramonto della Luna). La regia di questo allestimento punta a riportare Lunaria ad alcune delle sue matrici originarie: il cunto e l’opera dei pupi. La tradizione infatti in Consolo si mescola arditamente all’elaborazione poetica e all’artificio letterario.
Un solo attore, Pietro Montandon, da voce e gesto a tutti i personaggi, partendo dall’essere in primo luogo il narratore-cuntista dell’opera. Un baule da teatro, un leggio e un praticabile palcoscenico su cui si “interpretano” i vari personaggi e la storia, citano insieme narrazione e teatro.
Consolo stesso asseriva che “le didascalie, pur conservando in qualche modo la loro funzione di indicazione mimetica e ambientale, vogliono assumere anche dignità di testo, sono insomma didascalie che ambiscono ad essere recitate da un eventuale personaggio (il Narratore)”.
Montandon prende per mano il suo pubblico e lo guida con ironia, ma anche con mano ferma e mente fredda nei meandri non sempre facili dell’opera di Consolo, facendolo assistere ad un gioco letterario, ma anche teatrale, che diverte con l’astrusità dei vari linguaggi, il paradosso di alcune situazioni (l’Accademia dei Platoni Redivivi che cercano di dare “spiegazione” alla caduta della luna), l’ironia di alcuni personaggi (Messer Lunato, Cerusici, Dona Sol, e altri), da emozioni con il linguaggio poetico del Viceré e la versificazione dei Villani e delle Villanelle, ultimi baluardi di un mondo dove rimane ancora la poesia. La scenografia disegna in modo astratto la corte del Viceré di Sicilia e la contrada senza nome. Il gioco musicale è arricchito da effetti sonori sulle tante voci di Montandon. L’attore Pietro Montandon per lunghi anni interprete nella compagnia Mummenshanz, con Lunaria Teatro straordinario interprete di Maruzza Musumeci di Andrea Camilleri e de Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello.
Nelle “Pietre di Pantalica” (1988) la storia della Sicilia, riemersa dal sipario della preistoria, e indagata fino ai crudeli anni recenti, dove la scrittura, immersa a captare tracce esaltanti del passato, preme all’interno della sottile rifrangenza delle reliquie e lo scrittore, nella memorabile pagina de suo diario, risulta testimone straziato del precipitare della sua isola verso ogni forma di dissacrazione di carattere morale e umana, che assurge a metafora della crudeltà e dell’iniquità del mondo. Ritornano le riflessioni pessimistiche e una storica catena di sconfitte, ma anche una rinnovata sfida della ragione, a cui è riconducibile il nucleo sotterraneo dell’anima e l’identità genetica dello scrittore. Un particolare successo ha riscosso la pubblicazione del romanzo “Nottetempo, casa per casa” (1992). In questo romanzo, Consolo affronta la storia dell’Italia, alle origini del fascismo, nei primi anni Venti. Qui il giovane intellettuale Pietro Marano, turbato dalle tensioni del primo dopoguerra, aderisce al movimento anarchico – socialista e, dopo aver subito le violenze delle squadracce del regime, attenta con una bomba al palazzo del barone don Ciccio, corrotto sostenitore del fascismo.
La dura repressione costringe Pietro ad allontanarsi dalla Sicilia e, lasciato il movimento anarchico, mentre abbandona la sua terra, in seguito ad una operazione di profonda riflessione, ripudia ogni forma di violenza, purtroppo generatrice in quel tempo di efferatezza, di crudeltà e di sopraffazioni. Nella quiete dell’esilio, recuperata una lucida razionalità, decide di ritrovare attraverso il racconto, le vere ragioni di tanto orrore. In questo nuovo romanzo, si registra in Consolo, una visione diversa della storia. Se la scelta finale del protagonista del “Sorriso dell’ignoto marinaio” era l’azione, ora lo scrittore ritiene che solo la letteratura può ricostruire, attraverso il disordine doloroso degli eventi, il vero senso della storia e dei suoi orrori.
È il trionfo della letteratura, attraverso cui soltanto si può ridare senso alla morte e ad ogni forma di aberrazione e di irrazionalità.
È il romanzo corale di una intera civiltà, dove nobili e contadini, artigiani, disertori ed emigranti, anarchici e squadristi, animano le umane vicende di una Sicilia che sta per essere travolta da tanto dolore e da tanto degrado umano. Lo scritto, anche se ambientato in un’epoca precedente, riflette anche la premonizione dello scrittore di un ritorno del crollo delle ideologie e il preludio di una nuova era di oscurantismo culturale, condizione da cui sono nate sempre nella storia le involuzioni istituzionali verso la apocalisse.
CAPITOLO 9
NOTTETEMPO CASA PER CASA,
METAFORA DELL’APOCALISSE
Nel romanzo Nottetempo, il contesto storico nel quale i personaggi operano (i primordi del Fascismo), infatti, è interpretato come una apocalisse storica che rischia di essere “nuda crisi”, catastrofe senza rinnovamento, che diventa metafora per il presente: l’inizio del Ventennio fascista, infatti, diventa anche il mezzo per parlare dell’inizio della Seconda Repubblica.
Lo stesso autore, chiarendo come il passato sia una metafora per il presente, evidenzia il carattere “apocalittico” di tale passato e tale presente: “Dopo il Sorriso, ho continuato a scrivere romanzi storici […].
L’ultimo, Nottetempo, casa per casa, si avverte nel presente, il senso di una fine che non prevede un nuovo inizio, mentre individua nel passato eventi apocalittici che hanno segnato un rinnovamento.
Con Nottetempo siamo, dunque, nella Cefalù dei primi anni Venti e un uomo corre forsennatamente nella notte, in preda al “male catubbo”, una forma di depressione in cui l’interpretazione popolare riconosce il licantropismo, o “male di luna”, come aveva già mirabilmente descritto Pirandello in una sua omonima novella. Egli è il padre di una famiglia tormentata dal male interiore, per cui il licantropismo ha ragioni ben più profonde.
La moglie (“troppo presto assente”) è morta e le due figlie sono affette da problemi psicologici: l’una, Lucia (“che sola e orgogliosa se n’andava per altra strada”), è mentalmente instabile e verrà rinchiusa in una clinica, l’altra, Serafina (“torbida, di pietra”, 106), vive in uno stato catatonico. Petro è il figlio degli eventi, che “mi sembrano terribilmente somiglianti a questi che stiamo vivendo, anni di crisi ideologica e politica, di neo-metafisiche, di chiusure particolaristiche, di scontri etnici, di teocrazie, integralismi […]
Il Sorriso e Nottetempo formano un dittico. […]
Nel primo ho voluto insomma raccontare la nascita di un’utopia politica, della speranza di un nuovo assetto sociale; nel secondo, il crollo di quella speranza, la follia degli uomini e la follia della storia, il dolore e la fuga” (Consolo, 1993:47-48).
Nel capitoletto La rinascita del Val di Noto, in Di qua del faro, Consolo descrive il terremoto che distrusse la Sicilia orientale alla fine del ’600 proprio usando il termine “apocalisse” e riconoscendo nell’arte barocca un valore escatologico: “E però il Barocco non è stato solamente il frutto di una coincidenza storica. Quello stile fantasioso e affollato, tortuoso e abbondante è, nella Sicilia dei continui terremoti della natura, degli infiniti rivolgimenti storici, del rischio quotidiano della perdita d’identità, come un’esigenza dell’anima contro lo smarrimento della solitudine, dell’indistinto, del deserto, contro la vertigine del nulla” (Consolo, 2001a:99).
Spiega Consolo: “Il padre si ammala di depressione, che nel mondo contadino arcaico viene chiamata licantropia.
Questo fenomeno è stato studiato dalla principessa di Lampedusa, che era una psicanalista che ha associato la licantropia alla depressione: nel mondo rurale questi poveretti che soffrivano terribilmente, uscivano fuori di casa, magari urlavano e venivano scambiati per lupi mannari” (Consolo, 2001b).
Il protagonista del romanzo è affetto dalla malinconia, da una tristezza le cui origini egli stesso rintraccia in un tempo primordiale, un tempo perso nel tempo, di cui il nome della famiglia, Marano, ne è spia: “Da quale offesa, sacrilegio viene questa sentenza atroce, questa malasorte?” si chiedeva Petro. Forse, pensava, da una colpa antica, immemorabile.
Da quel cognome suo forse di rinnegato, di marrano di Spagna o di Sicilia, che significava eredità di ànsime, malinconie, rimorsi dentro nelle vene” (42). E più oltre riflette ancora che quel dolore sembra essere sorto “da qualcosa che aveva preceduto la sua, la nascita degli altri” (106).
La famiglia del protagonista e Petro stesso sono chiusi nella propria incomunicabile individualità, esprimono solitariamente il “delirio di fine del mondo”, cioè la perdita della sua “normalità” . Il male che affligge la famiglia si intravede anche nel suo cambiamento di status, che verghianamente aleggia sulla famiglia come una rovina: il padre ha ricevuto infatti l’eredità di un signore locale che ha preferito beneficiare la famiglia Marano piuttosto che suo nipote, il barone Don Nenè, legittimo erede.
La menzione di questo avanzamento sociale, all’origine anche dell’inimicizia fra Petro e Don Nenè, viene lasciata cadere qua e là nel romanzo come fosse la colpa da cui discende tutto il male che gravita sulla famiglia. La ragione dell’impossibilità del matrimonio fra Lucia e Janu è riecheggiamento verghiano.
“Ho adottato questo nome perché ha due significati per me. Marano significa marrano, cioè l’ebreo costretto a rinnegare la sua religione e a cristianizzarsi, perché in Sicilia con la cacciata degli Ebrei nel 1492 – così come in Spagna, – ci furono quelli che andarono via ma anche quelli che rimasero e furono costretti a convertirsi. È stata una forma di violenza. Ho dato il nome di Marano a questa famiglia come memoria di violenza iniziale, cioè della cacciata degli Ebrei dalla Sicilia nel 1492, e poi per rendere omaggio allo scrittore Jovine che chiama il suo personaggio principale Marano ne Le terre del sacramento, quindi è un omaggio a una certa letteratura” (Consolo, 2001b). Verga, non a caso, costituisce modello forte e necessario per Consolo, non solo a livello tematico in quanto “cantore” degli umili e ultimi, ma anche come un grande sperimentatore linguistico rivoluzionario nella letteratura moderna, come Gadda. Lucia si innamorerà poi di un uomo che non più ritornato dalla guerra le procurerà la ferita fondamentale che la porterà alla pazzia; Petro riflette allora che Janu “quell’uomo buono, schietto, avrebbe forse rasserenato la sorella […], cambiato la sua sorte, e provò pena per lui, per Lucia, rabbia per quell’assurdo vallone che s’era aperto fra loro due” (63).
Ma su questo motivo verghiano della condizione di classe, si innesta quello della roba inteso come voracità di accumulo sconsiderato di beni; si instaura il dubbio che la vera causa della perdita della ragione, il dolore che porta alla pietrificazione, possa trovarsi in quell’accumulo, in quella roba: “Petro si diceva come sarebbe stato meglio per Serafina, per Lucia, non aver avuto nulla, essere incerte nella roba, ma salde nella persona, nel volere, coscienti e attive” (114).
Si percepisce qui anche una critica al capitalismo sfrenato e al consumismo, che è in definitiva accumulo di roba per la roba, senza altra finalità, per cui è radice di “malattia” più generale della società feticizzata, non più in grado di generare valori umani, ma si accascia su se stessa senza rinnovamento e nuovo significato.
Accanto ai Marano, compare poi tutta una sfilza di personaggi che ruotano attorno all’arrivo a Cefalù di un individuo alquanto eccentrico e realmente esistito, il satanista inglese Alastair Crowley, il quale si insedia in una villa poco fuori paese e lì celebra i propri riti, coinvolgendo diverse persone.
Le proteste contadine e le azioni degli squadristi fascisti, infine, connotano il clima storico e sociale all’interno del quale le vicende si muovono.
L’apocalisse consoliana si manifesta nel romanzo attraverso due movimenti opposti che si estremizzano disarmonicamente: da una parte un moto vano e dall’altra una stasi pietrificata che sospingono il reale oltre ogni limite, con reciproco annientamento. Osservare questa profonda realtà in un momento in cui l’individuo non riesce a creare valore e significato, conduce alla pietrificazione, alla stasi, all’impossibilità del dire, del rappresentare e del comunicare.
Nei poli dell’apocalisse consoliana si può riconoscere una degenerazione che concorre a formare la tragedia greca, oscillante tra il dionisiaco e l’apollineo. Il dionisiaco, che annulla la soggettività per scatenare gli istinti e le pulsioni vitali. L’apollineo, invece, è contemplazione, sogno, creazione di immagini, rappresentazione; nella tragedia è l’“oggettivazione dello stato dionisiaco” del coro, dunque la scena, il dramma. Nell’apollineo si intravede la qualità statica della contemplazione, di immagini nelle quali si riduce l’azione; l’interazione e l’equilibrio tra l’apollineo e il dionisiaco dona forma alla tragedia greca; Consolo, tuttavia, vede nella modernità la perdita di questo equilibrio e la perdita della forza creatrice dei due impulsi: il dionisiaco diventa disumanità, movimento falso, scatenamento di istinti bestiali.
“La rottura del rapporto tra intellettuale e società ha lasciato un vuoto, colmata da una comunicazione che è sempre impostura; è la voce del più forte, la verità falsata del potere”, disconnessa dall’umano, dalla dimensione del divino, e incapace di accostarsi ad una verità profonda; e l’apollineo è pura stasi, è l’essere intrappolati nella contemplazione di immagini di dolore.
Questi due impulsi generano in Consolo un presente, caratterizzato da una tragedia degenerata, priva di catarsi, priva di conclusione; egli stesso lo spiega a commento della propria opera: “l’anghelos, il narratore, non appare più sulla scena poiché ormai la cavea è vuota, deserta. Sulla scena è rimasto solo il coro, il poeta, che in tono alto, lirico, in una lingua non più comunicabile, commenta e lamenta la tragedia senza soluzione, la colpa, il dolore senza catarsi” (Consolo 1996:258).
In un’opera successiva, L’olivo e l’olivastro (1994), lo scrittore individuerà nella metafora dell’“olivo”, l’albero innestato, l’albero che nasce dalla cultura e dalla civiltà, e dell’“olivastro”, l’albero selvatico, un’altra metafora per esprimere il senso di perdita dell’armonia di due opposti impulsi che, come l’apollineo e il dionisiaco, dovrebbero formare il senso e il valore della civiltà, di un mondo umanamente abitabile: “spuntano da uno stesso tronco questi due simboli del selvatico e del coltivato, del bestiale e dell’umano, spuntano come presagio di una biforcazione di destino, della perdita di sé, dentro la natura e la possibilità di salvezza in seno a un consorzio civile, una cultura”.
Essi “non si combattono: al contrario, si completano. Essi si uniscono in lui [in Ulisse] armoniosamente come il ceppo materno e il ceppo paterno”. Ma il dramma della modernità, ciò che porta la che vive la propria apocalisse, è il sopravvento dell’olivastro sull’olivo: “Ecco, nell’odissea moderna è avvenuta la separazione tra il selvatico e il coltivato. L’olivastro ha invaso il campo” (Consolo, 1999:25).
Così l’olivo e l’olivastro non coesistono più armonicamente nel tronco della civiltà, portando questa verso il suo tramonto. In Nottetempo, il polo del movimento è rappresentato in primo luogo dall’inglese satanista, La Grande Bestia (666), che reca significativamente in esergo una citazione dall’apocalisse di Giovanni.
Aleister Crowley inscena un allucinante rito orgiastico che riecheggia l’Arcadia greca, la mitologia e il riconnettersi con un mondo antico e aureo, ma che nella realtà è una degradata imitazione di un rito dionisiaco. Il capitolo principia, infatti, con la descrizione di un ballo, che ci immette subito nella sfera del movimento inarrestabile. È Aleister, immedesimato in una ballerina, a compiere prodezze sostenuto “nella felice trascendenza dai vapori d’oppio, d’etere, di altri stupefacenti” (85). Il ritmo diventa sempre più incalzante, i lunghi elenchi che riempiono la pagina riproducono il “suono della vibrante cetra, dei cembali tinnanti, dell’acciarino acuto, del timpano profondo” (83) con cui si apre il capitolo; si veda, a titolo di esempio, questa lista di nomi che connotano l’essenza fittizia di Aleister, senza sosta, in un ritmo incalzante che toglie il fiato alla lettura e che sfocia in una vorticosa ubriacatura di parole: Consolo rende in tal modo, il senso di un vano agitarsi, in cui si identifica un sintomo di schizofrenia, connessa a uno stato epilettico, l’alterazione del movimento, il crollo dell’equilibrio del mondo.
Ma quando Janu, “this sicilian caprone” (80) – il satiro – rifiuta di prendere parte al rito orgiastico, e fugge, il movimento vorticoso si arresta; il cielo di carta pirandellianamente si squarcia e la messa in scena rivela il proprio carattere fittizio, scoprendo per un attimo la falsità della vita stessa che il rito attraverso il vortice del ballo cercava di occultare: “Declamò ancora più forte la danzatrice in terra. Restò immobile. Attese. S’era interrotta ogni musica, ogni nota, sospeso ogni sussurro, fiato, il silenzio freddo era calato nella sala” (88). Sentì ch’era sopraggiunto quell’attimo tremendo in cui cadeva dal mondo ogni velario, illusione, inganno, si frantumava ogni finzione, fantasia, s’inceneriva ogni estro, entusiasmo, desiderio, la realtà si rivelava nuda, in tutta l’insopportabile evidenza, cava si faceva la testa, arido il cuore. […]
Guardava il modo in quello stato, si guardava intorno, e ogni cosa gli appariva squallida, perduta. (89) Si rivela il rischio della stasi, ma Aleister chiede altra droga per ridiscendere nella condizione di trance e ricreare un mondo fittizio. Il capitolo, tuttavia, si chiude bruscamente con un altro svelamento, un altro squarcio che irrompe in questa realtà: l’annuncio che l’infante, il figlio di Aleister, è morto. Segue “tutto un irrompere all’aperto, un correre nella notte” (99), ma ovviamente invano, perché la stasi suprema, la morte, si è già impossessata della piccola Poupée. Nella scomparsa dell’infante è da leggersi, metaforicamente, la morte di ogni speranza e del futuro. È anche presentimento della “apocalisse” che si abbatterà un ventennio dopo su tutta l’Europa nella forma della Seconda Guerra Mondiale causata dai fascismi.
Aleister, infatti, rappresenta anche l’irrazionalità e la bestialità del fascismo, se è vero che intorno a lui si convogliano personaggi simpatizzanti e legati al fascismo, come il barone Nenè e la sua cricca, e che lo stesso inglese viene nominato come Superuomo, “colui che aveva varcato ogni confine, violato ogni legge, che aveva osato l’inosabile, lui, la Grande Bestia dell’Apocalisse” (90). Ed egli, nel tentativo di ricreare un mondo antico attraverso una messa in scena irrazionale, si fa simulacro del progetto di Mussolini e del Duce stesso, di colui che ha “varcato ogni confine” umano, reale e metaforico.
Per Consolo apocalisse è anche questa: l’andar oltre il limite, il troppo, il movimento che travalica il confine, come l’ultimo viaggio dell’Ulisse dantesco oltre le colonne d’Ercole.
In molti, infatti, hanno riconosciuto nei personaggi dello scrittore siciliano dei moderni Ulisse condannati a una continua peregrinazione dove non esiste l’Itaca a cui tornare – tema d’altronde, quello della perdita di Itaca, comune a molta letteratura moderna italiana, per cui il ritorno è sempre impossibile, a iniziare dal ‘Ntoni verghiano.
E proprio i personaggi del romanzo di Aci Trezza sono descritti da Consolo in versione propria.
In Nottetempo, la figura di Ulisse coincide con quella di Consolo stesso, testimone dello spaesamento e del peregrinamento dell’uomo moderno, descritto “in toni che a tratti si fanno apocalittici” (38), soprattutto quando lo sguardo cade sulle odierne devastazioni lungo il Mediterraneo.
Ne L’olivo e l’olivastro L’Ulisse consoliano è privo di connotazioni romantiche ed eroiche, divenendo anzi simbolo della sua folle ricerca di un superamento dell’umano e dei suoi limiti contingenti. Il tentativo di superamento dell’umano è anche sempre violenza disumana, bestiale. Il varcare le colonne d’Ercole si pone dunque per Consolo entro una dimensione etica che non riguarda più solamente l’individuo e il suo singolare confronto con la divinità, ma riguarda l’individuo in quanto parte di una comunità. In questo vediamo delinearsi la responsabilità del satanista inglese, Alaister che diventa emblema e portavoce di un modello di ricerca che sfocia nel disumano e che ha come vittima il più piccolo, nonché futuro, della comunità. La vittima, tuttavia, non è prevista dal rito e perciò non è sacrificale; essa, rimanendo legati al significato etimologico del termine, non entra nel regno del sacro e non si connette con una spiritualità superiore, ma rimane ancorata al senso profano, alla materialità terrena, non assume nessun valore superiore. È, dunque, attraverso il recupero del senso dell’umano che il movimento può ritrovare il suo giusto ritmo, senzaeccedere verso il limite dell’apocalittico, che è superamento dell’umano. La riflessione avviene in occasione dell’incontro tra Petro e Janu, che per tanti mesi era scomparso e ora appare cambiato. Pensò Petro a come si può cangiare in poco tempo, al tempo che scorre, precipita e niente lascia uguale. Petro, dunque, minacciato costantemente, come i suoi familiari, dal pericolo dell’arresto del tempo, scorge dentro sé una via diversa da quella del satanista inglese o del fascismo. Solo nel tempo umano c’è la possibilità di salvarsi dall’apocalisse. È questo il tempo della memoria, il tempo che può essere articolato dalla coscienza umana, il tempo entro cui può risiedere l’umano. È perciò anche progetto di scavo, archeologia del tempo, del passato da cui recuperare frantumi, frammenti di umanità. Il tempo che scorre umanamente è costantemente minacciato dalla possibilità di arresto. il rischio che lo scrittore corre e gravita sulla sua scrittura e su chi acquista la consapevolezza della realtà, declinata come male di vivere dell’uomo nel male dell’epoca contemporanea.
Consolo, rifiutando l’uso di un linguaggio comune troppo abusato, cioè la parola che danza ma non dice, cede il passo alla pietrificazione della parola. Ed è dunque su questo punto il cruccio della sua scrittura che paradossalmente urgente non è più possibile dire che si pietrifica in un’unica immagine di sofferenza. Nella figura della Gorgone non si proietta semplicemente il presente, ma il dolore, la realtà profonda che soggiace a ogni esistenza nel male di vivere e nel senso di verità e di dolore che Consolo sente di non poter più praticare con una lingua tarata da forme vuote, consapevole del rischio di pietrificarsi, fissando la medusa.
In Nottetempo Petro svolge l’inseguimento notturno nei confronti del padre affetto dal “male catubbo”, il licantropismo, fenomeno dell’uomo tramutato in lupo, che trasferisce nel regno delle metamorfosi. Tutto in Nottetempo sembra essere sull’orlo della pietrificazione: personaggi, azioni, eventi, il tempo, la scrittura. Esistono differenti storie e tradizioni in letteratura, come il racconto che fa Ovidio di Licàone, trasformato in lupo da Giove perché progettava di uccidere il dio. Lui fugge, atterrito, e raggiunti i silenzi della campagna si mette a ululare: invano si sforza di emettere parole” (Ovidio, 1994:15).
E dopo Giove invocherà l’apocalisse: la distruzione del genere umano, perché indegno, corrotto e criminale. Fanno da contraltare le urla disumane, suoni che spesso non si articolano in parole intellegibili (come gli ululati del lupo mannaro) e che esprimono al pari del silenzio il dolore umano; molte volte l’urlo e il silenzio si ritrovano insieme come due espressioni dello stesso concetto di sofferenza.
Molti sono gli esempi sparsi nel testo, tutte espressioni di sofferenza e legate alla consapevolezza della sofferenza, alla sua contemplazione che sottrae l’azione e la parola.
Già nel Sorriso dell’ignoto marinaio (1976) era presente l’idea della pietrificazione come espressione del male, essa però era legata a una contingenza – i cavatori di pomice – che diventava metafora per una sofferenza più generale, quella degli ultimi: “Male di pietra continuò il marinaio. È un cavatore di pomice di Lipari. Ce ne sono a centinaia come lui in quell’isola. Non arrivano neanche ai quarant’anni” (Consolo, 2010:8).
Ma successivamente in L’olivo e l’olivastro la metafora “male di pietra” si approfondisce e diventa l’ossessione costante con cui dire la sofferenza umana. Nelle pagine iniziali ritornano i cavatori come a stabilire quel paragone, fondare quella metafora della pietra che poi diventa il nucleo lessicale fondamentale per esprimere il dolore: “[…] entrò nelle caverne della pomice, parlò con i cavatori silicotici […] Erano secchi e grigi i cavatori, avevano denti corrosi dalla polvere, prendevano anelettici, cardiotonici: cresceva dentro loro poco a poco una corazza di pietra, il cuore s’ingrossava, si smorzava il fiato, si spegneva” (Consolo, 2012a:26-27). E qui in questo testo allora abbondano non tanto – o non solo – espressioni diverse che indicano l’impossibilità del dire e del fare, quanto piuttosto in maniera più specifica lemmi legati alla radice “pietra”. La pietrificazione è legata all’esperienza personale, alla scrittura, ma anche alla società. Consolo attribuisce alla Sicilia, che sta sempre in rapporto sineddotico con la società, quell’impulso alla pietrificazione come forma generale, lo stadio che blocca la vita, la congela, la pietrifica” (Consolo 1977:1).
E la Sicilia sembra, per lo scrittore, bloccata “in questo limbo, in questa metafisica paralisi”, unica reazione con cui ha controbattuto il movimento artificiale, del quale ne diviene simbolo l’autostrada, “moderno feticcio dell’accelerazione spasmodica”.
E pure qui la contrapposizione si ritrova anche sul piano della comunicazione, poiché in questa Sicilia “sequestrata e pietrificata” chi ha cercato “di fare e di dire”, cioè di cambiare la situazione, è stato costretto al silenzio e sulla lunga tradizione letteraria isolana, da Verga a Sciascia, ora domina “la parola vuota, l’inutile incanto, la retorica” (Consolo, 1977:1).
In Petro e nella famiglia Marano l’arresto e la catatonia concretizzano la metafora di “folla pietrificata” in una società sull’orlo dell’apocalisse.
CAPITOLO 10
LA TORRE DELL’URLO E DEL SILENZIO
Le sorelle di Petro, come abbiamo già accennato, sono chiuse e sprofondate nell’impetramento dell’anima e del corpo. Serafina, col nome programmatico di chi non appartiene a questo mondo e di chi ha una pace che non è terrestre, è immobile in uno stato quasi catatonico, persa in vagheggiamenti religiosi che non hanno più alcun referente nel contingente. L’altra sorella, invece, Lucia, cade in una pazzia che prima ancora di essere assenza e distanza è urlo innaturale, parole sconclusionate, perse in un passato disordinato e non recuperabile. In Lucia, infatti, si racchiude anche il tema fondamentale del recupero del passato, ma un recupero che fallisce. Il ricordo delle ferite che riemerge in lei è un ricordo che riproduce meccanicamente il trauma ma non lo supera mai; Lucia, al contrario della sorella, è visibile, agisce, ha una personalità forte e inquieta, va per la campagna con il fratello Petro e l’amico Janu, è promessa sposa; ma il giovane che ha chiesto la sua mano non torna dalla guerra. In quel dolore Lucia si chiude, si pietrifica, ma esplode in urlo piuttosto che cadere nel silenzio, esplode in suoni che non possono articolare e razionalizzare quel dolore: “Finché un giorno, un mezzogiorno che Petro tornava dalla scuola, non si mise a urlare disperata dal balcone, a dire che dappertutto, dietro gli ulivi le rocce il muro la torre la sipale, c’erano uomini nascosti che volevano rapirla, farla perdere, rovinare” (46). E poco oltre: “Lanciò improvviso un urlo e scappò via, si mise a correre, correre per il sentiero, come presa da frenesia, da tormenti” (47). È la fuga di Lucia oltre il limite dell’umano, eppure anch’ella è figura statica, immobile, figura che s’impetra nel dolore e lo fissa perdendo la capacità di vedere altro e cioè anche la capacità di creare e vedere altre visioni apollinee: rimane una sola visione senza dramma e in essa Lucia si ferma.
Così ecco che anche il suo nome acquista pregnanza, nel momento in cui il testo ci ripete insistentemente nello stretto volgere di un paragrafo che Lucia – che vuol dire luce ma che è anche patrona dei non vedenti e degli oculisti – non vede più, è diventata cieca nella fissità: “La portò via da casa […] perché si dissolvesse in lei l’idea fissa. […] Ma era come lei non vedesse […] era come se avesse gli occhi sempre altrove, fissi dentro un pozzo” (47) – dove quel “pozzo” sta per la profondità del dolore. Lucia è anche figura pietrificata in quel suo guardarsi continuamente allo specchio, atto autoriflessivo che non comunica con il mondo esterno ma ricade sulla persona medesima; ella fissa se stessa e la sofferenza che ha guardato con i propri occhi ora riflessi allo specchio. Atto solipsistico e chiuso, come chiusa è lei nella propria camera: “E stava ore e ore chiusa nella stanza, avanti alla toletta a pettinarsi, in incantesimo, il guardo trasognato, perso nel guardo suo di fronte dentro lo specchio” (46).
La sofferenza familiare si racchiude metaforicamente nella concretezza della “torre”, ovviamente fatta in pietra (“la sua voce roca sembrava vorticare per le pietre della torre” (37), che assurge a simbolo di chiusura e solitudine – torre è quel tipo di edificio caratterizzato da una dimensione in altezza nettamente maggiore rispetto alla dimensione della base e che dunque si isola rispetto alle costruzioni circostanti; torre per antonomasia è quella di Babele, dove regna il caos, il disordine e la confusione, principio delle lingue diverse che impedirono all’uomo di comunicare l’uno con l’altro(12).
Nella torre dove sono chiusi i membri della famiglia Marano la comunicazione non è possibile, le parole non assumono un significato che possa essere compreso dagli altri, decifrato: “Pietà, pietà’ implorò in quella solitudine sicura, dentro quel rifugio della torre, quel segreto oratorio d’urla, pianto, sfogo” (38). L’urlo è il simbolo di questo dolore, sfogo inarticolato, contraltare del silenzio: “nella segreta sua torre d’urla” (51), “E nella torre ora, dopo le urla, il pianto”.
L’urlo, come il silenzio, è una comunicazione bloccata. Petro allora si rende conto che è necessario recuperare le parole per uscire dalla torre. È questo un momento fondamentale del testo, che è sia riflessione sulla sofferenza umana sia sulla scrittura cui è affidato il compito di esprimere tale sofferenza.
Nottetempo è allora anche e “innanzitutto la storia di una vocazione alla scrittura” (Traina, 2001:92). Il tentativo di uscire dalla torre di pietra e scongiurare l’afasia si pone come uno dei temi centrali del testo. Attraverso questo percorso del protagonista, si assiste anche alla lotta che lo stesso Consolo conduce per non cadere nell’impetramento della scrittura, nell’impossibilità del dire, del parlare, nell’apocalisse della parola. Nottetempo è anche romanzo autobiografico, perché la storia di Petro, la sua uscita dalla torre, è anche il viaggio intellettuale dello scrittore Consolo.
Nel protagonista del romanzo nasce il desiderio di uscire dalla torre ricomponendo un linguaggio attraverso cui poter di nuovo comunicare una realtà e riconnettersi con essa.
Così scandì a voce alta: “Terra. Pietra. Sènia. Casa. Forno. Pane. Ulivo. Carrubo. Sommacco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna. Mura. Ficodindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza. Colomba. Fringuello. Nuvola. Sole. Arcobaleno […]” scandì come a voler rinominare il mondo, ricreare il mondo. (38-39). Questo elenco precede quello che poi ritroveremo nelle pagine dedicate al rito satanico di Alaister e si pone su uno stesso piano di complementarietà: come quello nasceva dal movimento artificioso del dionisiaco degenerato, questo nasce dall’impetramento afasico dell’apollineo degenerato. In entrambi la parola è mimesi del gesto: lì c’è la ricreazione del movimento, in cui il segno della virgola dà il senso del ritmo della danza e della musica, qui c’è la riproduzione della stasi, marcata dal punto che segue ogni parola e che indica la pausa, una cesura di tempo e di spazio, la difficoltà dell’esprimere una parola dietro l’altra, l’inarticolazione di un discorso.
E se là il vortice delle parole serviva a confondere, ad allontanare dalla realtà, qui c’è l’avvicinamento, o per lo meno il tentativo di avvicinarsi a qualcosa che si è perso da tempo – o mai avuto. È un elenco di parole semplici, in cui tuttavia si può riconoscere una catena logica di riferimenti che dalla terra vanno al cielo, dalla “pietra” al senso di libertà del volo degli uccelli e alla luce del sole.
Attraverso questo “rinominare il mondo” Petro cerca di riattivare un legame con la realtà, Consolo, attraverso il personaggio di Petro, ci descrive allora il viaggio verso l’esaltazione dionisiaca, che qui altro non è che volontà e capacità di esserci ancora, di agire in questo mondo – e di scrivere, di dire. Assistiamo così all’uscita metaforica di Petro dalla torre, alla sua presa di coscienza politica (che passa tramite lo sputo al barone, l’amicizia con il Miceli, la partecipazione alle manifestazioni di piazza, l’“oltraggio” subito e infine l’attentato perpetrato) e alla promessa, a fine romanzo, di una nuova scrittura attraverso cui sciogliere il grumo del dolore.
Questo è anche il percorso intrapreso dal Consolo scrittore, che approda alla tragedia di Catarsi (1989) come simbolo di un modo di scrivere. Allora in Nottetempo, bisogna leggere questo approdo al canto del coro della tragedia, approdo di Petro dietro cui non sarà difficile riconoscere il percorso della scrittura e della poetica di Consolo stesso, teso tra il rifiuto della parola vuota e l’attrazione per quel silenzio che racchiude tutto il dolore. Petro è dunque il personaggio che incrocia tutti e tre i piani tematici su cui si dispone il romanzo e su cui si dispiega il senso dell’apocalisse: quello esistenziale, quello storico-culturale e quello della scrittura.
A livello narrativo egli funziona come elemento unificatore di questi piani e, a livello contenutistico, si configura come chiave per trascendere il pericolo dell’apocalisse nel valore che possa rinnovare i mondi (quello interiore, quello sociale e quello letterario) infondendo loro nuovo significato.
Più che romanzo “apocalittico”, dunque, Nottetempo è romanzo del “rischio della fine” e dell’inserimento di tale rischio in un’ottica che ne accenni e ne indichi il superamento e la reintegrazione.
“L’olivo e l’olivastro” (1994) è un libro al di fuori dei consueti canoni di scrittura. Il protagonista non ha un nome, ma può essere individuato, nonostante l’uso della terza persona, nell’Io narrante dello stesso Consolo.
Due sono i grandi temi, apparentemente divergenti, ma che in realtà costituiscono un motivo unico del viaggio del narratore per la Sicilia, sulla scia del naufragio collettivo; come “L’olivo e l’olivastro”, nati dallo stesso tronco, hanno destini diversi, così il primo percorre i luoghi epici di Omero e dei Malavoglia, alla scoperta di civiltà millenarie, comunità immaginarie e mestieri perduti, e rappresenta l’ulivo (che richiama al mito dell’Odissea, quando Ulisse, distrutto dal vano peregrinare, si rifugia nell’isola dei Feaci e si ristora sedendosi sotto un albero di ulivo, accanto a cui cresce l’olivastro), simbolo di una Sicilia innalzata al sistema della ragione, che rievoca amori e passioni.
L’olivastro (a volte scatenamento di matta bestialità) rappresenta, invece, quella moderna dello sfacelo architettonico, ambientale e sociale, la nuova Sicilia, flagellata da episodi di rimbarbarimento, di perdita di identità, di orrori, di inquinamento, come quello provocato dalla costruzione della raffineria di Milazzo, dove prima sorgevano sterminati campi di gelsomino. Ad una terra che soffre il dramma storico della disoccupazione e vive nell’eterna tensione della più assoluta precarietà e dell’inappagamento, si contrappone un Nord, dove la tendenza a ridurre l’uomo a mero strumento di produttività, ha ridotto gli spazi di libertà ed ha creato altre condizioni di infelicità, come traspare in questi anni, senza alcuna possibilità di finzione. La Sicilia dalle due anime, rappresentata tra viaggio della memoria e discesa nel labirinto della pietà, viene riscattata dall’immagine della negatività assoluta, nella riaccensione finale della straziante utopia, che fiorisce negli interstizi della catastrofe storica e della selvatica bestialità dell’isola mediante l’illusione della salvezza attraverso la cultura, ereditata dalla civiltà greca e ancora viva nella forza del pensiero. Ora il linguaggio è percorso da una più accentuata tensione poetica che sembra accarezzare gli stupri storici e ecologici, con cui la Sicilia ha pagato il prezzo di un’illusoria industrializzazione, con lo scempio del suo incantevole paesaggio, che continua a vibrare nei ritmi del melodico periodare.
Il romanzo “Lo spasimo di Palermo” (1992) è un “nòstos”, il racconto di un ritorno, quello del protagonista, lo scrittore Gioacchino Martinez, ai luoghi odioso – amati della sua infanzia e della giovinezza, Palermo e la Sicilia.
Ambientato nel periodo dalla fine della guerra ai nostri giorni, su una linea di evoluzione cronologica del pensiero di Consolo, l’opera contiene al suo interno, il romanzo della Sicilia e dell’Italia – tra Milano e Palermo – dell’ultimo mezzo secolo, in un flusso della memoria tra i mali della storia individuale e collettiva fino alle ben note cronache, dell’assassinio di un giudice, a cui si contrappone la storia letteraria d’Italia, caratterizzata da tanta letteratura siciliana.
Emblema del romanzo è la chiesa di S. Maria dello Spasimo, oltraggiata nei secoli ed ora restaurata, ed il quadro di Raffaello ivi dipinto, che mostra lo sgomento della Vergine di fronte a Cristo in ginocchio sotto la croce, in un simbolico atteggiamento di implorazione e di pietà per la perdizione dell’uomo di questi anni, che ha smarrito la rotta dell’identità di nobile creatura.
C’è il romanzo di Gioacchino Martinez e suo padre, ucciso dai nazisti, il romanzo di Gioacchino e suo figlio, esule a Parigi per la sua adesione al terrorismo politico, c’è il romanzo d’amore di Gioacchino e Lucia, dolcissimo e disperato fino all’annegamento nella follia.
C’è il fluire romanzesco della vita verso l’oblio, da cui si salva la voce immortale della poesia, ricantata nelle pagine dei più grandi scrittori, consegnati dalla memoria all’immortalità del futuro, in una sorta di utopistica sopravvivenza della sublimità della letteratura, di cui Consolo avverte di essere fibra consustanziale, già preannunciata in “Nottetempo, casa per casa”. Ne deriva una struttura, lontana da un prefissato schema narrativo, ma formatosi per sovrapposizione di circolari frammenti, disorganicamente ricomposto in una sfuggente dimensione spazio – temporale. Sui fotogrammi di violenze, sopraffazioni e fratture della storia di una pena lacerata, dilaga il regno del silenzio, in cui galleggia il protagonista – scrittore schiacciato dall’inefficienza pragmatica e dalla vacuità della parola, evirata di ogni vitalismo propulsivo.
Emerge sul destino sociale e sul racconto del dolore e del silenzio, l’operazione della scrittura sperimentale del protagonista, che, però, si interrompe con l’ultima esperienza della sua vita. Allora decide di tornare alla sua isola, dove muore, come un Ulisse ucciso dai Proci, cioè dai pirandelliani “giganti della montagna”, senza volto e senza ragione, metaforicamente i sacri mostri del nostro tempo, che hanno devastato storia, memoria e tutto. Sono gli anni straziati della violenza del terrorismo e della mafia, in cui Gioacchino, dopo aver tentato la rivolta, nell’ambito della scrittura distruggendo le convenzioni letterarie, responsabili dello “sfascio” sociale, è condannato alla sconfitta, anche della scrittura.
Anche la chiusura del romanzo, con l’uccisione del giudice Borsellino, nel luglio del 1992, risulta desolatamente pessimistica e sancisce la sconfitta della ragione di fronte alle barbarie della società post-moderna.
La narrativa di Consolo, come quella di Sciascia, è pervasa da un forte sentimento civile che vede l’intellettuale misurarsi con i più sconvolgenti eventi della storia e misura la possibilità di incidenza della letteratura sugli ingorghi delle vicende della nostra Sicilia. Ma se lo scrittore nel suo ultimo romanzo abbandona l’intreccio del romanzo, rimpiange di non avere il dono della poesia, attraverso le cui forme di comunicabilità è possibile ritrovare ed esprimere la logica del mondo.
Dal punto di vista strutturale, i romanzi di Consolo risultano molto intrecciati sia sul piano spazio-temporale, che sulla linearità della fabula, su cui s’intrecciano documenti e citazioni, flussi di coscienza e lacerti di un intenso lirismo, in cui le oscillazioni interiori del personaggio diventano le occasioni poetiche dello scrittore. Il lettore non è guidato da un trasparente filo conduttore, ma tra le geometriche rappresentazioni delle cose e dei sentimenti, nel sedimentarsi di fratture logiche e spiralizzazioni immaginifiche, sorrette da una straniante tecnica-linguistica orchestrata da un lucido razionalismo descrittivo di stampo illuministico, può trovare un collegamento tra spazio letterario e spazio comunicativo, tra procedimento logico e dialogico della narrazione, un modo di superamento delle diverse innovazioni artistiche, infarcite di stilemi e lessemi arcaico-letterarie-dialettali, che risentono della lezione di Gadda, sempre tesa al sublime e al tragico, binomio inscindibile che solo nella poesia ritrova la sua armonica funzionalità.
La vocazione intellettuale di Consolo si manifesta fin dal 1952 quando si allontana dalla Sicilia per andare a studiare Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano, dove nella creazione letteraria affiora la cultura meridionalistica e neorealista come avviene per altri scrittori conterranei della diaspora. Nel suo primo soggiorno milanese egli coltiva dentro di sé un modello di letteratura rappresentato dalla realtà contadina e una tipologia espressiva di stampo sociologico e di facile comunicatività ma già ne “La ferita dell’aprile” e nella produzione successiva, a partire dal “Sorriso dell’ignoto marinaio”, s’impone una scelta di scrittura iperletteraria, attraverso sui, da un lato lo scrittore si colloca accanto alla sperimentazione di Gadda e di Pasolini, dall’altro include l’utopia vittoriana di giustizia che rimarrà antagonistica con gli sviluppi involutivi della storia della sua Sicilia.
Allora incomincerà quella costante discesa di un siciliano nelle drammatiche pieghe dolorose della sua terra vilipesa nella sua dignità e nei suoi diritti dal sedimentarsi di regimi oppressivi, per cui il viaggio rappresenta il tema archetipico del “nostos” ricorrente anche nelle opere successive, come nelle “Pietre di Pantalica”, dove il viaggio si manifesta come immersione totale dell’anima fino alle più ataviche radici della storia siciliana, alla riscoperta di una identità italiana, eterna ed assoluta, fino all’“Olivo e l’olivastro” e alla storia disperata del popolo siciliano, scandita ne “Lo spasimo di Palermo”, dove la rivisitazione di una tragedia storica viene letta nei protagonisti, trucidamene seppelliti nei gorghi di un tempo di spaventosi orrori. Come ha sottolineato lo stesso Consolo, la sua narrativa riveste “romanzi di ritorno all’isola” e deve essere interpretata come resoconto di un’esperienza di viaggio; “L’olivo e l’olivastro”, infatti, è un diario, tra narrativa e saggistica, in sintonia con la concezione estetica di Consolo, del ritorno doloroso in una Sicilia, “terra di tanti mali”, del passato, mescolati alla devastazione dei valori umani del presente, ma anche utero materno, in cui si agitano nuove ostinate speranze, assieme all’urgenza di nuovi doveri, ma dove l’Ulisse consoliano conclude il suo viaggio, senza ritrovare più simboli per l’umana redenzione, perché la terra della memoria è stata radicalmente devastata dallo scempio di tanti Proci imbestialiti, che l’hanno ridotta a rovine.
La conclusione di una Sicilia irredimibile, dove l’isola può essere paragonata alla Troia incendiata di Omero, rappresenta anche l’incupirsi della visione consoliana, che coinvolge l’intera storia italiana, infatti, lo scrittore Gioacchino Martinez, per sfuggire allo sfacelo politico e socio-culturale di una invisibile Milano, dove si era recato alla ricerca di nuovi spazi di civiltà, come Vittorini di “Conversazione in Sicilia”, è ridisceso nella natia Palermo, ora mortalmente imprigionata nella spirale della violenza e del malaffare.
In questi ultimi anni lo scrittore tace. La sua vana creatività sembra essersi prosciugata nella inguaribile ferita della sua isola. Tuttavia, non si arresta la sua attività pubblicitaria, in cui continua a denunciare le devianze e la barbarie dell’Italia contemporanea. La sua pena di vivere, tuttavia, scorre in maniera autobiografica nelle pagine del testo “Madre Coraggio” (in cui viene evocata idealmente la madre di Vittorini), Consolo scrive: “E qui, al sicuro, nel mio Paese, nella mia casa, appena tornato dal viaggio in Israele/Palestina, per le atroci notizie che arrivano, per le telefonate giornaliere con Piera un’italiana sposata a un palestinese, chiusa nella sua casa di Ramallah, priva di luce, di acqua, sento l’inutilità di ogni parola, la sproporzione tra questo mio dovere di scrivere, di testimoniare della realtà che abbiamo visto, delle persone che abbiamo incontrato e la grande tragedia che si stava svolgendo laggiù”. Il suo negativismo storico si è esteso ai popoli dell’intero pianeta, ma la necessità di testimoniare sopravvive intatta per poter consegnare al futuro dell’umanità la memoria di un tempo apocalittico.
L’attuale silenzio narrativo dello scrittore è stato interpretato come convinzione dell’impossibilità della letteratura di poter redigere un’immagine credibile del mondo, per il fatale estinguersi dell’utopia che nella tradizione letteraria siciliana si è opposta all’omologazione delle riflessioni e della stessa scrittura, travolgendo gli eroi verghiani, vittoriniani e sciasciani. Infatti, nella nuova generazione di scrittori, sembra aprirsi ad un dialogo con le letterature nazionali e internazionali, dove dato esistenziale e denuncia disillusa del gattopardismo convivono armonicamente nell’attuale classe dirigente siciliana, verso la quale Consolo ha espresso, sia in letteratura, sia nella sua attività pubblicistica e nel suo impegno personale, il suo disgusto e la sua convinta condanna.
CAPITOLO 11
ESERCIZI DI CRONACA
Dopo la laurea in legge e la pubblicazione del suo primo romanzo “La ferita dell’Aprile”, incominciò la sua collaborazione. su invito dell’allora direttore Vittorio Nisticò, al coraggioso giornale “L’Ora”, la cui lettura giovanile delle drammatiche vicende di cronaca e dell’atavica schiavitù del popolo siciliano ad un destino fatale di rassegnazione e di dolore, lo vide impegnato nella rubrica: ”Fuori casa”.
Con l’agenda del cronista in mano, resocontò casi particolari di cronaca quotidiana, sequestri di persona, orribili delitti, lo scempio delle selvagge speculazioni edilizie, soprusi su gente inerme, abusi politico-amministrativi, inganni della potente burocrazia, struttura istituzionale della incolta e rapace classe dirigente, riuscendo a svelare i reconditi intrecci di interesse tra olitici e criminalità organizzata, alimentando una galoppante angoscia interiore per la disperata condizione interiore della popolazione della sua isola, che lo indusse ad allontanarsene per non essere soffocato, come tanti altri intellettuali meridionali, condannati alla sofferenza e al disagio economico, alla ricerca al Nord industrializzato in un clima migliore per sopravvivere e scrivere. Come scrive Quasimodo, “l’uomo cerca dovunque la sorte di una patria”, e Consolo divenne il cronista-scrittore, emblema della diaspora, spesso spinto a ritorni frequenti discese agli Inferi della sua isola, per verificare la realizzazione di promesse politichese di indizi di rinascita, ma ad ogni discesa annotava sul taccuino del cronista, scempi e disfatte, solitudini strazianti, saccheggi del denaro pubblico, delitti d’interesse, oltraggiosi incursioni su persone avvilite nella propria dignità, tragedie familiari per la scalata al potere subdolo nei vari quartieri, orrendi episodi di cronaca nera, di cui erano vittime designate, negozianti e possidenti, vessate dall’avidità degli “esattori” della criminalità, spesso costretti a cedere la loro attività economica e a tacere, per le minacce di rappresaglie di ogni genere anche ai familiari degli sfruttati e saccheggiati di ogni bene. Insomma, ad ogni discesa, Consolo progressivamente soffriva nella constatazione della sua terra galleggiante in un turpe panorama di iniquità, violenze pubbliche e private, di cui erano bersaglio anche le donne oneste, renitenti alla libidinosa avidità sessuale, prevista come segno di orgoglio nel codice dei capi, riflesso di sfiducia, rassegnazione e morte delle idee e dei sentimenti di una Sicilia, nel lontano passato, ricca di umanità, di valori morali, di cultura che era stata denominata “Magna Grecia”, ora genuflessa con oltraggio al sadismo politico-mafioso, sempre in piena attività delittuosa tesa a smerigliare e disfare il naturale codice etico di un popolo, sopravvissuto nella sua elevata valenza di valori.
Tutto nella sua terra continuava a vivere nel lungo sonno, ben spiegato ne “Il Gattopardo” da don Fabrizio a Chevalej, inviato dal nuovo governo unitario per comunicare al Principe la nomina (rifiutata) a senatore della nuova Italia. Come quando esordì come cronista nel quotidiano palermitano, di fronte all’immobilismo sempre vivo, come quando correva alla stazione ferroviaria di Sant’Agata Militello, per prendere il suo giornale, stampato a Palermo, che riportava notizie e analisi dolorose di cronaca nera, tesa ad informare e responsabilizzare la coscienza dei lettori sulla reale condizione di cosificazione in cui ristagnavano con amarezza, ma afasici ad ogni impulso di ribellione. Allora le sue cronache giornalistiche diventavano letteratura. L’impatto con eventi sanguinosi, con truci dazioni di sindacalisti e con la “morte bianca” di giornalisti, che avevano avuto il coraggio di rivelare sulla stampa, particolari modi, motivi e nomi dei responsabili di incredibili delitti, che lottavano per il riscatto del mondo contadino e in difesa del diritto al possesso delle loro terre, bagnate dalle lacrime e dal sangue, in rischio i confisca ed espoliazioni, fecero capire al giovane Consolo, quanto fosse difficile, in Sicilia, esercitare il mestiere di giornalista. Andare in giro con il taccuino di cronista in mano, resocontare sul processo del “mostro” di Trapani (responsabile del sequestro e della morte delle tre bimbe gettate in un pozzo), o il caso del sequestro Corleo, il potente esattore siciliano imparentato con i De Salvo, il viaggio all’interno degli uffici deserti della regione e del Comune, dove nei registri anagrafici i vivi risultavano morti e i morti rinascevano, secondo gli interessi dei funzionari, che assegnavano per i propri interessi contributi e pensioni ai disperati poveri cittadini o creavano difficoltà burocratiche agli emigranti, fecero scoprire al cronista i valori eterni e inossidabili di una Sicilia antica, i segreti di una realtà più profonda, sotto la violenta maschera obbrobriosa della sanguinaria ferocia dell’episodiità quotidiana. La collaborazione a “L’Ora”, (iniziata il 4 febbraio del 1964, continuò fino al febbraio del 1972 anche da Mlano) con interviste e recensioni, soprattutto all’uscita di ogni libro di Sciascia (Da “Le parrocchie di Regalpetra”, a “Porte aperte” (9-1-1988). Interessanissima è la visita a Stefano D’Arrigo, di cui spiega la tecnica di lavoro nel labirintico intreccio di Horcynus Horca. Non sfuggono all’attenzione del sensibilissimo scrittore i molteplici aspetti della Città opulenta che, accanto al dilagare del terrorismo e dello stragismo brigatista, almanacca eventi clamorosi di morte, come la morte dell’editore Giangiacomo Feltrinelli o il licenziamento di un operaio napoletano perché parlava nel suo dialetto con i compagni di lavoro in una fabbrica. Partecipa agli eventi più importanti di autori siciliani e informa e commenta con raffinata penetrazione ed entusiasmo le mostre a Milano di pittori meridionali come Caruso, Guttuso, Migneco, Carpinteri, ed altri.
Nell’estate del 1975, l’esule inquieto è ancora una volta in Sicilia per frugare nei misteri dei sequestri di Salemi, nei paesi poveri e distrutti della Valle del Belice, o nelle segrete minacce che ostacolarono la rivelazione della verità nel processo “Vinci”, terribile metafora di una Sicilia divenuta “Cava della morte” di ogni certezza. Tra tanto doloroso oscillare spazio-temporale Nord-Sud, nei meandri della cronaca, lo scrittore riesce a ricucire, nel suo tormentato universo interiore per le sorti disumane e tragiche della sua terra, le indistinte schegge per la nascita di una speranza.
Allora lo scrittore si immergerà nel lavoro di perfezione del suo capolavoro “Il sorriso dell’ignoto marinaio” che nell’erudito barone Enrico Pirajno do Mandralisca, convoglierà svampi di riscatto da una storia infame, quando, dopo la scoperta dell’impostura della letteratura, le parole nuove imbevute nella scrittura saranno riempite di cose e diventeranno l’elemento propulsore di una consapevolezza che, se non cambia il mondo, diviene “una difesa contro la ferita dell’impotenza.
Il Consolo meridionalista ricercò sempre, attraverso la raffinatezza della scrittura, un qualche strumento di risorgimento del popolo siciliano, ma, pur essendo pervenuto alla conoscenza della tragedia meridionale, potè lottare solo con le armi spuntate della letteratura, un percorso che egli seguì nelle possibili stazioni temporali, ma che non potè concludere se non nel sogno delle sue illusioni di scrittore e di “poeta della storia”, perché anche oggi la Sicilia è più incartata nel dolore e nell’orrore di una società che, mutatis mutandi, è rimasta immobile con più gravi e irredimibili problemi.
CAPITOLO 12
VINCENZO CONSOLO E LA SICILIA
“Più nessuno mi porterà nel Sud, lamentava Quasimodo. Invece – se m’è concesso il confronto – io nel Sud ritorno sovente”. Così Vincenzo Consolo spiegava il suo ininterrotto rapporto con la terra e la cultura siciliane: “Da Milano, dove risiedo, con un volo di un’ora e mezza, atterro in Sicilia. Dalla costa d’oriente o d’occidente, ogni volta, come per ossessione, vizio, coazione a ripetere, celebrazione d’un rito, percorro l’isola da un capo all’altro, vado per città e paesi, sperduti villaggi, deserte campagne, per monti e per piane, per luoghi visti e rivisti non so quante volte”.
L’ultima volta che Consolo era tornato in Sicilia è stato nell’estate del 2010. A Gratteri, sopra l’amata Cefalù, in una limpida serata d’estate si presentava “L’isola in me”, un film documentario di Ludovica Tortora de Falco sulla Sicilia suggestiva e straziante di Consolo. Era un ritratto dello scrittore, dell’uomo e dell’artista attraverso i luoghi, i temi, le suggestioni letterarie della sua vita.
Consolo si era assegnato quello che chiamava il “destino d’ogni ulisside di oggi”: quello di “tornare sovente nell’isola del distacco e della memoria e di fuggirne ogni volta, di restarne prigioniero…”. Di questo intenso legame passionale, civile e letterario con la Sicilia Consolo ha sempre dato testimonianza. Dalle profondità del mito ha ricavato una lettura lucida della storia italiana e siciliana dal dopoguerra a oggi. Lo ha fatto attraverso alcuni temi cruciali: l’emigrazione, la vita dei minatori delle zolfare, l’industrializzazione e le devastazioni del territorio, i terremoti e le selvagge ricostruzioni, le stragi mafiose. È una storia che Consolo ha vissuto in prima persona, condividendola con altri scrittori, in primo luogo Leonardo Sciascia a cui era profondamente legato.
E proprio Sciascia aveva segnato il suo percorso letterario cominciato nel 1963 con “La ferita dell’aprile”. Prima che nel 1976 pubblicasse il suo secondo romanzo, quello che gli diede la notorietà, “Il sorriso dell’ignoto marinaio”, Consolo si era lasciato tentare (lui diceva “irretire”) da Vittorio Nisticò e da Milano era approdato a Palermo nella redazione del giornale L’Ora. Ma vi era rimasto solo pochi mesi, poi era tornato a Milano da dove ha continuato a tenere un rapporto intenso, e continuamente rinnovato, con la Sicilia. Di questo legame con la storia e la cultura siciliana sono testimonianza, oltre al sodalizio con Sciascia e all’amicizia con Gesualdo Bufalino, anche la sua intensa produzione letteraria, da “Le pietre di Pantalica” a “Retablo”, da “Nottetempo casa per casa” (premio Strega 1992) a “L’olivo e l’olivastro”, da “Lo Spasimo di Palermo” a “Di qua dal faro”. A cui si aggiungono saggi di forte intonazione civile, interventi e una densa raccolta di articoli per il Messaggero e per l’Unità.
Aveva scelto di vivere a Milano ma il suo cuore e la sua curiosità intellettuale erano radicati in Sicilia.
”La tentazione di sottrarmi alla Sicilia c’è – diceva – ma il meccanismo memoriale della mia narrativa me lo impedisce fino in fondo, è connaturato a uno stile che ingloba la memoria attraverso il linguaggio”.
E proprio al linguaggio dedicava la sua cura sperimentale in una ricerca che lo allontanava sempre più dai canoni correnti.
Da qui la sua invettiva contro la deriva di un paese “telestupefatto”, cioè scivolato verso la volgarità del linguaggio che uccide i valori della vita.
CAPITOLO 13
VINCENZO CONSOLO, GLI ORRORI DELLA STORIA, LO SPASIMO DELL’UOMO, LA SCHIAVITÙ DEGLI OPPRESSI, LA MORTE DELLA LETTERATURA E LA UTOPISTICA E OMOLOGATA SOPRAVVIVENZA NELLA MEDIOCRITÀ DEI GESTI E NELLA FUGA DALLO SQUALLORE NEL MITO DI EMPEDOCLE.
In quel panorama saggistico così completo delle tendenze e delle
aporie dello spirito del XX secolo che è Uomo senza qualità,
Musil mette a fuoco la complessa, subdola, disperata problematica in cui lotta l’uomo contemporaneo. Dibattuto sempre tra due poli, l’uomo è condannato all’incertezza, ad una perenne insicurezza, che investe, ovviamente, anche la Storia, ormai talmente deprivata dell’ottimistica visione progressista di stampo positivista da portare Musil ad affermare che <<per cause ignote l’evoluzione raramente acquista di più di quanto non perde in deviamenti e distruzioni» (p. 280). Una visione realisticamente sconsolata di come stanno le cose
nel XX secolo, quindi, contro cui Kurndera, Brodskij, Calvino, Todorov – tra i tanti – hanno ipotizzato una possibile via d’uscita. Una sorta di salvezza estetica contro il male del mondo, e della Storia: il male dell’indifferenza (contro cui si scagliava Gramsci con tutta l’indignazione di cui era capace), del potere che tutto eguaglia con la forza dell’ideologia, delle armi, del danaro. All’incertezza paralizzante individuata da Musil si oppone la saggezza dell’incertezza del romanzo, il rigore con cui la poesia oppone al buio o alla luce accecante delle certezze ufficiali le tracce più tenui, la differenza di minuscoli fatti o cose, come il topo bianco d’avorio in Dora Markus di Montale. La coscienza che emerge dalla letteratura – ovvero il fatto che il reale è un fascio di possibilità – è ciò che viene opposto alle macchine da guerra del potere. Di qui l’invito di Brodskij: “Eppure dobbiamo parlare; e non solo perché la letteratura, come i poveri, è notoriamente portata a prendersi cura dei propri figli, ma più ancora per via di un’antica e forse infondata convinzione, secondo la quale se i padroni di questo mondo avessero letto un po’ di più, sarebbero un po’ meno gravi il malgoverno e le sofferenze che spingono milioni di persone a mettersi in viaggio. Poiché non sono molte le cose in cui riporre le nostre speranze di un mondo migliore, poiché tutto il resto sembra condannato a fallire in un modo o nell’altro, dobbiamo pur sempre ritenere che la letteratura, sia l’unica forma di assicurazione morale di cui una società può disporre; che essa sia I’antidoto permanente alla legge della jungla; che essa offra l’argomento migliore contro qualsiasi soluzione di massa che agisca sugli uomini con la delicatezza di una ruspa […] Dobbiamo parlare perché dobbiamo dire e ripetere che la letteratura è una maestra di finesse umana, la più grande di tutte, sicuramente migliore di qualsiasi dottrina; dire e ripetere che, ostacolando l’esistenza naturale della letteratura e l’attitudine della gente a imparare le lezioni della letteratura, una società riduce il proprio potenziale, rallenta il ritmo della propria evoluzione e in definitiva, forse, mette in pericolo il suo stesso tessuto. Se questo significa che dobbiamo parlare di noi, tanto meglio: non già per noi stessi, ma forse per la letteratura”.
La realtà estetica è, così, chiamata a ridefinire la realtà etica dell’uomo. Ed è proprio in questo senso, allora, che l’affermazione di Dostoevskij – «la bellezza salverà il mondo» – va presa alla lettera. Consolo sapeva tutto questo. Sempre impegnato sia nel suo lavoro giornalistico sia in quello letterario, sapeva bene – sapeva sempre più – che (come aveva intuito Musil) non abbiamo punto d’appoggio, che danziamo tutti sull’orlo dell’abisso. Sapeva che il mondo con i suoi orrori – (guerre, fame, ingiustizie, razzismo, violenza, disperazione dei tanti, arroganza dei potenti) da lui inesaustivamente denunciati fino all’ultimo – deborda da tutte le parti. E, dunque, avvertiva (insieme a Kundera, Brodskij, Calvino Torodov’, Pasolini, etc.) che per un intellettuale è necessario opporsi con tutti i mezzi possibili, essere contro a tutto questo. Ma per fare diga all’orrore del mondo e di chi lo governa, ci vuole un impegno permanente, una capacità di sdegno sempre all’erta, un’arte – la scrittura – che abbia un metodo inesorabile che permetta di costruire un ponte sull’abisso sottostante. Ecco, quindi, delinearsi le componenti necessarie al suo scrivere storico-metaforico, sostanziato anche dalla sua frequentazione con i lavori del Gruppo 47, particolarmente con l’«etica della memoria» di Enzensberger a cui Consolo fa eco con la propria «metrica della memoria»: Consolo – rifacendosi alle parole di Sciascia nel racconto. La sesta giornata – si ascrive a quella schiera di poeti che non capiscono come «un testo possa splendere di verità e mancare di poesia» e che intendono, invece, scrivere «parole che vogliono farsi azione», rappresentando profondamente la storia e lo spirito del proprio tempo, partendo sempre da una precisa appartenenza e specificità storico-geografica perché, come ricorda Maria Attanasio – poetessa e scrittrice calatina che ha in Sciascia e Consolo due suoi maestri – ogni narrazione storica è sempre ad alto tasso autobiografico e non potrebbe essere altrimenti. Come in Sciascia, così in Consolo, parola e azione sono due facce della stessa medaglia. Scrittura e impegno etico e civile sono indissolubili l’una dall’altro. E se Sciascia afferma che solo nella storia la sua scrittura del mondo trova legittimazione e senso, Consolo ha sempre ripetuto: «Mi interessava il mondo storico sociale, non mi interessavano i problemi personali o le indagini psicologiche. Mi interessava raccontare la storia, la Sicilia». Detestava, inoltre, come sanno tutti quelli che lo hanno conosciuto, il romanzo giallo (fatta eccezione per i gialli civili di Sciascia ben lontani dal cosiddetto romanzo giallo con tanto di fine risolutiva) e l’autobiografismo (amava ripetere che proprio non si sapeva più che farsene dei troppi Proust di provincia …). Scrive, quindi, di storia e sulla storia, cercando – non senza valenze utopistiche – soluzioni non volte a cancellare la storiografia ufficiale, ma tali da affiancarle quella potenziale, mai scritta, mai. A questo proposito si veda il saggio di Renato Nisticò, Cochlìas legere. Letteratura e realtà nella narrativa di Vincenzo Consolo, in «Filologia antica e moderna», 4, 1992, pp 179.22). Per gli aspetti linguistico-stilistici e per il concetto di plurivocità, è d’obbligo il lavoro di Cesare Segre, La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, in intrecci di voci, rientra nella polifonia nella letteratura del novecento. Ne Il Sorriso dell’ignoto marinaio (editio princeps 1976) delega nelle appendici i cosiddetti documenti ufficiali, mentre costruisce i capitoli del libro su elementi verisimili, e non ufficiali. La storia, infatti, la scrivono sempre i vincitori mai i vinti, ed è proprio ai vinti – nel suo tentativo di riscattarli dall’immobilismo fatalistico a cui li aveva condannati Verga ed eternati Tomasi di Lampedusa – che Consolo dà la parola. Scrive di storia con convinzione per scrostare la parzialità e l’assolutismo di cui è fatta la storiografia ufficiale. Dietro quella crosta, costruita sull’illusione del cammino progressivo della storia, si nasconde la storia di chi non ha avuto i mezzi e gli strumenti per narrarla dal proprio punto di vista, cercando di rintracciare il nostro destino, al di là di tante false certezze, che giustifichi laicamente, la «nostra vita mortale». Consolo ricorda che è la poesia a salvare il poeta: «E nel deserto della natura e della storia, unica consolazione si trova nell’odorata ginestra”, nella “social catena”, ne “l’onesto e il retto conversar cittadino”, nella “giustizia e nella pietade”», ribadendo che l’unica consolazione possibile va cercata «nella religione della tradizione e della famiglia, nell’attaccamento tenace come quello dell’ostrica allo scoglio, al paese natio». Il che rende omogenee sia le ragioni di Leopardi che quelle di Consolo. Nel saggio “Impietrata luna”, a proposito di Verga – che deluso, a Milano, a partire dal 1874 scrive sulla Sicilia in una maniera prima sconosciuta (Consolo parla metaforicamente di se stesso, del suo essere diventato scrittore di storia di Sicilia dopo avere lasciato l’isola nativa alla volta della città del Grande Nord dello Sviluppo Economico) – in seguito alla caduta di tutte le illusioni che questo esilio aveva comportato e alla necessità di trovare nella scrittura, il confronto con la storia della collettività umana (di cui la Sicilia è emblema) per coglierne, al di là delle inique divaricazioni esistenti, alcune delle sue vivede connotazioni.
«Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all’interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove. Una voglia, una smania che non mi lascia stare fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta d’addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca.»
Queste parole, tratte dal racconto Comiso (da Le Pietre di Pantalica), sono una dichiarazione di poetica e di ontologia letteraria: la memoria evocatrice dell’esilio dalla lontana Sicilia. La vocazione di Consolo scaturisce sia dalla posizione geografica (Sant’Agata di Militello in Sicilia), sia dalla dichiarata volontà di asetticizzare ogni mediterraneità, e subito immergersi nell’impegno di indagare la realtà, Dopo l’università Cattolica, Milano divenne la mia città.
Emblematico di quanto appena detto è il brano finale del racconto “La casa di lcaro”:
E ora che sei migrato per sempre, caro Uccello, io rispondo a quella tua richiesta di fare tutto il possibile… E il possibile è questo, di ricordarti, dagli spazi chiusi di questa nostra frigida vita, con affetto e con rimpianto, dolce e feroce, cantore e predatore di memorie, di reliquie d’un mondo trapassato di fatica e dolore, vero, umano, per il quale non nutrivi nostalgia, ma desiderio, apparenza di riscatto.
Il primo libro, La ferita dell’aprile (1963), rispecchia quegli anni di impegno, giustifica la propensione verso la storia che è stata decisiva per la sua vita letteraria.
E con il romanzo del 1976, Il sorriso dell’ignoto marinaio – con cui si apre la Trilogia – che il quarantatreenne scrittore fa affiorare sua critica corrosiva alla storia ufficiale, proponendo quella di una lettura polifonica dei fatti e degli eventi che accolga polifonicamente anche la voce di coloro che hanno avuto sempre negato di averne una come gli esclusi, dei reietti e dei subalterni. Non quella rassegnata dei protagonisti gattopardeschi, né quella dei vincitori, dei nobili, dei mafiosi: quella di Vincenzo Consolo è una storia “altra” – di sofferenti e di sofferenze – contro la Storia di sempre, quella che viene ripetuta da “baroni, proprietari e allitterati con ognuno che viene qua a comandare, per avere grazia e giovamenti e soprattutto per fottere i villani”. Il Sorriso è il rispecchiamento di una speranza storica, della fiducia ancora nella lotta di classe quale unico strumento valido per cambiare il corso della Storia. Dopo il Sorriso si assiste progressivamente ad una metamorfosi, un cambio di quel sorriso, in rintuzzamento di quella fiducia e di quel sorriso in Nottetempo, casa per casa (1992), fino allo spegnersi nell’afasia finale dello Spasimo (1998). Nel Sorriso, Consolo rappresenta il drammatico dilemma tra la classe possidente e il proletariato, rappresentanti di una voluta incomunicabilità umana. Ma la prima classe ha la consapevolezza di essere costruttrice della sua propria potenza, la seconda si sente invece annientata e impotente e comprende la sua esistenza come non umana. C’è una pagina, all’inizio del capitolo sesto del Sorriso – Lettera di Enrico Pirajno all’avvocato Giovanni Interdonato come preambolo a la memoria sui fatti d’ Alcara Li Fusi – che a questo proposito certamente esemplare. Il romanzo – che racconta le vicende siciliane negli ultimi anni del dominio borbonico e, in particolare, i tentativi di rivoluzione liberale e le rivolte contadine, susseguitesi fino a poco dopo lo sbarco di Garibaldi – e culminate nella rivolta di Alcàra Li Fusi contro i feudatari del luogo nel maggio 1860. Vi assiste casualmente il protagonista del libro, il nobile Enrico Pirajno barone di Mandralisca – personaggio storico realmente esistito (1809- 1864) a cui si deve Il Museo Mandralisca di Cefalù, dove è conservato il Ritratto di Ignoto di Antonello da Messina a cui rimanda il titolo del romanzo di Consolo – erudito, archeologo, numismatico e famoso naturalista e collezionista d’arte, deputato alla Camera dei Comuni nel 1848 e, dopo l’Unità, nel Primo Parlamento del Regno d’Italia. Uomo di idee liberali ma lontano fino a quel momento dall’azione politica, in tale circostanza di cui è stato testimone, è invaso da due decisive riflessioni: I) la considerazione che la Storia è «una scrittura continua di privilegiati» e che esiste, quindi, una storia dei vincitori e una dei vinti, la prima mai scritta, la seconda, in questa drammatica dicotomia, visibilmente irresolubile, è la tragedia della Storia.
Nell’atto di stendere una relazione sui fatti appena accaduti, e di stenderla come avrebbe fatto «uno di quei rivoltosi protagonisti fucilati in Patti» o «uno zappatore analfabeta come Peppe Sirna inteso Papa», intuendo tali versioni in immutabile opposizione, ammette l’impossibilità dell’impresa. Per quanto l’intenzione e il cuore sian disposti, troppi vizi ci nutriamo dentro, magagne, per nascita, cultura e per il censo. Conseguentemente questo “scarto di voce e di persona” gli appare un’azione scorretta. Ed allora, nella sua lettera all’avvocato «illuminato» Giovanni Interdonato (altra figura storica del romanzo, nominato nel 1865 Senatore del Regno d’Italia) che fa da preambolo alla memoria su fatti di Alcàra Li Fusi, scrive: “Ed è impostura mai sempre la scrittura di noi cosiddetti illuminati, maggiore forse di quella degli ottusi e oscurati da’ privilegi loro e passion di casta. Osserverete: ci son le istruzioni. Le dichiarazioni agli atti le testimonianze.,. E bene: chi verga quelle scritte, chi piega quelle voci e le raggela dentro i codici, le leggi della lingua? Uno scriba, un trascrittore, un cancelliere, Quando [invece] un immaginario meccanico istrumento tornerebbe al caso, che fermasse què discorsi al naturale, siccome il dagherrotipo fissa di noi le sembianze. Se pure, siffatta operazione sarebbe ancora ingiusta. Poi che noi non possediam la chiave, il cifrario atto a’ interpretare que’ discorsi. E cade acconcio in questo luogo riferire com’io ebbi la ventura di sentire un carcerato, al castello dei Granza Maniforti, nel paese di Sant’Agata, dire le ragioni nella parlata sua sanfratellana, lingua bellissima, romanza, o mediolatina, rimasta intatta per un millennio sano, incomprensibile a me, a tutti, comecché dotati d’un moderno codice volgare. S’aggiunga ch’oltre alla lingua, teniamo noi la chiave, il cifrario dell’essere, del sentire e risentire di tutta questa gente? Teniamo per sicuro il nostro codice, del nostro modo d’essere e parlare ch’abbiamo eletto a imperio a tutti quanti: il codice del dritto di proprietà e di possesso, il codice politico dell’acclamata libertà e unità d’Italia, il codice dell’eroismo come quello del condottiero Garibaldi [.,.], il codice della poesia e della scienza, il codice della giustizia o quello d’un utopia sublime e lontanissima. E dunque noi diciamo, Rivoluzione, diciam Libertà, Egualità, Democrazia, riempiamo d’esse fogli, gazzette, libri, lapidi, pandette, costituzioni, noi, che que’ valori abbiamo già conquisi e posseduti [.,.] E gli altri, che mai hanno raggiunto i dritti più sacri e elementari, la terra e il pane, la salute e l’amore, la pace, la gioia e l’istruzione, questi dico, e sono la più parte, perché devono intender quelle parole modo nostro? La ricerca di una possibile veridicità dei fatti storici da parte di coloro che hanno potere di scrittura viene meno. E allora? Che resta da fare? Ben lontano dalla fatalistica accettazione dello status quo in cui sono condannati a mal convivere per sempre i «galantuomini» e la «povera gente» che popolano la novella “Libertà” di Verga – relativa alla feroce rivolta di Bronte e alla ancor più violenta repressione di Nino Bixio il 4 agosto 1860-, Consolo è altamente conscio della natura umana delle due classi antagoniste. In lui, con Dotti. sono evidenti sia il riconoscimento di quanto sia stata giusta la cruda ribellione contadina, ma anche l’inattesa affermazione che la classe dei possidenti, mancando dei necessari “codici” interpretativi”, dovrebbe comunque astenersi dal giudicare un evento che ha in realtà appalesato l’ignominia umana della storia stessa. E qui soccorre la proposta, dal sapore utopistico, di Consolo espressa, in quegli anni ancora soffusi di speranza, attraverso il suo barone di un secolo prima con un attacco di frase, che echeggia il «“Verrà un giorno.,.”» che Padre Cristoforo rivolge a Don Rodrigo nel VI capitolo dei Promessi sposi.: “Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i nomi saranno interamente riempiti dalle cose.” Si vagheggia di un futuro in cui il linguaggio, invece di essere l’ornamento retorico di una violenta ipocrisia storica, riconquisti urla, precisa adesione al senso concreto delle cose e possa dare corpo alle voci fino ad allora silenziate e mute, rese abili finalmente a svelare l’autentico senso della storia, con le sue infamie morali, politiche ed economiche. Una certa qualche speranza nel futuro, che poi sparirà dall’ opera di Consolo, si rintraccia nel fatto che quell’auspicato cambiamento trovi uno spiraglio per riproporsi non più nell’Occidente (dove la fiducia nella lotta di classe è spenta. divenuta fredda cenere), bensì in un più profondo e vitale Sud del mondo. C’è un racconto del 1985, raccolto ora in La mia isola è Las Vegas col titolo “Porta Venezia”, in cui Consolo parla del luogo da lui più amato a Milano, la zona, multietnica di Porta Venezia, dove a proposito della cospicua popolazione africana e asiatica che ci vive, leggiamo nell’incipit: «“Incidono lo spazio” mi dicevo. “Sono una perentoria affermazione dell’esistenza”». E ancora, poco più avanti nel testo: Erano, i marciapiedi di corso Buenos Aires, in questo tardo pomeriggio di sabato, tutta un’ondata di mediterraneità, di meridionalità, dentro cui m’immergevo e crogiolavo, con una sensazione di distensione. di riconciliazione. Io che non sono nato in questa nordica metropoli, io trapiantato qui, come tanti, da un Sud dove la storia s’è conclusa, o come questi africani, da una terra d’esistenza (o negazione d’esistenza) dove la storia è appena o non è ancora cominciata; io che sono di tante razze e che non appartengo a nessuna razza, frutto dell’estenuazione bizantina, del dissolvimento ebraico, della ritrattazione araba, del seppellimento etiope, io, da una svariata commistione nato per caso bianco con dentro mutilazioni e nostalgie. Mi crogiolavo e distendevo dentro questa umanità come sulla spiaggia al primo, tiepido sole del mattino”. Nel 1985 la speranza riguardo alla Storia trapelava ancora. Non a caso, sempre nel 1985, Consolo può scrivere quel cunto di settecentesca ironia che è Lunaria che, insieme a Retablo (1987), costituisce un intermezzo, un momento di pausa e di riflessione riguardante (sempre da leggersi in chiave di metafora) il secolo dei lumi, con le sue contraddizioni, la sua guerra tra buio e ragione, seguendo i protagonisti nel loro progressivo rendersi conto dei perché del proprio vivere e del mondo, alla luce di una ragione difficilmente conquistata, se e quando conquistabile. E questo costituisce l’impegno di tutti i personaggi degli scritti di Consolo e, con loro, del loro autore che in essi rivive e tramite essi cerca di dare espressione all’uomo che si sforza di annientare la propria componente animalesca per diventare umano. Messaggio questo ben esemplificato nel titolo di un libro, tra i suoi più belli, che è L ‘olivo e l’olivastro (1994): l’umano e il bestiale, il coltivato e il selvatico: dicotomia di omerica, ulissica memoria. Con il passare del tempo e con quel che accade nello scrittore, sensibilissimo a rilevare i cambiamenti e i sismi della società (gli anni Novanta vedono la cancellazione di un’intera generazione politica, Tangentopoli, l’inchiesta Mani pulite, l’ascesa politica di Berlusconi e della Lega Nord in un ritorno al fascismo fatuo), speranza e fiducia vacillano e cominciano a venir meno, soppiantate da rabbia, sdegno, impotenza senza scampo tranne – forse e sempre più in bilico – quello estetico da affidare nonostante tutto e contro qualsiasi tentazione di afasia e silenzio, alla scrittura. La Trilogia è come un’appassionata partitura, in cui i tre movimenti – adagio, sostenuto, grave – sono ben distinti e si susseguono in un crescendo vorticoso (come l’immagine della chiocciola cara a Consolo) che svela, con sempre più sdegnato dolore, gli inganni, le crudezze, le insensatezze della storia: dalla cosiddetta Unità nel Sorriso nel 1976 (in realtà miope piemontizzazione della penisola), alle sopraffazioni e angherie del fascismo in Nottetempo (1992), ai crimini di uno Stato connivente con la Mafia nello Spasimo (1998)”. Il 1992 è l’anno di Nottetempo. In questo romanzo Consolo, come suo solito, parla dell’oggi raccontando dell’ieri. Qui si tratta di un momento clou della storia siciliana e italiana nei primi anni Venti, quelli che hanno segnato l’avvento del fascismo e la notte della ragione. In un romanzo corale, attraverso l’evocazione di tanti destini individuali, lo scrittore coglie un’intera civiltà ormai sull’orlo dell’abisso, In questo libro Consolo tenta di realizzare quell’arduo proposito a cui accennavo poco fa dell’uomo che lotta per fare prevalere la sua umanità sull’animalità. Qualcuno ha suggerito che Nottetempo è un «poema diviso in dodici canti». In questi dodici canti il narratore svolge il tema di un uomo, Petro Marano che, atrocemente colpito da un’ignota offesa, si sforza facendo conto solo su se stesso per sottrarsi alla propria sventura, alla sua continua pena: la follia animalesca del padre («luponario», licantropo), la disgrazia mentale della sorella, la confusione babelica che corrompe anche il linguaggio e che «stracangiava le parole, il senso loro» onde «il pane si faceva pena, la pasta peste, il miele fiele, la pace pece, il senno sonno…». Il tutto ad echeggiare i tempi (passati e presenti) di perdita della ragione, buio dell’ignoranza, irrazionalità (v. il personaggio modellato su quello storico di Aleister Crorvley (1875 -1947), mago profeta e satanista di origine britannica), sopraffazioni, crimini e misfatti” Nel libro si cerca, con fatica e allentata speranza, di fare leva sulla ragione per vincere quello che ragione non è, quella «bestia dentro l’uomo che si scatena e insorge, trascina nel marasma. La bestia trionfante di quel tremendo tempo, della storia, che partorisce orrori, sofferenze». Alla fine del libro Consolo, con scoperta autoreferenzialità, riprende lo speranzoso proposito del Sorriso (quello veicolato dalla frase «verrà un giorno in cui i nomi saranno riempiti dalle cose») e ne affida la (potenziale) realizzazione al disgraziato protagonista del libro che nella chiusa si smarca dalla nefasta influenza dell’’anarchia violenta e idealista di Paolo Schicchi, fugge in Tunisia, e cerca ragione nella scrittura: ultimo stadio prima dell’afasia e del silenzio. Ecco le parole conclusive di Nottetempo: Cominciava il giorno, il primo per Petro in Tunisia. Si rinnovò il libro dell’anarchico, aprì le mani e lo lasciò cadere in mare. Pensò al suo quaderno. Pensò che, ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore. Pietro Marano, qui esplicitamente chiamato a ‘riempire i nomi con cose nuove’, porta a compimento la prima parte del suo compito (quella precedente la scrittura) nel momento in cui arriva a comprendere che l’unica salvezza possibile risiede nella fuga. Una fuga che è anche resurrezione: emigrazione a Tunisi, come un qualsiasi emigrante alla ricerca di «lavoro, casa, di rispetto». Ed è rispetto la parola chiave. Rispetto per se stesso, per gli altri, per gli uomini di senno che superano il sonno a cui i più sono costretti. Il risvegliarsi dal quel sonno non è stato facile, non allietato da nessun enfatico ‘sol dell’avvenire’. Il risveglio coincide con il distacco necessario autobiograficamente a chi scrive (a Dante in esilio, a Verga e Consolo a Milano) – avvenuto nottetempo, casa per casa – da un passato dolorosamente ma consapevolmente respinto, da una memoria a cui si dovrà tornare un giorno (con la scrittura) per calcolarne il peso e coglierne il significato. La speranza in una possibile polifonia della storia e sulla storia, vaga nel Sorriso, assai attenuata in Nottetempo, è fugata nello Spasimo (1998). Il libro è stato scritto in seguito all’offensiva della Mafia contro lo Stato culminata nelle stragi che videro nel 1992 la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (alla cui esecuzione il narratore fa menzione alla fine del libro). Si tratta del testo più sofferto della Trilogia, e non a caso.
È infatti quello che tratta di fatti contemporanei all’autore, ragione per cui gli viene a mancare a mancare – data la gravità dell’argomento trattato – il distacco. È il meno lineare dei libri di Consolo nell’ossessivo affollarsi di passato e presente, nella contrapposizione di storia e memoria, nel vano bisogno di conforto che il ricordo potrebbe offrire e che suscita, invece, un bruciante sentimento di patimento, di sofferenza, di spasimo appunto. Il sostantivo del titolo (oltre al dipinto di Raffaello e alla chiesa eponima palermitana a cui si riferisce), è allusivo allo strazio che da Palermo e dalla Sicilia si allarga e investe il mondo intero. Consolo fa scorrere il suo sguardo, sempre più ferito e indifeso, sulla società attuale in cui, sotto mentite e apparentemente benevole spoglie, domina sempre, e non solo subliminalmente, la violenza fascista avvallata dalla follia del libero mercato del capitalismo più selvaggio, che ha inondato il mondo con la sua spietata corruzione. Dopo la guerra, l’Italia del dopo-guerra, quella del futuro… Ma, si chiede il narratore, cosa hanno fatto di effettivo le due generazioni che si sono succedute dal secondo dopoguerra? Quella del padre (protagonista del libro, scrittore) Gioacchino Martinez e quella del figlio Mauro? La prima s’è rinchiusa nell’inerte escapismo dell’«azzardo letterario»; la seconda, mossa da quella che riteneva una «lucida ragione», si è data all’inconcludente violenza della lotta armata e del terrorismo. Ma è così che si costruisce una «nuova società, una civile, giusta convivenza»? Questa amara confessione, sottesa a tutte le ingarbugliate pagine del racconto, emerge finalmente nel capitolo conclusivo. Ma in quell’ultimo, XI capitolo, la catartica confessione scritta del protagonista e indirizzata all’estraniato figlio, proprio quando sembra lasciare trapelare che, nonostante tutto e tutti, il lume della ragione possa forse ancora riaccendersi e mandare qualche favilla, viene bruscamente interrotta da una telefonata allarmata che impone al protagonista di scappare e, di lì a poco, esplode sotto casa sua la bomba che distrugge la vita del giudice (senza nome ma è Borsellino) e della sua scorta.
Se la lettera, in quanto scrittura, era ancora, a sole poche righe dalla chiusa del libro, l’unico salvagente possibile rimasto per aggrapparvicisi e cercare di non affogare, dopo l’esplosione rimane solo il silenzio. Storia e memoria sono morte. E con esse muoiono parola e scrittura e, quindi anche l’un tempo vagheggiata altra possibilità polifonica di scrivere la storia. Restano il silenzio e una cantilena popolare muta, un rituale senza più speranza che irride forse apotropaicamente, qualsiasi salvezza, dovuta alla ragione e all’umanità. Su queste ha prevalso l’animalità, l’olivastro ha estirpato l’olivo: Cercò di dire, ma dalle secche labbra non venne suono. Implorò muto. O gran mano di Diu, ca tantu pisi, cala, manu di Diu, fatti palisi! Dopo due millenni di civiltà «post Cristum natum i popolani si vedono ancora costretti a invocare l’appalesarsi della giustizia divina»: più sconsolata e sconsolante di così questa fine non poteva essere. Nessuna speranza, per nessun autore italiano impegnato, esiste più negli anni Novanta subito prima e dopo la morte, nel 1992, dr Falcone e Borsellino e delle loro scorte.
Caterina, giovane eroina fuggita dalla Sicilia, parlando a Roma del loro paese natio al cugino Gerlando, che si appresta a divenire killer d’ultima generazione al fine di eliminare i colleghi di vecchia generazione, gli dice: “La cosa tremenda è che non sarebbe finita mai. E così, improvvisamente, mi è sembrata la nostra Rocca di Loto. Un inferno perché tutti fanno sempre le stesse cose, dicono le stesse frasi. E si proteggono, l’un l’altro, perché questo inferno continui, perché non cambi mai, perché nessuno dall’esterno venga a turbarlo. Anche ora, che tutti si ammazzano.,. Sì, si ammazzano per qualche interesse, però non per cambiare qualcosa, ma per continuare ad essere così come sono sempre stati.” Con una manovra paradossale, ma realistica, nel suo libro – che tratta di una generazione siciliana che, persino nel ribellismo giovanile, non ha alternative all’uso dei metodi mafiosi -, Deaglio annoda il fatalismo di Verga e di Tomasi di Lampedusa con la desolazione a cui per la sua strada è giunto Consolo, emblematizzandolo in un paese siciliano dove la modernizzazione passa stravolgendo tutto e non cambiando nulla. Nel 2002, in Catarsi, Consolo scrive parole che tornano retroattivamente all’explicit dello Spasimo e le affida ad Empedocle: Se le parole si fanno prive di verità, di dignità e di storia, prive di fuoco e di suono, se ci manca il contorto loro, non c’è che l’afasia. Non c’è che il buio della mente, la notte della vita, Nell’ultimo Consolo, un’ulteriore passo. Dalla dissoluzione di qualsiasi speranza storica sancita dallo Spasimo – che mette la parola fine al suo dialogo illuminato e razionale sulla Storia intrapreso anche sulla scia di Sciascia e con Sciascia -, all’abbracciare sempre più sfiduciato le ragioni di un male di vivere più universale, cosmico, a forte reminiscenza leopardiana e pirandelliana, meno storico (quantomeno non solo storico) che, però, lascia spazio al recupero dell’ importanza, malgrado tutto, dell’azione individuale affidata alla parola «“scritta e pronunciata”». Sempre nel Prologo della sua opera teatrale tragica Catarsi (in cui, ricordo, è messo in scena il suicidio sull’Etna di un moderno Empedocle di Agrigento), Consolo, dice che la «tragedia è la meno convenzionale, / la meno compromessa delle arti» e che «al di là è la musica. E al di là è il silenzio». E, altrove – ne La Metrica della memoria, riflessione critica sulla sua stessa scrittura – ricorda di avere voluto scrivere questi versi incipitari di Catarsi, perché la tragedia, in forma teatrale o narrativa, in versi o in prosa, rappresenta l’esito ultimo di quella che posso chiamare la mia ideologia letteraria, l’espressione estrema della mia ricerca stilistica. Espressione, in Catarsi, in forma teatrale o poetica, in cui si ipotizza che la scrittura, la parola, tramite il gesto estremo del personaggio, si ponga al limite della pronunciabilità, tenda al suono, al silenzio. E questo si rinserra con la chiusa sul silenzio già esperita e sofferta dal narratore dello Spasimo (1998): generi diversi, esiti analoghi. Col silenzio Consolo si era già scontrato nel suo libro del 1994 L’olivo e I’olivastro, il cui incipit non a caso recita: «Ora non può, Narrate» e in cui vengono negate la finzione letteraria e l’invenzione del racconto”. E, a proposito dell’Olivo e l’olivastro, ne La metrica della memoria, Consolo allude al narratore, all’ànghelos che vede interrotto il dialogo con i suoi destinatari, scomparso lo «spirito socratico», perché ormai la cavea è vuota, deserta. Sulla scena è rimasto solo il coro che in tono alto, Lirico, in una lingua non più comunicabile, commenta e lamenta la tragedia senza soluzione, la colpa, il dolore senza catarsi. Sempre più netto è il passaggio operato da Consolo, fin dai suoi esordi letterari, da scrittura della comunicazione a scrittura dell’espressione. L’unica, ormai, secondo lui, in cui possa scriversi un romanzo:” Nelle mie narrazioni c’è sempre l’interruzione del racconto e il cambio della scrittura, il suo alzarci di tono, svolgersi in forma ritmica, lirico-poetica.” Se l’atteggiamento nei confronti di parola e silenzio è andato peggiorando – culminando nella disperata chiusa dello Spasimo, che è un romanzo, nell’ultimo Consolo riemerge la speranza nella catarsi, nel potere consolatorio della parola, ma in un genere letterario diverso, quello teatrale di greca memoria con tanto di anghelos e coro. Eccolo, quindi, in Catarsi, affidare la deuteragonista di Empedocle, Pausania, la rivendicazione del ruolo del narratore: Io sono l’anghelos, il messaggero necessario, colui che narra, che riferisce in tono basso la tragedia, che dice l’indicibile, che rappresenta l’irrappresentabile. Io sono il coro, l’eco sonora del crudo, del muto evento, colui che piange, si lamenta in geometrica cadenza, come vuole il rito, Poiché solo nel rito, come quello teatrale, nelle frasi, nelle movenze stabilite è possibile dire del dolore, della colpa, è possibile che avvenga la catarsi. E, ancora, restituisce alla parola la sua funzione super partes et super omnes et omnia, oltre la Storia. È Empedocle a parlare: “Chi è presso alla morte si fa profeta. Io vi dico: la sua poesia eretica, blasfema, com’è la poesia vera, in questo tempo uniforme e tondo come una sfera spenta, la sua esplosione, la sua voce di vento e acqua, di terra e fuoco, valicherà me, voi, la storia, dopo millenni illuminerà la terra come la luce d’una remota stella”. Ultimo, ma non meno importante, Consolo, oltre all’impegno letterario, ha da sempre portato avanti, con coerenza e coraggio quello dell’impegno giornalistico (tra i pochi in Italia, in un passato recente, a schierarsi pubblicamente contro l’ex governatore della regione Sicilia Totò Cuffaro, che ha passato anni in galera per associazione mafiosa).
La sua ultima accorata difesa della forma teatrale tragica, lo porta a realizzare un testo composito e inatteso: l’atto unico intitolato Pio La Torre, orgoglio di Sicilia (2009), scritto su incarico del Centro di Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre, col preciso intento di destinarlo alle scuole. Il testo composito, dicevo, è a cavallo tra storiografia e teatro. Infatti, è in parte un obiettivo resoconto storico di alcuni dei fatti più significativi della storia siciliana a partire dal secondo dopoguerra (dalla lotta contro il feudo all’ industrializzazione, al boom economico, attraversando le successive fasi della migrazione dei siciliani e dei meridionali e il continuo conflitto con la Mafia, strumento di potere connivente con lo Stato). I resoconti storici sono affidati a tre voci narranti che offrono mirabilmente «una drammatica sintesi della vita politica e sociale dell’Italia dal primo dopoguerra», come recita la nota introduttiva vergata da Vito Lo Monaco. Ma è anche un dialogo mimetico tra i personaggi coinvolti da cui emerge – con discrezione e grande efficacia – il loro vissuto, il loro credo, i loro valori pagati con il prezzo delle loro stesse vite. La storia del grande sindacalista comunista, successore del precedentemente assassinato Placido Rizzotto, che sarà assassinato a sua volta dalla Mafia insieme al suo amico-autista Rosario Di Salvo il 10 aprile 1982, si profila sullo sfondo della Storia d’Italia dal secondo dopoguerra ad oggi. Si Tratta di uno scritto in cui Consolo con penna leggera e obiettiva delinea, e fa rivivere, il travaglio e l’evoluzione del nostro Paese verso la modernità. Credo che un testo come questo, sia la fertile eredità lasciata da Consolo ai più giovani: un modello di scrittura della Storia – obiettivo, espresso con lingua e stile efficacemente comunicativi, che tenga conto del punto di vista delle vittime e di chi gli sopravvive.
Un linguaggio diretto, lontano da quello dell’’espressione letteraria. Ecco perché questo suo ultimo tentativo di comunicare la storia potrebbe germogliare al contrario di quello letterario. Quest’ultimo è uno stile: individuale, unico ed irripetibile per definizione; l’altro suggerisce un metodo. Gli stili sono, e devono restare, inimitabili; i metodi si imparano e si applicano.
Concludo lasciando la parola a Consolo, a futura memoria:
Vito Lo Monaco, nota editoriale a Vincenzo Consolo, Pio La Torre. Orgoglio di Sicilia, Palermo, Centro di Studi ed iniziative Culturali Pio La Torre,2009, pp.4 – 5,p.4.
L’atto unico è stato donato da Vincenzo Consolo al Centro Studi affinché fosse usato come strumento di memoria e di educazione civica. Io sono stato onorato, al di là di ogni retorica, quando il Centro Pio La Torre mi ha incaricato di scrivere quest’atto unico, destinato alle scuole, [e di essere qui,] oggi, in questa sede così importante qual è il carcere dei Pagliarelli.
Ecco io dico che la storia di Pio La Torre è la storia di tanti altri che sono la nobiltà di Sicilia. Io non credo ai signori gattopardi. Mi ha molto irritato da sempre la frase di Lampedusa «Noi fummo i leoni, i gattopardi e dopo di noi vennero le iene e gli sciacalletti. Questi signori che abitavano nei loro palazzi, questi feudatari, sapevano benissimo chi erano le iene e gli sciacalletti. Erano i gabellotti, i soprastanti. Erano quelli che sfruttavano il lavoro dei braccianti e dei contadini, dove è nata La Mafia, e che poi portavano i profitti nei palazzi dei signori nobili palermitani. Io credo che la vera nobiltà di Sicilia sia, appunto, rappresentata da quei braccianti, da quei contadini, da quei sindacalisti come Pio La Torre. Figura di grande nobiltà è quella di Francesca Serio, la madre di Turiddu Carnevale, di cui ci parla Carlo Levi ne Le parole sono pietre. E si potrebbero fare tantissimi altri nomi, una lista enorme di persone che hanno sacrificato la vita per ii riscatto della loro dignità, per avere riconosciuti i loro diritti. E poi, oltre i braccianti, i contadini, i sindacalisti, sono stati anche i magistrati e le forze dell’ordine ad avere sacrificato la vita per il riscatto di questa nostra terra. Io ho avuto l’onore di conoscere alcuni di questi magistrati.
Ho conosciuto Falcone. Ho conosciuto Gian Giacomo Ciacco Montaldo. E pensare alle loro figure… veramente quella è la vera nobiltà di Sicilia: i braccianti. i sindacalisti, i contadini, i magistrati e le forze dell’ordine che hanno pagato con la vita per il riscatto di questa nostra terra».
CAPITOLO 14
INTERVISTA A VINCENZO CONSOLO (RAI)
CONSOLO: Mi chiamo Vincenzo Consolo. Sono uno scrittore siciliano, quindi meridionale, emigrato trent’anni fa al Nord, a Milano, quindi appartengo a quella lunga schiera di scrittori, intellettuali e artisti meridionali che hanno lasciato la propria terra e si sono trasferiti al Nord. Magari poi parleremo di questa storia dell’emigrazione intellettuale, dal Sud verso il Nord.
Il tema che oggi affronteremo è appunto il tema del Meridione dal punto di vista soprattutto culturale, cioè: Meridione e cultura, che cosa significa questa grande regione d’Italia dal punto di vista culturale, oltre che dal punto di vista sociale e storico. Vediamo ora una scheda filmata. Esiste nelle estreme e più lucenti terre del Sud un mistero nascosto, per la difesa della natura dalla ragione, un genio materno di illimitata potenza, alla cui cura gelosa e perpetua è affidato il sogno in cui dormono quelle popolazioni. Se solo un attimo quella difesa si allentasse, se le voci dolci e fredde della ragione umana potessero penetrare quella natura, essa ne rimarrebbe fulminata.
A questa incompatibilità di due forze ugualmente grandi e non affatto conciliabili, come pensano gli utilitaristi, a questa spaventosa quanto segreta difesa di un territorio, la vaga natura coi suoi canti, i suoi dolori, la sua assurda innocenza e non a un accanirsi della storia, che qui è più che altro regolata, sono dovute le condizioni di questa terra e la fine miseranda che vi fa, ogni volta che organizza una spedizione o invia i suoi guastatori più arditi, la ragione dell’uomo.
Qui il pensiero non può essere che servo della natura, suo contemplatore in qualsiasi libro o nell’arte. Se appena accenna a qualche sviluppo critico, o manifesta qualche tendenza a correggere la celeste conformazione di queste terre, a vedere nel mare soltanto acqua, nei vulcani altri composti chimici, nell’uomo delle viscere, è ucciso. All’immobilità di queste ragioni sono attribuite altre cause, ma ciò non ha rapporti col vero. È la natura che regola la vita e organizza i dolori di queste regioni. Il disastro economico non ha altra causa. Il moltiplicarsi dei re, dei viceré, la muraglia interminabile dei preti, l’infittirsi delle chiese come dei parchi di divertimento e poi degli squallidi ospedali, delle inerti prigioni, non ha un diverso motivo. È qui, dove si rifugia l’antica natura, già madre di estasi, che la ragione dell’uomo, quanto in essa vi è di pericoloso del Regno dei rei, deve morire. La dicotomia tra natura selvatica e l’innesto della cultura dell’uomo, simboleggiata ne “L’ulivo e l’olivastro”
Ecco, abbiamo visto delle immagini della natura, nel Meridione, commentate dalle bellissime parole di una scrittrice napoletana, Anna Maria Ortese, parole tratte dal libro: “Il mare non bagna Napoli”. È l’eterno dilemma di queste zone del Meridione, fra natura e ragione, fra natura e cultura. Ma è un dilemma antichissimo, che appartiene ai primordi della nostra civiltà, già alla civiltà greca. C’è una immagine molto bella, un simbolo molto bello, nel primo nostro grande romanzo, romanzo mediterraneo e romanzo della civiltà occidentale, che è l’Odissea di Omero, quando Ulisse, dopo la tempesta, approda a Scherìa, nel Regno dei Feaci. Dopo il disastro approda nudo, martoriato dalla tempesta e “si rifugia” – dice il poeta – sotto un albero, che è un ulivo, un ulivo e, insieme, dallo stesso tronco, anche un olivastro. Gli interpreti di questo simbolo omerico hanno sempre giustamente interpretato come la dicotomia, il contrasto fra quella che è la natura selvatica e quello che è l’innesto culturale dell’uomo nella natura. La natura a volte può essere serena, può essere idilliaca e può captare e addormentare in questa sua serenità. È la natura dei poeti bucolici, dei poeti idilliaci. Ma c’è una natura anche violenta, c’è la natura che distrugge l’uomo, c’è la natura dei vulcani, la natura dei terremoti, la natura delle alluvioni. E quindi l’uomo con la sua cultura, deve intervenire per correggere questa violenza della natura, guardarsi dalla seduzione della natura da una parte e poi, correggere, attraverso la cultura, la tecnica, perché l’ulivo non è altro che il frutto di un innesto. È una invenzione agricola quella dell’innesto dell’ulivo, che è poi l’albero del nostro Meridione.
STUDENTESSA: Lei ha parlato di correzione nella natura. Perché l’uomo non può proteggersi semplicemente allontanandosi da quelle che sono le zone a rischio, invece di modificare ciò che è naturale, il mondo che gli è stato dato?
CONSOLO: Le eruzioni dei vulcani sono difficili da correggere. Quando il vulcano si sveglia, come è successo al Vesuvio con la tragedia di Pompei – va bene, allora non c’era la tecnica di adesso – vengono sepolte dalla lava e dai lapilli intere città. Molti dei villaggi dell’Etna sono stati distrutti e poi ricostruiti. È difficile correggere la natura violenta, correggere una tempesta, correggere un’alluvione. Oggi la tecnologia ha fatto dei passi avanti. L’ultima eruzione dell’Etna, per esempio, è stata corretta da una persona straordinaria, che è Barbieri della protezione civile – che oggi si trova nel Kosovo – cercando di deviare il flusso della lava, per salvare dei paesini delle falde dell’Etna, buttando con gli aeroplani dei blocchi di cemento e facendo deviare questa lava. L’uomo può intervenire, può correggere. Ma molto spesso questa natura, più che corretta, nel nostro Meridione soprattutto, è stata violentata, è stata disastrata dalle varie speculazioni.
CAPITOLO 15
IL VOLTO DEL MEDITERRANEO
HA IL SORRISO DI CONSOLO
Vincenzo Consolo è senza dubbio, come ha sancito la critica più attendibile, uno dei maggiori narratori del secondo Novecento: un Meridiano, curato da Gianni Turchetta nel 2015 e introdotto da Cesare Segre, raccoglie l’opera completa dello scrittore siciliano, come si fa per gli autori entrati nell’albo dei classici. Non è uno scrittore facile, Consolo, ma di quelli che hanno un riconoscimento sicuro non solo per la sua visione della storia, ma anche grazie alla assoluta originalità dello stile con cui la storia viene raccontata e in qualche misura sfidata: una scelta «archeologica» che richiede una continua ricerca e una perenne voglia di sperimentare. Quando gli si chiedeva dove si collocava idealmente come scrittore, Consolo rispondeva in prima battuta pensando al linguaggio e denunciando il rifiuto di uno stile comunicativo: pertanto tra i due filoni letterari definiti un po’ artificiosamente in codice, quello monolinguista e quello espressionista, Consolo optava decisamente per il secondo, in parte verghiano, in parte gaddiano-barocco. Lui che era stato per una vita amico di Leonardo Sciascia diceva di porsi, per le scelte stilistiche, sulla sponda opposta: non solo rispetto a Sciascia, ma anche rispetto a Tomasi di Lampedusa, Moravia, Morante, Calvino. E riteneva fallita l’utopia unitaria di Manzoni, che pure considerava un modello «sacra mentale» per la capacità di mettere in scena la storia (quella secentesca) come metafora universale. Quell’utopia era fallita perché era naufragata, secondo Consolo, la società italiana moderna, da cui era nata una superlingua piatta, tecnologico-aziendale e mediatica, che faceva ribrezzo anche a Pasolini, per il quale l’omologazione linguistica (con il conseguente tramonto dei dialetti) era il segno più visibile di un nuovo fascismo.
Dunque, per Consolo l’opzione linguistica ha una valenza non estetica ma politica, di resistenza e di opposizione, che si traduce sulla pagina in una moltiplicazione di livelli, di generi, di registri, di stili, di voci: la sua è una lingua di lingue, cui si accompagna la pluralità dei punti di vista, una lingua ricchissima, un impasto di dialetti, preziosismi, arcaismi, echi dal greco, dal latino, dallo spagnolo, dal francese, dall’arabo, eccetera, il miscuglio dei depositi di civiltà sedimentati nella storia siciliana. (Paolo di Stefano, Corriere della sera)
Se per Consolo la letteratura è memoria dolorosa e irrisolta, essa è alimentata da una memoria linguistica altrettanto dolorosa, conflittuale e composita. Anche per questo, è giusto inserire Consolo dentro la vasta e plurima cultura mediterranea, come suggeriva il convegno milanese del 2019, di cui ora vengono pubblicati gli atti (Mimesis, pagine 233, e 20), a cura di Turchetta, sotto un titolo molto significativo: «Questo luogo d’incrocio d’ogni vento e assalto», tra virgolette perché così lo scrittore intendeva il Mediterraneo, ma anche la Sicilia, che ne era (ne è) la sintesi.
Inutile negarselo. Leggere il capolavoro di Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, non è una passeggiata: ma si pone nel solco della narrativa sicula sui moti risorgimentali, dal Mastro don Gesualdo di Verga a I vicerè di De Roberto al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, quella narrativa che affronta il Risorgimento come un grumo di opportunismi, di miserie, di compromessi, di astuzie, di contraddizioni mai veramente superate. Ma Consolo lo fa a modo suo, con tutta la diffidenza per le imposture della storia (si è parlato di anti-Gattopardo), facendo dialogare tra loro i documenti, frammentando i punti di vista e moltiplicando le voci. Del resto, non è una passeggiata neanche leggere i grandi europei dell’Ottonovecento, ma ciò non toglie nulla alla loro grandezza e al piacere della lettura, anzi è una conquista di senso ad ogni frase. Il fatto è che la scrittura di Consolo viene fuori da un rovello morale e civile, non certo da una felicità narrativa spensierata. Ma i nodi e le interferenze inattese, simmetriche alle tragiche e spesso incomprensibili emergenze storiche, come ha scritto Cesare Segre, sono narrate in una prosa ritmica, «quasi colonna sonora di un viaggio nella storia che è anche, o soprattutto, giudizio sul tempo presente».
Un «passo di danza», lo chiamava Consolo, che deriva anche dalla sensibilità lirica (accesa certamente dall’ammirazione per il poeta «barocco» Lucio Piccolo, il barone esoterico di Capo d’Orlando, cugino di Tomasi). Musica della narrazione e implicito richiamo (per ipersensibilità etica) al presente sono la benzina dei suoi libri, si tratti dei romanzi, dal libro d’esordio La ferita dell’aprile (1963), romanzo di formazione autobiografico sul dopoguerra, si tratti di quel viaggio irreale nella Sicilia del Settecento che è Retablo (1987), fino a Nottetempo, casa per casa (1992) e a Lo spasimo di Palermo (1998).
Si tratti dei saggi-racconti-reportage de Le pietre di Pantalica o de L’ulivo e l’olivastro o delle sequenze di quello specialissimo incrocio tra «operetta morale» e cuntu popolare (così Turchetta) che è Lunaria, definita dall’autore una «favola teatrale». Il sorriso dolceamaro di Vincenzo assomigliava a quello dipinto da Antonello da Messina nella tavoletta che ispirò il suo capolavoro, ma si aggiungeva un che di dispettoso e di infantile, e soprattutto si accendeva o si oscurava, da lontano, al pensiero della Sicilia. L’ossessione di Consolo, come quella di tanti scrittori siciliani (tutti?), era la Sicilia, da cui partì verso Milano poco più che ragazzo prima per studiare, negli Anni 50, poi definitivamente nel 1968.
I 58 elzeviri pubblicati sul «Corriere» non tradiscono la ferrea fedeltà verso la sua isola, a cominciare dal primo, datato 19 ottobre 1977, sulla «paralisi» della Sicilia paragonata alla malinconia di cui è vittima il «lupanariu», ovvero colui il quale è colpito dai malefici del lupo mannaro nelle notti di luna piena. Ricordava, Consolo, che da studente dell’Università Cattolica, alloggiando in piazza S. Ambrogio, vedeva dalla sua finestra i minatori che dal vicino centro di smistamento immigrati, dopo la selezione medica, il casco e la lanterna in mano, salivano sui tram per prepararsi a partire, dalla Stazione Centrale, verso i bacini carboniferi del Belgio, e qualcuno certamente sarebbe andato a morire a Marcinelle o in altre miniere… Lo raccontò anche in un articolo del 1990 in cui recensiva i primi libri-testimonianza dei migranti africani che allora si chiamavano «extracomunitari» o «vu’ cumprà». Sono, è evidente, interventi sempre militanti, come quelli pubblicati per una vita in altri giornali: «L’Ora», «Il Messaggero», «La Stampa», «il Manifesto», «L’Espresso».
Il 21 novembre 1989 gli toccò ricordare l’amico e maestro Leonardo, morto il giorno prima a Palermo. Cominciava evocando i luoghi reali e quelli immaginari dell’amico e accostandoli a quelli di Faulkner e di Camus: «Racalmuto, Regalpetra: la sua Yoknatapawpha, la sua Orano. La sua, di Leonardo Sciascia. Credo che non si possa capire questo straordinario uomo e questo grande scrittore, al di là o al di qua del più vasto teatro della Sicilia, dell’Italia o della civiltà mediterranea, senza questo piccolo mondo, questo suo piccolo paese di nascita e formazione, sperduto nella profonda Sicilia. Un paese “diverso”, singolare». Tutto diverso e singolare, in Sicilia, tutto è originale.
CAPITOLO 16
UN MESE CON VINCENZO CONSOLO
Dal 19 gennaio è iniziato il mese di manifestazioni culturali dedicato allo scrittore siciliano Vincenzo Consolo, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi scrittori in assoluto del secondo novecento.
Tutta la sua opera è stata dominata dal dolore per la sua amata isola, la Sicilia, terra emarginata dalla storia e, particolarmente nella trilogia, dalla sconfitta del proletariato ad opera della classe dominante, che ha scritto anche le vicende umane, come assecondate nella vittoria dalla ineluttabilità del destino, che la classe subalterne non ha potuto contrastare perché ancora ingannata dall’analfabetismo.
Ne deriva l’esortazione dello scrittore ai giovani, affinché imparino a studiare, perché solo attraverso la conoscenza, possono acquistare la consapevolezza del loro protagonismo nell’acquisizione di una coscienza della legalità, del diritto e del sapere gestire e riscattare il loro destino scaturito dall’immobilismo.
Con il presente saggio, anche noi desideriamo partecipare all’omaggio doveroso verso lo scrittore che, come Sciascia, ha saputo leggere la dolorosa genuflessione degli emarginati di fronte all’arbitrio crudele dei potenti.
CAPITOLO 17
IL SIMBOLO DELLA LUMACA
STUDENTESSA: Abbiamo letto una citazione dal Suo libro, “Il sorriso dell’ignoto marinaio”, in cui Lei fa una similitudine tra il potere borbonico e una lumaca. Volevamo sapere il senso di questa similitudine.
CONSOLO: Sì, la lumaca è un simbolo che ho preso dagli studi sulle lumache del protagonista del mio romanzo, il barone di Mandralisca. Voi sapete che il guscio della lumaca ha un andamento a spirale. Ora la spirale è un segno molto antico. Rappresenta appunto questa ascensione dal basso verso l’alto, oppure può significare anche lo sprofondare e il perdersi, perdersi all’apice di questa stessa spirale. Ed è anche il simbolo, per studiosi di etnologia e di storia delle religioni, è anche il simbolo del labirinto. Ecco, dal labirinto, con intelligenza, si può uscire, oppure si può rimanere prigionieri. Ecco, quel simbolo io l’ho preso come il simbolo della storia, per cui i popoli, le popolazioni che si trovano in una infelicità sociale, possono rimanere prigionieri dentro questo labirinto a forma di spirale, oppure, seguendo il labirinto, possono uscire verso la realtà della storia e prendere consapevolezza della loro condizione sociale. Ecco, è questo il simbolo della lumaca.
STUDENTE: Quindi nel Meridione la cultura si dovrebbe staccare dalla religione?
CONSOLO: Non credo che si debba staccare. La religione è una grande tradizione culturale. Lo vediamo nelle feste religiose e in tante altre manifestazioni della religione. Il rischio è che la religione diventi superstizione. Superstizione significa annullamento di quella che la Ortese chiama: “la ragione”. Ecco la religione dev’essere qualcosa di veramente scoperto, di veramente sentito, che non ha bisogno di orpelli, che non ha bisogno di iconografie eclatanti per essere vissuta. La religione è un fatto che si vive all’interno della nostra coscienza, della nostra mentalità. Io credo che ogni religione sia valida, non solo quella cristiano-cattolica, ma le religioni del mondo, perché le religioni sono quelle culture che insegnano ad avere rispetto dell’uomo, innanzi tutto come immagine di Dio. Almeno tutte queste religioni, tutte le religioni suggeriscono questo concetto: l’abolizione della violenza e il rispetto dell’altro individuo, dell’altro che è fuori di noi. La religione insegna di rispettare l’uomo come immagine di Dio.
STUDENTE: Quindi la religione nel Sud non ha frenato la cultura?
CONSOLO: In certe forme deteriorate, quando la religione diventa inganno, quando la religione diventa “sonno della ragione”, come dicevano gli illuministi francesi, allora è stata una remora. Però la religione nel Meridione è stata anche educazione delle popolazioni. Non esistevano le scuole, le scuole erano le Parrocchie. Lì veramente l’individuo imparava che cosa era, non solo i beni materiali, questo affanno della conquista dei beni materiali, ma era anche un’educazione dello spirito, un’educazione alla fraternità e, come dicevo prima, alla consapevolezza che ogni individuo è una creatura di Dio e quindi deve essere rispettato e, come dice la religione cristiana, deve essere anche amato.
STUDENTESSA: Abbiamo portato come contributo “Mastro Don Gesualdo” di Verga, perché abbiamo pensato che Verga sia una figura emblematica di intellettuale del Sud. Ora Lei cosa pensa della figura dell’intellettuale del Sud, in quanto lei stesso rappresenta oggi l’intellettuale?
CONSOLO: Vorrei narrarVi brevemente la storia umana e letteraria di questo scrittore. Giovanni Verga è stato forse uno dei primi intellettuali meridionali che ha lasciato la propria terra ed è emigrato prima a Firenze e poi a Milano. C’è stato sempre, da Verga in poi, una sorta di assillo, da parte degli intellettuali meridionali, proprio perché si sentivano di abitare una periferia, di raggiungere il centro. Il centro, al tempo di Verga, parliamo della fine dell’Ottocento, era innanzi tutto Firenze, che era il centro della lingua, della cultura, Firenze del Rinascimento, Firenze dei grandi scrittori toscani.
Il suo primo approdo è stato proprio Firenze. Poi da Firenze si è spostato a Milano, dove incominciava quella che si chiama “l’industria culturale”, cioè incominciavano ad aprirsi le prime case editrici. E quindi questo spostamento Verga lo ritenne necessario. Lui arrivò a Milano nel 1872, pensando di trovare una città immobile nei suoi riti e nei suoi gesti, con i salotti delle varie contesse, che ricevevano gli scrittori, con questi riti mondani. Verga, sino a quel momento, aveva scritto dei romanzi, che vengono connotati appunto come “romanzi mondani”. Ecco, lì si trova in una città in grande subbuglio. Milano allora aveva la Prima Rivoluzione Industriale. Quindi c’era un processo di inurbamento, dalla periferia, dalle campagne, a Milano si aprivano le prime fabbriche. Soprattutto la fabbrica della Pirelli, che lavorava la guttaperga, come si diceva, la gomma. E con questa prima industrializzazione lombarda incominciarono i primi conflitti sociali, tra il “padrone” e il lavoratore. I lavoratori chiedevano i diritti.
Verga si trovò di fronte a questo mondo in subbuglio che non riusciva a capire, perché aveva una memoria contadina e quindi concepì quella sua rivoluzione stilistica, quel “salto di genio”, come lo chiamò De Benedetti, che lo portò alla sua seconda stagione letteraria, che era la stagione del verismo, da cui poi incominciarono le prime novelle: Nedda, per passare poi a I Malavoglia e quindi a Mastro Don Gesualdo. E immagina una concezione dell’uomo immutabile, dove la storia non può intervenire, perché l’uomo è condannato dal Fato, dal destino e non può fare niente per modificare questo suo destino.
STUDENTESSA: Non pensa che questo rapporto di violenza e anche di simbiosi con la natura, non abbia portato qualcosa in più alla cultura dell’uomo meridionale, cultura intesa come atteggiamento culturale dell’uomo? Lei non pensa che questo abbia dato qualche cosa in più allo sviluppo dell’intellettuale meridionale?
CONSOLO: Certo, ha portato a questa organizzazione sociale del nostro Meridione, soprattutto dei piccoli villaggi, dei paesi, a una grande comunicazione, a un grande scambio culturale, soprattutto a quella che era la cultura della tradizione, i racconti che si facevano di vicende locali. E quindi questo era un arricchimento. D’altra parte questa è una ricchezza di tipo mediterraneo: il racconto orale, che si tramanda da una generazione all’altra, di vicende, di fatti importanti, ma anche di fatti minimi e quindi un maggior accumulo di memoria nelle popolazioni meridionali, soprattutto negli intellettuali.
Gli intellettuali sono quelli che memorizzando poi attingono a questo prezioso patrimonio, che è la memoria, per cercare di interpretare e di esprimere il mondo. Io credo che tutti gli scrittori – meridionali soprattutto – abbiano avuto questa grande ricchezza memoriale, da Verga, di cui parlavamo poco fa, a Pirandello, a tutti gli scrittori, ad Anna Maria Ortese, ai grandi scrittori napoletani, calabresi, pugliesi. Forse è dovuto al clima, alla nostra tradizione, alla nostra mediterraneità, c’è un maggiore scambio, perché nel Meridione esiste la piazza.
Ecco, la piazza che è l’antica agorà greca, dove la gente si riuniva per raccontare, per dare giudizi sulle cose, soprattutto sulla vita pubblica, su quella che era la vita sociale. E questo significa uscire fuori dalla solitudine, uscire fuori dal monologo e arrivare al dialogo, che è quello che stiamo facendo noi oggi qui. Ecco, il dialogo è una cosa importante, confrontare i giudizi, le opinioni, il pensiero.
Questa è una ricchezza enorme, che oggi nel mondo, che chiamano “globalizzato”, in questo mondo in cui la vita dell’uomo si è verticalizzata, nel senso che ormai viviamo in queste nostre case alte, ognuno chiuso nel proprio appartamento, a guardare soltanto quello che le immagini ci vogliono dare e ci restituiscono, si è perso il senso della comunicazione orizzontale, cioè il senso della piazza. Però nel Meridione tutto questo resiste ancora. E credo che sia una grande risorsa per le zone meridionali.
STUDENTESSA: Quindi pensa che il Meridione sia una specie di Grecia antica ancora viva? Cioè che questo enorme patrimonio culturale che ci hanno lasciato gli antichi sia ancora vivo nel Meridione?
CONSOLO: Sì, dobbiamo cercare di non mitizzare, ma c’è ancora questa dimensione di cui parlavo, della piazza, del dialogo, del confronto, quando non è ucciso da quelli che sono i messaggi dei media. I messaggi dei media che cercano di darci una realtà così com’è. È scelta da loro, non è scelta da noi, è una realtà appunto mediata, non originale.
Però, in confronto a quelle che sono le zone nordiche, dove la possibilità di stare fuori nella piazza è minore, da noi, questo che tu chiami “retaggio greco”, forse c’è ancora, esiste, quando poi non traligna e non diventa aggressione, non diventa violenza.
STUDENTE: Quanto conta, secondo Lei, la produzione culturale degli intellettuali a contribuire al risanamento di quella che è la condizione sociale ed economica del Meridione?
CONSOLO: Potrebbe contribuire molto. Io ricordo un grande intellettuale, Gaetano Salvemini, pugliese, di Molfetta, che ha delle pagine violente nei confronti degli intellettuali meridionali. Li chiama: “piccolo-borghesi”. Soprattutto dell’Università di Napoli, lui è dell’Università di Messina, di cui aveva fatto esperienza. Ecco, dice che questi intellettuali “piccolo-borghesi”, molto spesso, sono diventati “amorali e cinici”, cioè hanno la possibilità di studiare, di diventare classe dirigente e poi tradiscono quello che è la loro matrice, la matrice popolare fanno da anello di congiunzione, da mediatori, fra quelli che detengono il potere, i padroni e quelle che sono le classi popolari. Fanno da mediatori e tradiscono le istanze storiche delle classi meridionali.
Naturalmente Salvemini parlava della fine dell’Ottocento. È morto nel ‘57 e quindi la sua esperienza risale a quegli anni. Però le colpe dei problemi meridionali sono da attribuire, anche alla prevalenza economica del Nord, ma sono da attribuire soprattutto al compromesso e al trasformismo degli intellettuali meridionali.
STUDENTESSA: Al Sud esiste concretamente la possibilità di fare cultura senza dover emigrare altrove?
CONSOLO: Credo che adesso non sia più necessario emigrare. Credo anzi che contrariamente al periodo in cui io sono andato via, oggi l’intellettuale nel Meridione possa riscoprire dei valori – e anche delle possibilità – che altrove non esistono.
Altrove c’è la cosiddetta industria culturale, ci sono i grandi giornali, ci sono le grandi case editrici che purtroppo oggi tendono a omologare tutto, a produrre quella cultura che è soltanto all’insegna del profitto e del messaggio pubblicitario.
Qui ancora, dove lo scrittore, il cantante, l’uomo di teatro non ha, diciamo, queste mete dell’assoluto profitto, perché non ci sono le grandi concentrazioni dell’industria culturale, qui l’intellettuale può ancora avere possibilità di riscoprire quella che è la cultura meridionale. Per esempio a Napoli c’è una grande rinascita del teatro e del cinema napoletano.
Ecco, in campo letterario il discorso è un po’ diverso perché tutti ormai tendiamo a ubbidire a quelli che sono i messaggi che l’industria ci impone. Naturalmente ci sono ancora degli scrittori che disobbediscono a queste leggi non scritte, ma molto impositive e molto dure. Ma ripeto, in campo cinematografico e in campo teatrale, ci sono delle nuove forze, molto vivaci, che agiscono qui, nel Meridione. Parlo di Napoli, ma potrei parlare anche di Palermo. C’è un nuovo teatro, un nuovo cinema, c’è anche una nuova letteratura, che stanno nascendo, molto vivaci e molto interessanti.
STUDENTESSA: Sciascia si poneva il problema della mafia, se questa si affermava nel momento in cui lo Stato era assente e veniva meno alle sue funzioni. Secondo Lei, le organizzazioni mafiose dove si sviluppano e quando?
CONSOLO: Si sviluppano nel “vuoto dello Stato”, come diceva appunto Sciascia. Sciascia era un grande illuminista, apparteneva veramente a quella schiera dei grandi illuministi meridionali, da Croce a Salvemini e a tantissimi altri.
A un certo punto, dopo aver scritto Il Consiglio d’Egitto, che era proprio un romanzo sull’Illuminismo e sul giacobinismo meridionale, siciliano, allora capì che il problema più impellente per la Sicilia era proprio il problema della mafia. E in tutti i suoi romanzi cercò di indagare quelle che erano i rapporti della classe politica con i mafiosi, che era il male atavico della Sicilia, questo del “vuoto dello Stato” e del connubio fra quelle che erano le istituzioni dello Stato con questa piaga siciliana che si chiama “mafia”.
Oggi questa mafia non ha più i confini dell’isola. Purtroppo è uscita fuori da questi confini ed è straripata da per tutto. Sappiamo che è emigrata in America e in altre parti del mondo. Oggi si parla di “mafia russa”, si parla di altri tipi di mafia.
STUDENTESSA: Gli eventi che si sono susseguiti nel Mezzogiorno hanno favorito una cultura che è particolare e che è tipica proprio del Mezzogiorno. È possibile che in questo campo il Mezzogiorno sia superiore rispetto a tutte le altre culture?
CONSOLO: Non bisogna mai parlare di superiorità e inferiorità. Bisogna, credo, parlare di diversa cultura. Anche nelle culture più arcaiche, più tribali, ci sono delle ricchezze che noi non sospettiamo. Penso alle culture del Centro-Africa, per esempio. Loro hanno una cultura rispettabilissima.
Mi ricordo che tempo fa morì un grande intellettuale africano e un premio Nobel disse che quando muore uno di questi uomini è come se si bruciasse un’intera biblioteca, perché lì, naturalmente, non esistono i libri, non esistono le biblioteche o le case editrici, ma c’è questa grande cultura orale che viene trasmessa da una generazione all’altra.
Quindi la morte di un uomo così significa appunto la distruzione di una cultura se non viene tramandata, se questa cultura si interrompe. Quindi noi non possiamo sentirci superiori agli abitanti dell’Uganda, per esempio, o di qualsiasi altro popolo che a noi sembra arretrato, perché la cultura e la civiltà non è lo sviluppo economico, lo sviluppo tecnologico.
La cultura è qualcosa che riguarda l’individuo, non la tecnologia, quella che Pasolini chiamava, parlando dell’Italia: “lo sviluppo senza progresso”.
STUDENTESSA: Il degrado economico e sociale in cui si trova il Meridione, può avere influito sulla creazione del degrado culturale? E, se sì, in che modo?
CONSOLO: Senz’altro. Il degrado economico che ha delle ragioni, ma anche delle responsabilità ben precise. Si è puntato – parlo dal secondo dopoguerra in qua, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dalla caduta del fascismo, non parliamo dei disastri che erano avvenuti prima, dall’Unità d’Italia in poi – soltanto a una unidimensionalità. È quella unidimensionalità a cui il mondo va oggi incontro, a quella che si chiama la “globalizzazione”, dove l’unica direttiva è soltanto l’economia.
Ma l’uomo non è fatto di economia. L’uomo è fatto di tanti altri valori che non sono quelli materiali. E allora noi progrediamo, cioè in questo mondo globalizzato si progredisce economicamente, ma si perde di interiorità. E quindi diventa una spirale senza fine. L’uomo cerca di consumare soltanto i beni e non pensa a riempire quella che è l’interiorità.
L’interiorità – lo spirito – si riempie con la cultura, con quelli che sono i valori spirituali. Ecco, questo lo diceva un filosofo spagnolo, Fernando Savater, che si è occupato molto anche di educazione dei giovani. Diceva appunto che l’alienazione di oggi sta proprio nel consumismo, nel cercare continuamente dei beni e dei beni nuovi da consumare – la macchina nuova, la casa nuova, il frigorifero nuovo – e svuotandoci di quella che è la ricchezza interiore, cioè la cultura e i valori umani. Questa oggi è la dimensione, purtroppo, di tutto il mondo, questa dimensione soltanto economica. Dovremmo riscoprire questi valori di cui ci stiamo impoverendo a poco a poco.
STUDENTESSA: Le strutture economiche, politiche e sociali sono legate all’immaginario, quindi alla cultura. Ma sono queste strutture che fanno le idee, o viceversa, sono le idee a fare queste strutture?
CONSOLO: Dobbiamo essere noi a immaginare che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo costruire. Quindi è un’espressione della nostra cultura e del nostro spirito. Non deve essere una cosa che ci viene imposta, che ci viene proposta come un oggetto assolutamente necessario e indispensabile, se non è ideato e pensato da noi. Sono le idee che creano le cose, il che significa avere un atteggiamento attivo nei confronti dell’oggettualità, questo è il significato della libertà dell’uomo.
STUDENTESSA: Quindi l’economia del Mezzogiorno non ha avuto poi una forte influenza sulla cultura del Mezzogiorno?
CONSOLO: Sì, non ha avuto una forte influenza perché è stata un’economia bloccata, per delle ragioni precise.
Per quanto riguarda il Meridione, per esempio, è stata una grande sciagura – lo dice anche Croce – la persistenza del latifondo. Vi potrei parlare del latifondo siciliano.
Era un’ingiustizia sociale e storica, che è durata nei secoli, per volere di quelli che erano i poteri, prima il potere spagnolo e poi il potere borbonico, per la prepotenza di quelli che erano i baroni, i latifondisti, di questi baroni anarchici che ricattavano il potere dei re, dei viceré e che cercavano di mantenere immobili queste nostre zone e contrade.
Con quello che significa il latifondo per sfruttamento dell’uomo, umiliazione dell’uomo e anche il depauperamento di quello che era il patrimonio agricolo delle nostre zone. I terreni lasciati incolti o sfruttati sino all’inverosimile sono dei problemi di cui tutti i meridionalisti si sono occupati.
STUDENTE: In che modo il susseguirsi di governi stranieri, delle dominazioni, ha influito sulla cultura? Anche il governo dei Savoia si può dire che sia stato un governo straniero. In che modo poi ha influito sulla cultura del Meridione? Per esempio, ci sono anche delle testimonianze che i Savoia hanno chiuso molte scuole pubbliche nel Meridione, nei vari paesi del Sud.
CONSOLO: Sì, anche i Savoia erano degli stranieri, come i Borboni, come i Castigliani o come gli Aragonesi e tutte le dinastie che abbiamo avute nel nostro Meridione.
Croce indica un momento felice del Meridione soltanto nella monarchia angioina. Dice che è stato un momento veramente glorioso della cultura meridionale, il Regno di Napoli, nel momento in cui qui si erano varate delle leggi che, per quell’epoca, per l’Alto Medioevo, erano delle regole che ancora in Europa non esistevano, cioè il suffragio delle popolazioni, ma anche il rispetto della vita umana.
A Napoli poi c’è stata, dopo il cambio di questo potere, di questo Regno, proprio per queste leggi che erano ormai entrate nella cultura e nella mentalità del popolo, c’è stata una ribellione perché a Napoli non si voleva il Tribunale dell’Inquisizione.
Croce per esempio, giudicò i Vespri Siciliani una grande iattura, quella che negli storici dell’Ottocento era considerato come una ribellione di popolo alla ricerca della libertà, soprattutto degli storici romantici dell’Ottocento. I Vespri Siciliani hanno tolto il Regno di Sicilia ai Francesi e l’hanno consegnato agli Spagnoli.
Gli Spagnoli poi hanno portato tutti i mali possibili, confermando quelli che erano i privilegi dei baroni, dei feudatari, portando il Tribunale dell’Inquisizione in Sicilia, ma non solo in Sicilia, anche nelle zone meridionali, come la Puglia e la Calabria. E quindi c’è stato un momento di grande progresso in queste regioni, che poi purtroppo si è arrestato.
Si è arrestato ed è durato secoli questo regresso del Meridione, per cui, poi, è nato quel problema che noi chiamiamo meridionale. Io Vi posso raccontare un aneddoto di quello che era la mentalità dei signori, dei feudatari del luogo.
Questo aneddoto me lo ha raccontato un pronipote di Garibaldi. Io sono tanto vecchio, che ho fatto in tempo a conoscere un pronipote di Garibaldi. Si chiamava Canzio Garibaldi ed era Direttore del Museo del Risorgimento di Milano.
Mi raccontava che lui, la madre e i suoi fratelli erano stati ospiti di una baronessa calabrese. Erano venuti in questo castello della baronessa calabrese e la madre di Canzio Garibaldi si accorse che tutti i bambini del paese soffrivano di tracoma, avevano questa malattia infettiva agli occhi, che era allora un male di cui soffriva tutto il Meridione. Questa signora incominciò a curare i bambini, a pulire gli occhi di questi bambini. E la baronessa quando si accorse di questa attività della signora Garibaldi, le fece capire che non erano più ospiti graditi nel suo castello.
Quindi dovettero fare le valigie e andarsene. Per dirVi che cos’era la mentalità di questi feudatari nel nostro Meridione di allora. Cioè volevano tenere le popolazioni in quel disagio, non solo di malattia, ma anche di ignoranza. Non volevano ammettere che ci fosse la scuola d’obbligo, per esempio.
Ci sono stati molti che si opponevano all’istituzione della scuola dell’obbligo. E questo è durato anche con l’Unità d’Italia e con i Savoia.
STUDENTE: Solamente qualche altro governo straniero potrà migliorare le condizioni del Sud, qualche altro governo potrà aiutare a migliorare le condizioni dei tracoma negli altri bambini nel Sud?
CONSOLO: Per fortuna non c’è più il tracoma e i governi stranieri non ci servono più. Siamo noi che dobbiamo formare i governi, siamo noi, scegliendo gli uomini e capendo chi bisogna mandare in questo Parlamento che dirige le nostre sorti, non solo i Comuni e le Regioni, quelle che sono le amministrazioni locali, ma anche le amministrazioni centrali.
Dobbiamo capire noi quali sono gli intellettuali, perché i politici, come diceva Gramsci, sono degli intellettuali, sono quelli che mettono in atto le filosofie, le idee. Se sono dei “piccoli-borghesi, cinici e immoralisti”, come diceva Salvemini, o se sono delle persone probe che vogliono veramente il bene del paese.
STUDENTESSA: Prima si è parlato della mercificazione dell’arte e quindi della prostituzione di molti intellettuali. Oggi l’intellettuale che non vuole obbedire alle leggi di mercato, ha la possibilità di esprimersi, o viene tagliato fuori?
CONSOLO: Noi oggi viviamo in democrazia, non siamo più nel periodo delle dittature dei fascismi, per fortuna, qui nel nostro paese, in Italia. E quindi ognuno ha la libertà di esprimersi in qualsiasi modo, artisticamente, ideologicamente.
C’era la famosa frase – una frase terribile – di Mussolini, riferita a Gramsci: “Questo cervello non deve più funzionare”. E Gramsci l’hanno fatto morire in carcere. Ecco questo, per nostra fortuna, dopo la Guerra di Liberazione, dopo la conquista della libertà, non capita più. Però vi sono delle dittature molto più sottili, invisibili, che sono le dittature economiche, i patronati, quelli che detengono in mano le leve della produzione culturale.
Non sto qui a dilungarmi. Sono i proprietari dei giornali, delle Case Editrici, delle Gallerie d’Arte. Loro decidono che cosa veicolare e che cosa lasciare ai margini. Soprattutto oggi con la rivoluzione dei mezzi di comunicazione di massa, qualsiasi voce, se non è supportata da questi mezzi di comunicazione di massa, può essere seppellita e ignorata.
Oggi allo scrittore, all’artista, si richiede il presenzialismo, la ribalta. E guai chi non calca queste ribalte, perché non ha esistenza, viene ignorato! A volte, poi, possono succedere delle cose straordinarie, malgrado l’essere appartato. Come è successo, per esempio, ad Anna Maria Ortese.
Anna Maria Ortese era una scrittrice molto rigorosa con se stessa e con gli altri, che ha vissuto una vita appartata e, malgrado questo, era una scrittrice che ha avuto molto eco, è stata letta da molti lettori.
STUDENTE: Pino Daniele è il tema della ricerca che abbiamo fatto su Internet. Pino Daniele rappresenta un po’ la figura del musicista napoletano che ha rilanciato la musica napoletana in tutta l’Italia. Come la cultura musicale, può anche il patrimonio culturale del Mezzogiorno uscire oltre i propri confini?
CONSOLO: Credo di sì, soprattutto la musica che è un linguaggio universale e quindi ha una maggiore possibilità di diffondersi, di uscire fuori dai confini, se è una musica vera, che interpreta quelli che sono i sentimenti degli uomini. Credo che la musica sia la prima delle arti.
C’è stato Kant che ha fatto una classificazione delle arti e ha detto che: “le arti sono tanto più arte, quanto meno materia hanno”. E allora partiva dalla musica, poi la poesia.
Ecco la musica è puro suono, poi la poesia, che è parola e poi la pittura, la scultura. Secondo Kant, quanta più materia c’era nell’espressione artistica, tanto meno arte c’era. Ma io credo che queste classificazioni non si possono fare. È certo che la musica ha un linguaggio universale, quindi è quella che ha maggiore diffusione.
CAPITOLO 18
SCRITTI DI SICILIA “COSE DI COSA NOSTRA”
Uno scrittore così intimamente legato alla sua Sicilia, con tormento, con affetto, con dolore, con speranza, non poteva non confrontarsi con la questione mafiosa che, purtroppo, in larga parte ha segnato un pezzo di storia dell’isola; e questa ambivalenza trova espressione nell’uso dell’immagine omerica dell’olivo e dell’olivastro, che aveva già dato il titolo ad uno dei suoi libri, per spiegare «il duplice atroce destino della Sicilia» (p. 257). Consolo è stato poeta delle “profondità”, romanziere che non ha avuto mai timore a scandagliare le viscere più inquiete e meno consolatorie, e poi tentare, cercare di trovare, d’offrire spiegazioni e, come nel “Sorriso dell’ignoto marinaio”, suggerire soluzioni, vie d’uscita, a volte di fuga. Ogni suo romanzo, ogni sua parola rimanda alla Sicilia, alla sua bellezza e alle sue tragedie.
Il 23 maggio del 1992 sull’autostrada a Capaci esplode il tritolo in un Paese allo sbando, senza classe dirigente e con incerte istituzioni. Ai mesi di quell’estate rimandano le ultime pagine del romanzo “Lo Spasimo di Palermo” scritto, sin dall’inizio, con parole marchiate da sangue, dolore, malinconia, distanza: esilio dalla/nella terra dell’altra annunciata strage del 19 luglio. Bisogna partire da qui per apprezzare fino in fondo il senso di questi scritti sulla mafia, bisogna aver chiaro il rapporto dello scrittore con l’isola e con la parola decisiva: esilio.
Se la sua produzione creativa è il risultato di quella «nascita nell’isola, nell’assurdo della storica stortura, prigione dell’offesa, deserto della ragione, dissolvimento, spreco di vite, d’ogni umano bene», c’è sempre dell’altro: un carico di ragione, certamente di speranza.
Nelle ultime pagine dello “Spasimo” scrive: “(Un lume occorre, una chiara luce)”, un lume timidamente indicato tra due parentesi tonde. Una fievole luce per sopravvivere? O, forse, per meglio capire. E questa luce si apre su ogni pagina di “Cosa loro”. In un testo del luglio 2007 pubblicato sull’”Unità” in occasione dell’anniversario della strage di Via d’Amelio (“Borsellino, l’uomo che sfidò Polifemo”), quando Consolo affronta un tema cruciale riferendosi a quanti hanno creduto che la «mafia fosse qualcosa di separato dal nostro contesto civile, che essa sarebbe stata prima o dopo tagliata con un colpo d’ascia dal ceppo sano della nostra società da parte di organi a questo delegati» (p. 261), si avverte quella lucida consapevolezza propria sia di Leonardo Sciascia che di Giovanni Falcone.
In “Cose di Cosa nostra” il giudice contesta l’opinione di chi pensa che la mafia sia un soggetto esterno, un nemico che da fuori minaccia i siciliani. I mafiosi sono «uomini come noi» e, conclude, «se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia».
Più dolente Sciascia (“La Sicilia come metafora”): «Prendiamo ad esempio questa realtà siciliana nella quale vivo: un buon numero dei suoi componenti io li disapprovo e li condanno, ma li vedo con dolore e “dal di dentro”; il mio “essere siciliano” soffre indicibilmente del gioco al massacro che perseguo. Quando denuncio la mafia, nello stesso tempo soffro poiché in me, come in qualsiasi siciliano, continuano a essere presenti e vitali i residui del sentire mafioso. Così lottando contro la mafia io lotto contro me stesso, è come una scissione, una lacerazione».
A partire dal primo intervento della raccolta, un dattiloscritto probabilmente del 1969, Consolo individua nell’assenza di fiducia nello Stato la causa del radicamento e rafforzamento della mafia; egli conosce bene l’Italia all’indomani dell’Unità quando le repressioni e «il trattamento da cittadini di seconda classe da parte del nuovo governo» (p. 14) non fanno altro che perpetuare anziché risolvere quella causa, tenendo «viva la sfiducia verso lo Stato», dando «maggior fiato alla mafia in un drammatico circolo vizioso», rinfocolando l’ostilità della popolazione «e questo, a sua volta, dava motivo per altri provvedimenti repressivi» (p. 15).
Ritorna in un altro testo del 1994 denunciando come «dopo l’impresa di Garibaldi […] la mafia rafforza ancora di più in Sicilia il suo potere, fidando su una maggiore lontananza del governo centrale e sul malcontento, sulla sfiducia nel potere costituito per le nuove leggi che impongono […] nuovi obblighi, come quello della leva militare, e pesanti tasse come quella sul macinato» (p. 158). La mafia non è un fenomeno accidentale o casuale, continua a ricordarci Consolo, è l’effetto di precise responsabilità che chiamano in causa le classi dirigenti dell’isola e del Paese, sia nella fase di origine, sia nei decenni più recenti.
Da questo punto di vista, nella riflessione dello scrittore un’attenzione particolare è riservata alla critica del “Gattopardo”. In un articolo del 1986 Consolo disvela la mistificazione ideologica del «sentenzioso romanzo che è “Il Gattopardo”». Noi fummo i Gattopardi e i Leoni; quelli che ci sostituiranno…», è la sentenza del Lampedusa. Ma non è stato così: «Che i gattopardi e i leoni non sono stati del tutto sostituiti, ma che essi stessi si sono trasformati in sciacalli e iene e che forse tali sono sempre stati» (p. 64). In un altro testo del 2007, più diretto è l’obiettivo polemico: «Ma il principe di Salina ignorava o voleva ignorare che le iene e gli sciacalli, i don Calogero Sedara, erano nati e cresciuti, si erano ingrassati nelle terre, nei feudi dei suoi pari, dei nobili, mentre loro, i feudatari, se ne stavano nei loro palazzi di Palermo a passare il tempo tra feste e balli» (p. 251).
La mafia era figlia di quel sistema economico e sociale, era l’effetto di concreti comportamenti delle classi dirigenti: «Tomasi di Lampedusa, l’autore del “Gattopardo”, ignorava questo?» Insomma: «Al Salina o al Lampedusa, grande scrittore e sapiente letterato, vogliamo dire che sciacalletti e iene erano anche loro, i Gattopardi, consapevoli complici di quei mafiosi che agivano là, nei loro feudi» (p. 296).
Era già stato molto chiaro Leopoldo Franchetti nel libro dato alle stampe nel 1877. Il giovane studioso toscano, un liberale conservatore, sottolineava le gravi responsabilità della classi “abbienti” siciliane. La relazione tra mafiosi e classe dominante è «un fenomeno complesso» ma con una certezza: se la classe dominante lo volesse la mafia verrebbe immediatamente distrutta (ha i mezzi materiali e l’autorità morale). Invece la relazione è reciproca e i destini intrecciati.
In un saggio scritto dopo la strage di Capaci Consolo spiega come sia cambiato il rapporto tra mafia e politica. Se per decenni «mafia e potere politico procedevano trionfalmente in simbiosi perfetta […] l’una e l’altro si alimentavano di un vasto consenso […] insieme poi davano e ricevevano protezione e padrinaggio al e dal potere di Roma» (p. 110), tutto cambia con quello che lo scrittore chiama «il Grande affare»: «Il devastante traffico internazionale della droga, con i suoi traffici succedanei, ha mutato il rapporto di forza tra mafia e potere politico, Cosa nostra ha finito per dominare politica, invadere industria, commercio, finanza».
Ma è cambiata anche la percezione della mafia e delle sue vittime, adesso uomini delle istituzioni, giudici, prefetti, ufficiali, politici, imprenditori. Sino al secondo dopoguerra la mafia uccideva capilega e sindacalisti che si opponevano ai gabellotti, e queste morti «provocavano dolore e rimpianto forse soltanto nel gruppo politico, nella classe da cui provenivano» (p. 126). Cambia la mafia, cambiano le vittime, cambia l’antimafia.
Umberto Santino (“Storia del movimento antimafia”) sottolinea il passaggio di fase: a cambiare sono soprattutto le motivazioni dell’opposizione: se prima la lotta alla mafia si intrecciava e in larga parte si sovrapponeva al conflitto sociale e politico (antimafia sociale), dagli anni ottanta in poi il movente è l’indignazione e la rivendicazione dei valori civili (il diritto, la democrazia, la non violenza, ecc.) che non hanno una specifica connotazione di classe.
Scrive Consolo: «Il dolore e il rimpianto per le vittime non ritrovavano più risonanza in un gruppo politico, in una classe sociale, ma in tutta la società civile».
Il nuovo anno da poco entrato è anche quello del trentesimo anniversario di Mani pulite. Tangentopoli, scrive efficacemente Consolo in un articolo del 1994, è la «perfetta realizzazione di un’utopia negativa» (p. 145) in cui il malaffare è divenuto elemento fisiologico, «quasi legale, sistematicamente accettato, praticato e tacitamente regolarizzato dai partiti al governo e qualche volta pure dall’opposizione»; e le leggi, vane e violate, assomigliavano sempre più «alle “gride” nella Lombardia del Seicento, la cui applicazione era sempre lasciata “all’arbitrio di Sua Eccellenza”». L’implacabile descrizione del degrado morale del mondo politico e imprenditoriale non impedisce a Consolo di esprimere una dura, e all’epoca in controtendenza, critica alla trasmissione televisiva del processo Enimont, «un orrendo, fascinoso spettacolo».
Non c’è nelle sue parole solo la rivendicazione della forza del diritto, il rifiuto della gogna mediatica, il rispetto della dignità degli imputati, c’è la denuncia di quella ipocrisia nazionale che tiene incollati al video milioni di telespettatori che non hanno mancato di dare il proprio voto ai politici processati: «Elettori-telespettatori che nello spettacolo-gogna si autoassolvono» (p. 146). Forza del diritto, dunque, e irriducibile denuncia di ogni ipocrisia. Nell’ottobre del 1990 su “L’Ora” in risposta ad un articolo di giornale dopo le dimissioni dal Premio Racalmare-Leonardo Sciascia, Consolo spiega il suo un inevitabile gesto di protesta: «Finché la mafia uccide in Sicilia […] non possiamo permetterci di “celebrare cerimonie letterarie sovvenzionate da pubblico denaro”». Ci sono momenti in cui bisogna saper dire “no”, non si può far finta che tutto prima o poi passi.
Nella polemica, poi, mette in guardia su un altro rischio: le “cerimonie” finanziate da denaro pubblico forniscono «soltanto alibi a gravi responsabilità altrui, [danno] una mano a imbellettare ingiuriosamente i cadaveri» (p. 80).
«Ci sono momenti» – questa la dolorosa consapevolezza dello scrittore – «in cui bisogna rifiutarsi di suonare e cantare in pubbliche feste o cerimonie […] perché non s’ingenerino equivoci o fraintendimenti […] per non allietare i responsabili dei mali». Infine, qualche parola a titolo personale sul rapporto di Consolo con l’esperienza del movimento antiracket a cui sono dedicati alcuni degli articoli di “Cosa loro”.
Vincenzo Consolo, nella rivolta dei commercianti di Capo d’Orlando individuava una ragione di speranza che covava proprio in quei Nebrodi in cui era cresciuto e a cui ritornava ogni estate e ad ogni occasione. A partire dal famoso articolo all’indomani dell’omicidio di Libero Grassi “Morti in licenza” e, poi, dopo la sciagurata decisione del governo Berlusconi nei confronti di chi scrive e, ancora, in un saggio del 2005, Vincenzo è sempre stato un appassionato e affettuoso compagno di viaggio che ha saputo apprezzare quella strategia contro la solitudine e l’isolamento che è stata alla base dell’ACIO di Capo d’Orlando e continua a essere la ragione di fondo delle associazioni nate ispirandosi a quel modello. E proprio guardando a questo centro di commercianti affacciato sul Tirreno si può a ragione dire che la mafia è Cosa “loro”.
POI
Poi,
quando sorge e sale nel cielo
pallido e regale il faro familiare,
lo schermo opalescente,
il sipario
consolante dell’infinito e dell’eterno,
torna incerta,
tremante la parola,
torna per dire
solo meraviglia …
Vincenzo Consolo – Sant’Agata di Militello 2007
L’IMPASSE
In pasto al mondo
il nome, poi la cosa.
Una via tronca, quasi un’impasse.
Agra d’aspetto, sospetta
per battiti, frequenze.
Coeundi et generandi
è la vittoria, il pensare
è rimandato
nel futuro anteriore.
Vincenzo Consolo – Milano 23/VI/1998
È un vicolo cieco l’espressione di sé, delle cose, del mondo?
Sembra interrogarsi sulle scarne possibilità dell’espressione, Vincenzo Consolo, in questa poesia asciutta e dura come pietra.
Il mondo consuma i nomi e le cose che i nomi rappresentano, in una continua erosione della realtà e della possibilità di dirla.
La vittoria è preclusa, il pensare congelato e rimandato ad un futuro tutto ancora da immaginare. È quasi profetico questo piccolo scritto inedito del grande scrittore santagatese, in cui prevede i margini strettissimi e soffocanti, che restano oggi a chi ha qualcosa da dire.
Una mancata armonia: Accordi – Vincenzo Consolo
Una prospettiva, un’aura mai del tutto manifestata accompagna questi pochissimi e per questo ancora più preziosi versi di Vincenzo Consolo in una claque te, Accordi, curata da Claudio Masetta Milone e stampata artigianalmente dall’editore santagatese Francesco Zuccarello – e addirittura rilegata a mano con filo di rete da pesca (cosa che allo scrittore di mare non sarebbe per niente dispiaciuta) – che continua a coltivare così anche la memoria paterna dello storico Stabilimento tipografico “Progresso” dove ebbero la fortuna di nascere le introvabili 60 copie delle 9 Liriche di Lucio Piccolo in quei “caratteri frusti e poco leggibili” di cui parlò Montale che fecero infuriare Zuccarello senior: «io questo Pontale lo denunzio!» (nota puntualmente registrata dal giovane Consolo nel racconto Il barone magico). Alcune liriche di Vincenzo Consolo erano state rese pubbliche nel lontano 1992 all’interno della pregevole antologia curata da Sergio Palumbo e intitolata Poesia al Fondaco. Il cenacolo culturale della libreria Ospe, nella quale erano presenti anche poesie di Piccolo, Cattafi, Vann’Antò, Ballotta e molti altri, in quella che Palumbo definì «‘na fazzulittata d’amici». Il punto lirico si massima intensità era tuttavia stato raggiunto da Consolo – a mio avviso – nel prologo-mantra di Lunaria, laddove cantava la notte palermitana sospesa tra sogno e memoria:
Origine del tutto,
fine d’ogni cosa,
eco, epifania dell’eterno,
grembo universale,
nicchia dell’Averno,
sosta pietosa, oblio,
loto che nutre e schiude
la semenza.
Nutta, nuce, melània,
vòto, ovo sospeso,
immòto.
Oh notte di Palermo,
Mammuzza bedda,
lingua dulcissima,
parola suavissima,
minna d’innocenti,
melassa di potenti,
tana di briganti,
tregua di furfanti,
smània monacale,
desìo virginale:
deh dura perdura,
dimora,
ristagna nella Conca,
non porgere il tuo cuore
alla lama crudele dell’Aurora.
Questo Accordi consta di soli quattro testi ma vi si ravvisano molti degli elementi che caratterizzano anche la prosa dell’autore nebroideo: una propensione alla nomenclatura precisa, quasi scientifica degli oggetti e degli ambiti richiamati; il gusto eclettico per la commistione etimologica e, non ultimo, il senso profondo per gli spazi memoriali di una civiltà contadina isolana ormai perduta, che ne fanno un gioiello da rileggere e, soprattutto, conservare gelosamente.
[…] S’è indurita la tua carne
alle sabbie tempestose
del deserto,
affilate si sono le tue ossa
sui muri a secco
della masseria.
Brillano granatini
sul tuo palmo
per le punture
delle spinesante.
È un vicolo cieco l’espressione di sé, delle cose, del mondo?
Sembra interrogarsi sulle scarne possibilità dell’espressione, Vincenzo Consolo, in questa poesia asciutta e dura come pietra.
Il mondo consuma i nomi e le cose che i nomi rappresentano, in una continua erosione della realtà e della possibilità di dirla.
La vittoria è preclusa, il pensare congelato e rimandato ad un futuro tutto ancora da immaginare.
È quasi profetico questo piccolo scritto inedito del grande scrittore santagatese, in cui prevede i margini strettissimi e soffocanti, che restano oggi a chi ha qualcosa da dire.
La vittoria è preclusa, il pensare congelato e rimandato ad un futuro tutto ancora da immaginare. È quasi profetico questo piccolo scritto inedito del grande scrittore santagatese, in cui prevede i margini strettissimi e soffocanti, che restano oggi a chi ha qualcosa da dire.
Vincenzo Consolo – Leonardo Sciascia – Gesualdo Bufalino
Racalmuto. La foto inquadra i tre scrittori in conversazione davanti all’abitazione di Sciascia, già consapevole del suo male incurabile.
CAPITOLO 19
LA METRICA DELLA MEMORIA
Con questo titolo, lo scrittore declina le connotazioni essenziali della sua tastiera tematica, risonante di scansioni salmodianti, di segmenti elegiaci alti, di torrenti di venature liriche, di cesure drammatiche, di incisioni tragiche, in un procedimento linguistico elaborato con innesti ben omogeneizzati, estrapolati dal serbatoio di altre aree espressive, razionalmente funzionali alla mappatura della bellezza e dell’incanto della sua Sicilia mitica divenuta nel tempo storico e in quello sequenzialmente narrativo il proscenio squarciato di un irredimibile e perenne rispecchiamento di tragedia antica.
(Dal sito dello scrittore).
Questa è la nostra Itaca d’oggi, la matrigna terra della giustizia negata, della memoria cancellata, dell’intelligenza offuscata, della bellezza e della poesia oltraggiate, delle passioni incenerite.
LA METRICA DELLA MEMORIA
Un velo d’illusione, di pietà,
come ogni sipario di teatro,
come ogni schermo; ogni sudario
copre la realtà, il dolore,
copre la volontà.
La tragedia é la meno convenzionale,
la meno compromessa delle arti,
la parola poetica e teatrale,
la parola in gloria raddoppiata,
la parola scritta e pronunciata. (1)
Al di là è la musica. E al di là é il silenzio.
Il silenzio tra uno strepito e l’altro
del vento, tra un boato e l’altro
del vulcano. Al di là é il gesto.
O il grigio scoramento,
il crepuscolo, il brivido del freddo,
l’ala del pipistrello; é il dolore nero,
senza scampo, l’abisso smisurato;
é l’arresto oppositivo, l’impietrimento.
Così agli estremi si congiungono
gli estremi: le forze naturali
e il volere umano,
il deserto di ceneri, di lave
e la parola che squarcia ogni velame,
valica la siepe, risuona
oltre la storia, oltre l’orizzonte.
In questo viaggio estremo d’un Empedocle
vorremmo ci accompagnasse l’Empedoklès
malinconico e ribelle d’Agrigento,
ci accompagnasse Hölderlin, Leopardi.
Per la nostra inanità, impotenza,
per la dura sordità del mondo,
la sua ottusa indifferenza,
come alle nove figlie di Giove
e di Memoria, alle Muse trapassate,
chiediamo aiuto a tanti, a molti,
poiché crediamo che nonostante
noi, voi, il rito sia necessario,
necessaria più che mai la catarsi.
(Catarsi, p.13-14, […])
Questi versi, strofe o frasi, sono tratte dal Prologo della mia opera teatrale intitolata Catarsi, in cui é messo in scena il suicidio sull’Etna di un moderno Empedocle.
Ho voluto iniziare con questi versi perché la tragedia, in forma teatrale o narrativa, in versi o in prosa, rappresenta l’esito ultimo di quella che posso chiamare la mia ideologia letteraria, l’espressione estrema della mia ricerca stilistica. Espressione, in Catarsi, in forma teatrale o poetica, in cui si ipotizza che la scrittura, la parola, tramite il gesto estremo del personaggio, si ponga al limite della pronunciabilità, tenda al suono, al silenzio.
[…] Empedocle:
La tragedia comincia nel fuoco più alto
In questa nuda e pura, terrifica natura,
in questa scena mirabile e smarrente,
ogni parola, accento é misera convenzione,
rito, finzione, rappresentazione teatrale.
Un testo, questo, dal linguaggio di voluta comunicabilità, privo di innesti dialettali, lontano dal pastiche espressionistico praticato nelle mie opere narrative, intenzionalmente alto, in qualche modo declamatorio, puntellato da rimandi impliciti e da esplicite citazioni di testi classici: da Hölderlin, naturalmente, ai frammenti di Perì Phùseos e di Katharmoì di Empedocle.
Per spiegare questo esito, devo partire dall’ esordio, dalla mia scelta di campo letterario, dalla prima impostazione stilistica. E il discorso cade fatalmente sulla scrittura, sulla lingua.
La lingua italiana, sin dalla sua nascita, sappiamo, é stata, come dice Roland Barthes, “molto parlata”, nel senso che molto si é scritto su di essa.
A partire dal suo grande creatore, da Dante, con il De vulgari eloquentia. Il quale, oltre ad essere un saggio di poetica personale, é il primo trattato di linguistica italiana.
“Chiamiamo lingua volgare” dice “quella lingua che i bambini imparano ad usare da chi li circonda quando cominciano ad articolare i suoni […] Abbiamo poi un’altra lingua di secondo grado, che i Romani chiamarono ‘grammatica’ (lingua letteraria regolata)”. E afferma, con un bell’ossimoro: “Harum quoque duarum nobilior est vulgaris” (Di queste due lingue la più nobile é la volgare). Da Dante dunque a Lodovico Castelvetro, ad Annibal Caro, e giù fino a Leopardi, a Manzoni, a De Amicis, fino a Pasolini. Molti scrittori insomma hanno parlato di questo strumento, della lingua che erano costretti ad usare.
Mi voglio soffermare su Leopardi, sulle riflessioni che il poeta fa sulla società, sulla letteratura e sulla lingua italiana in quel gran mare che é lo Zibaldone. Leopardi confronta la lingua italiana con la lingua francese, stabilisce un continuo parallelo fra le due lingue, così apparentemente prossime e insieme così lontane. Lontane al punto, afferma tra gli altri Luca Serianni, che per un adolescente italiano la lingua di Dante o del Novellino è ancora in gran parte comprensibile, mentre per il suo coetaneo francese La Chanson de Roland é un testo straniero, da affrontare con tanto di vocabolario.
Ma torniamo al nostro Leopardi. Il francese, egli dice, tende all’unicità, mentre l’italiano é un complesso di lingue piuttosto che una lingua sola, potendo essa variare secondo i vari soggetti e stili e caratteri degli scrittori, per cui diversi stili sembrano quasi diverse lingue; il francese invece, sin dall’epoca di Luigi XIV, si é geometrizzato, é diventato lingua unica. E cita, Leopardi, Fénelon, il quale definisce la lingua francese una “processione di collegiali”. Diciamo qui tra parentesi che alla frase di Fénelon deve aver pensato Ernest Renan nell’affermare: “Il francese non sarà mai una lingua dell’assurdo: e neanche sarà mai una lingua reazionaria. Non si riesce a immaginare una vera e propria reazione che abbia per strumento il francese”.
Ma a Renan ribatte Roland Barthes: “L’errore di Renan non era errore strutturale ma storico; egli credeva che il francese, plasmato dalla ragione, conducesse necessariamente all’espressione di una ragione politica la quale nel suo spirito non poteva che essere democratica”. E concludeva: “La lingua non é né reazionaria né progressista: essa é semplicemente fascista; il fascismo infatti, non é impedire di dire, ma obbligare a dire”. Non capisco questo radicalismo linguistico di Barthes, espresso nella lezione inaugurale al Collège de France, ma chiudendo la lunga parentesi, ritorno ancora a Leopardi, alla sua idea del francese geometrizzato. E non posso non esclamare: “Beati i francesi con la loro lingua unica, geometrica e cartesiana! Che é segno, quella lingua, dell’esistenza e della compiutezza di una società civile (“Oggi so che alla Francia mi lega soltanto l’amore per la lingua francese” scriveva Jean Genet durante il suo vagabondare per l’Europa) (4). Il complesso di lingue che é (o che é stato, fino agli anni Sessanta, fino all’analisi della trasformazione di questa lingua che ne fa Pasolini), l’italiano é di segno opposto: segno vale a dire dell’assenza o incompiutezza di una società civile italiana.
Lo Zibaldone, dicevo. Leopardi afferma che la lingua italiana, il toscano vale a dire, raggiunge la sua massima eleganza nel Cinquecento. Finisce questa eleganza, questa centralità toscana, con la Controriforma, con l’esplosione di quel leibniziano cataclisma armonico, di quell’ anarchia equilibrata che va sotto il nome di Barocco. Per Croce però il Barocco non nasce dalla Controriforma, ma da una concomitante decadenza, dall’ affievolirsi di quell’ entusiasmo morale, di quello spirito del Rinascimento che aveva illuminato l’Europa. Era stata Firenze dunque centro di quella lingua attica, di quell’italiano platonico, di quella scrittura borghese, laica, elegante dei poeti, dei filosofi, degli scienziati a cui ogni scrittore, da ogni corte o convento, da ogni accademia o piazza, da ogni centro o periferia aspirava.
Ma questa lingua dell’Ariosto e del Tasso, del Machiavelli e del Guicciardini, nel tempo si irrigidisce, si fa aulica, perde contatto col suo fondo popolare, si geometrizza, perde in estensione. Leopardi ammira la perfezione stilistica raggiunta dagli scrittori del nostro Secolo d’Oro, ma predilige l’immensità, la varietà, la vertiginosa libertà espressiva di uno scrittore secentesco, barocco, del gesuita Daniello Bartoli, l’autore della Istoria della Compagnia di Gesù. Dice: “Il padre Daniello Bartoli é il Dante della prosa italiana. Il suo stile, in ciò che spetta alla lingua, é tutto risalti e rilievi”. Risalti e rilievi come quelli del Resegone, che Manzoni ironizza ironizzando il Seicento, il tempo della disgregazione, del marasma sociale.
Ironizza prima esplicitamente trascrivendo nell’introduzione del suo grande romanzo il “dilavato e graffiato autografo” dell’anonimo secentista, inzeppato “d’idiotismi lombardi”, di “declamazioni ampollose”, di “solecismi pedestri” e seminato qua e là da qualche eleganza spagnola. (L’espediente del documento dell’anonimo secentesco pensiamo derivi al Manzoni da Cervantes, dal Don Chisciotte, dal sedicente manoscritto dell’arabo Cide Hamete Berengeli).
E ironizza ancora nascostamente parodiando nell’incipit, in “Quel ramo del lago di Como”, un brano del Bartoli riguardante l’India, la regione del Gange, riportando così il disordine lombardo all’ordine, alla geometria fiorentina. Che era per Manzoni l’aspirazione all’ordine, all’armonia sociale, a un illuministico, cristiano Paese, di cui la lingua, comune e comunicativa, doveva essere espressione. Utopia mai realizzatasi, si sa. E dunque la moderna storia letteraria italiana, con le rivoluzioni linguistiche degli Scapigliati, di Verga e dei Veristi, con il preziosismo decadente di D’Annunzio, con la esplosione polifonica del “barocco” Gadda e degli altri sperimentalisti, da una parte, con lo sviluppo della “complessa” semplicità leopardiana dei rondisti e degli ermetici, con l’asciutta, scabra lingua di Montale, dall’altra, é la storia del convivere e dell’alternarsi della lingua rinascimentale e illuministica e della linea barocca e sperimentale. É la storia di speranza e di fiducia degli scrittori in una società civile; la storia di sfiducia nella società, di distacco da essa, di malinconia, di disperazione.
Da tali altezze scendendo al mio caso, a quel che ho potuto o saputo fare, posso dire questo. Ho mosso i miei primi passi in campo letterario (e questo risale al 1963) nel momento in cui si concludeva in Italia la stagione del Neorealismo e stava per affacciarsi all’ orizzonte quel movimento avanguardistico che va sotto il nome di Gruppo ‘63. Il quale, come tutte le avanguardie, opponendosi alle linee letterarie che erano in quel momento praticate, dalla neo-realistica, alla illuministica e razionalistica, alla sperimentalistica, programmava l’azzeramento d’ogni linguaggio che proveniva dalla tradizione e proponeva un nuovo, artificiale linguaggio di difficile praticabilità.
L’operazione non era nuova, naturalmente, era già stata fatta dal Futurismo, dal suo fondatore Marinetti, il quale aveva dettato il decalogo della nuova scrittura.
1) Bisogna distruggere la sintassi, disponendo i sostantivi a caso, come nascono.
2) Si deve usare il verbo all’ infinito.
3) Si deve abolire l’aggettivo.
4) Si deve abolire l’avverbio … Etc … Etc…
Questa ideologia linguistica o stilistica marinettiana riproponeva uno dei teorici del Gruppo’63, affermando che bisognava praticare il “disordine sintattico e semantico come rispecchiamento del disordine della società”. Credo che si fosse nel campo della indecifrabilità, della pseudo-afasia, speculare alla indecifrabilità linguistica e alla pseudo-afasia del potere. Dicevo che ho mosso i primi passi in quel clima letterario e insieme in quel clima politico in cui un partito di maggioranza, la Democrazia Cristiana, dal ’48 ininterrotta- mente al potere, aveva cambiato profondamente l’assetto sociale e culturale del nostro Paese, aveva cambiato la nostra lingua.
Pasolini (sulla rivista Rinascita – dicembre ’64 – quindi in Empirismo eretico) aveva pubblicato il saggio dal titolo Nuove questioni linguistiche in cui sosteneva che, con il neo-capitalismo, l’asse linguistico italiano s’era spostato dal centro meridione, da una realtà burocratica e contadino-dialettale, al centro settentrione, a una realtà piccolo-borghese aziendale e tecnologica. E analizzava un brano del discorso di un uomo politico emblematico, Aldo Moro (ucciso a Roma nel ’78, come sappiamo, da quei piccolo-borghesi criminali, mascherati da rivoluzionari, che sono stati i componenti delle Brigate Rosse), discorso pronunciato nel momento significativo dell’inaugurazione dell’Autostrada del Sole, autostrada che univa per la prima volta l’Italia dal Piemonte alla Sicilia.
Diceva Moro: “La produttività degli investimenti del piano autostradale dipende dunque dal loro coordinamento in una programmazione delle infrastrutture di trasporto, che tenda a risolvere gli squilibri, ad eliminare le strozzature, a ridurre gli sperperi della concorrenza fra diversi mezzi di trasporto, a dare vita insomma ad un sistema integrato su scala nazionale”.
E Pasolini concludeva dunque nel suo saggio: “Perciò in qualche modo, con qualche titubanza, e non senza emozione, mi sento autorizzato ad annunciare che è nato l’italiano come lingua nazionale” (si noti in questa frase l’amara ironia pasoliniana). Non era certo, questo italiano per la prima volta nazionale, uguale al francese unico e geometrizzato di cui parlava Leopardi, ma una sorta di sotto o extra-lingua, una astorica, rigida, incolore koinè. Sono passati più di quarant’anni dal 1964 e lascio immaginare la situazione linguistica italiana di oggi, dell’italiano strumentale e di quello letterario.
Esordivo in quel tempo, insieme a Luigi Meneghello, Lucio Mastronardi, Stefano D’Arrigo con La ferita dell’aprile, titolo di eco eliotiana. Un racconto in una prima persona mai più ripresa, una sorta di Telemachia o romanzo di formazione.
Mi ponevo con esso subito, un po’ istintivamente e un po’ consapevolmente, sul crinale della sperimentazione, mettendo in campo una scrittura fortemente segnata dall’ impasto linguistico, dal recupero non solo degli stilemi e del glossario popolari e dialettali, ma anche, dato l’argomento, di un gergo adolescenziale. Gergo quanto mai parodistico, sarcastico, quanto mai oppositivo a un ipotetico codice linguistico nazionale, a una lingua paterna, comunicabile. E organizzavo insieme la scrittura su una scansione metrica, su un ritmo, con il gioco delle rime e delle assonanze. Prendeva così il racconto, nella sua ritrazione linguistica, nella sua inarticolazione sintattica, nella sua cadenza, la forma in qualche modo di un poemetto narrativo. C’era certo, dietro il libro, la lezione di Gadda e di Pasolini, c’era l’ineludibile matrice verghiana, ma c’era l’evidente polemica sociale, la diffidenza nei confronti del contesto storico, della sua lingua.
Tredici anni sono trascorsi tra il primo e il secondo libro. Un tempo lungo che poteva anche significare dimissione dalla pratica letteraria. Un tempo che ha coinciso – mi si permetta di dirlo – con la mia vicenda personale, con il mio trasferimento, nel ’68, dalla Sicilia a Milano. In questa città provai spaesamento per la nuova realtà, urbana e industriale, in cui mi trovai immerso, realtà di cui mi mancava memoria e linguaggio; per l’acceso clima politico, per i duri conflitti sociali di quegli anni. Fu un tempo quello di studio e di riflessione su quella realtà e sul dibattito politico e culturale che allora si svolgeva. Frutto di tutto questo fu la pubblicazione, nel 1976, del romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio.
Un romanzo storico-metaforico, ambientato in Sicilia intorno al 1860, che voleva chiaramente rappresentare il grande rinnovamento, l’utopia politica e sociale che nel Sessantotto si vagheggiava in Italia e altrove, che nel nostro Paese doveva frantumarsi a causa dei suoi esiti tragici, disastrosi.
L’ambientazione storica e il ripartire dal luogo della mia memoria mi permetteva di raggiungere maggiore consapevolezza della mia scelta di campo letterario, scelta contenutistica e stilistica.
La sperimentazione linguistica, per l’adozione della terza persona, si svolgeva ora sul piano dell’ironia e del discorso indiretto libero. L’esito era quindi la “plurivocità” ben individuata da Cesare Segre. In cui era incluso il linguaggio alto del protagonista, un erudito dell’800, e la lingua dei contadini, la cui estremità era rappresentata da un antico dialetto, il gallo-italico o mediolatino, che si parlava in Sicilia in isole linguistiche dell’azione del romanzo.
La sperimentazione, nel romanzo, era anche sul piano della struttura. I cui jati, le cui fratture erano riempite da inserti storiografici, da documenti, la cui funzione era quella di connettere i vari lacerti narrativi. Mi veniva questo dalle sollecitazioni del Gruppo ’47 di Enzerberger, per le sue teorie di Letteratura come storiografia. Anche qui c’é la messa in crisi del genere romanzo, c’é ancora la polemica della scrittura narrativa nei confronti della società. Società di cui fa parte la cosiddetta industria culturale che mercifica e distrugge il romanzo.
Nei miei successivi romanzi perseguo e approfondisco sempre di più la sperimentazione linguistica. In essi c’é la messa in crisi del genere romanzo, e c’é ancora, come dicevo sopra, la polemica nei confronti della società. Società in cui, con la rivoluzione tecnologica, con l’invasione dei mezzi di comunicazione di massa, l’autore non riesce più a individuare il lettore. Italo Calvino, scrittore quanto mai razionalista o illuminista, estremamente comunicativo, al pari di Moravia, di Bassani, di Primo Levi, di Sciascia, e di altri di quella generazione, Calvino, nel contesto di una inchiesta, alla domanda, a quale tipo di lettore egli pensasse scrivendo, rispondeva: “A un lettore che la sa più lunga di me”. Non credo che Calvino, in questo nostro presente, potrebbe ancora rispondere in quel modo, oggi in cui non è immaginabile un lettore più o meno letterariamente avveduto, più o meno colto dell’autore.
Viene quindi la pubblicazione di Lunaria (1985), un racconto, una favola dialogata, che fatalmente prende forma teatrale.
La favola, ambientata in un vago Settecento, alla corte di un viceré spagnolo di Sicilia, si ispirava a un frammento lirico di Leopardi, Lo spavento notturno, e ad una prosa di Lucio Piccolo, L’esequie della luna.
La metafora della caduta della luna significava la caduta della poesia, della cultura nel nostro contesto. L’epoca e il tema favolistico,mi facevano approdare a soluzioni di apparente puro significante, come questa:
Lena lennicula
Lemma lavicula,
làmula,
lèmura,
màmula.
Létula,
màlia,
Mah.
Della stessa epoca e dello stesso clima quasi favolistico è anche Retablo. È un viaggio nella Sicilia classica, una metafora della ricerca al di là della ideologia, della completa dimensione umana, della perduta eredità umanistica. Per i rimandi, le citazioni esplicite e no, per la struttura, il risultato del racconto è di un ipertesto letterario o di un palinsesto.
Nottetempo, casa per casa è ancora una narrazione scandita come un poema. Dico narrazione nel modo in cui è stata definita da Walter Benjamin. Il quale in Angelus Novus, nel saggio su Nicola Leskov, fa una netta distinzione tra romanzo e narrazione.
La storia di Nottetempo, casa per casa é ambientata negli anni Venti, nel momento del fascismo in Italia. Vi si parla della follia privata, individuale, dolorosa, innocente, e della follia pubblica, la follia della società, della storia.
Personaggio simbolico è il satanista Aleister Crowley, che incarna il decadentismo estremo della cultura europea di quegli anni, di nuove metafisiche, di misticismi di segno nero o bianco.
Il protagonista del racconto, Petro Marano, è un piccolo intellettuale socialista, é costretto all’esilio, a rifugiarsi in Tunisia. Il racconto termina con questa frase: “Pensò che ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore.”
Il libro successivo L’olivo e l’olivastro, inizia con questa frase: “Ora non può narrare. Quanto preme e travaglia arresta il tempo, il labbro, spinge contro il muro alto, nel cerchio breve, scioglie il lamento, il pianto”. Qui è negata la finzione letteraria, l’invenzione del racconto. Il libro è un viaggio nella realtà contingente e nella memoria. È il ritorno di un Ulisse a Itaca, dove non trova che distruzione, violenza, barbarie. Ma devo ora tornare all’inizio di questa conversazione. Tornare alla tragedia Catarsi, in cui, l’antagonista di Empedocle, PAUSANIA, così recita:
– Io sono il messaggero, l’anghelos, sono
il vostro medium, colui a cui è affidato
il dovere del racconto, colui che conosce
i nessi, la sintassi, le ambiguità,
le astuzie della prosa, del linguaggio….
Cambia tono, diviene recitativo, enfatico.
PAUSANIA – E un mattino d’agosto lasciammo la dimora alta e luminosa, lasciammo i templi, le piazze, le arnie e le vigne, abbandonammo la patria nostra, la superba Agrigento che s’alza sopra il fiume…Spogli ed esposti, solitari, per boschi e per deserti giungemmo all’oriente, all’altro mare di quest’isola vasta, alla montagna immensa, presso la scaturigine del fuoco, del fragore, della minaccia…
Empedocle lo interrompe con un ghigno sarcastico.
EMPEDOCLE – Che menzogna, che recita, che insopportabile linguaggio! È proprio il degno figlio di questo orrendo tempo, di questo abominevole contesto, di questo falso teatro compromesso, di quest’era soddisfatta, di questa società compatta, priva di tradimento, d’eresia, priva di poesia. Figlio di questo mondo degli avvisi, del messaggio tondo, dei segni fitti del vuoto… Dietro il velo grasso delle sue parole di melassa, io potrei scoprire l’oscena ricchezza della mia città, la sua violenza, la sua volgarità, gli intrighi, gli abusi, i misfatti, le stragi d’innocenza, d’onore, di memoria, la morte quotidiana imbellettata come le parole morte di questo misero ragazzo, di questo triste opportunista… Ecco, ne L’olivo e l’olivastro l’ánghelos, il narratore, non appare più sulla scena poiché ormai la cavea è vuota, deserta. Sulla scena è rimasto solo il coro che in tono lirico, in una lingua non più comunicabile, commenta e lamenta la tragedia senza soluzione, la colpa, il dolore senza catarsi. Avviene qui la ritrazione invece che l’irruzione dello spirito socratico, quello che Nietzsche, ne La nascita della tragedia vede nel passaggio dall’antica tragedia di Eschilo e di Sofocle alla moderna tragedia di Euripide. Lo spirito socratico è il ragionamento, la filosofia, è la riflessione che l’autore del romanzo fa sulla vicenda che sta narrando: è quindi, come quello dell’ánghelos o messaggero con lo spettatore, il dialogo con il lettore. La ritrazione, la scomparsa dello spirito socratico é l’interruzione del dialogo con il lettore; é lo spostamento della scrittura dalla comunicazione all’espressione. Nelle mie narrazioni c’é sempre l’interruzione del racconto e il cambio della scrittura, il suo alzarsi di tono, svolgersi in forma ritmica, lirico-poetica. Sono questi per me le parti corali o i cantica latini. Eric Auerbach, nel suo saggio sul Don Chisciotte, contenuto in Mimesis, scrive: “Cervantes (…) é (anche) un continuatore della grande tradizione epico-retorica, per la quale anche la prosa é un’arte, retta da proprie leggi. Non appena si tratti di grandi sentimenti e di passioni o anche di grandi avvenimenti, compare questo alto stile con tutti i suoi artifici”.
I grandi avvenimenti di cui parla Auerbach (e i sentimenti che essi provocano) consistono per me, in questo nostro tempo, in questo nostro contesto occidentale, nella cancellazione della memoria,equindi della continua minaccia della cancellazione della letteratura, soprattutto di quella forma letteraria dialogante che é il romanzo. Il quale credo che oggi possa trovare una sua salvezza o plausibilità in una forma monologante, in una forma poetica. Poesia che é memoria, e soprattutto memoria letteraria.
Questo ho cercato di fare nello Spasimo di Palermo, terzo tempo, con il Sorriso dell’ignoto marinaio e Nottetempo, casa per casa, di una trilogia. “Ostinata narrazione poetica, in cui il raccontare é in ogni momento ricerca di senso, un interrogazione sul valore della realtà e dell’esistenza…” (Giulio Ferroni). Nello Spasimo vi si narra ancora di un viaggio di ritorno, di un nòstos in un’Itaca dove non é che smarrimento, violenza e dolore, “. una landa ingrata, / dove si trovano strage e livore” dice Empedocle nel Poema lustrale. Questa é la nostra Itaca d’oggi, la matrigna terra della giustizia negata, della memoria cancellata, dell’intelligenza offuscata, della bellezza e della poesia oltraggiate, delle passioni incenerite.
Vincenzo e Caterina, Brescia 1992 a casa di Vincenzo Cottinelli
CAPITOLO 20
VINCENZO CONSOLO:
“ANDIAMO VIA DA QUESTA ORRENDA CITTÀ”
«Più nessuno mi porterà nel Sud» lamentava Quasimodo. Invece – se m’è concesso il confronto – io nel sud ritorno sovente. Da Milano, dove risiedo con un volo di un’ora e mezza, atterro in Sicilia. Dalla costa d’oriente o occidente, ogni volta, come per ossessione, vizio, coazione a ripetere, celebrazione d’un rito, percorro l’ Isola da un capo a un altro, vado per città e paesi, sperduti villaggi, deserte campagne, per monti e per piane, per luoghi visti e rivisti non so quante volte; incontro vecchie persone, ne conosco di nuove; registro ogni volta, in quella mia terra, che esito chiamare patria, come invece con foga la chiama il poeta, il degrado continuo, le perdite irreparabili, la scomparsa d’ogni vestigia ammirevole, l ‘inarrestabile imbarbarimento, gli atroci misfatti, gli assassini le stragi, il saccheggio d’ogni memoria, d’ogni reliquia di civiltà e bellezza.
Vado in Sicilia e ne fuggo ogni volta, ritorno a Milano, la città dove da sempre, fuggendo dal sud, si sono rifugiati poeti e scrittori, artisti, credendo trovarvi, via dalla periferia, da una mediterranea deriva, vicino a un centro d’Europa, per illuministici retaggi, per eredità di probo governo, decenza civile, rispetto di leggi e diritti; a Milano, in Lombardia, in un Nord di lavoro e sviluppo dove da sempre sono emigrati, come da ogni Sud d’immobilità, privazione e offesa, masse di lavoratori in cerca di un nuovo destino.
Ritorno a Milano e scrivo, riverso nelle parole, nella scrittura, in racconti e diari, cronache d’avventure sempre uguali e sempre nuove negli esiti orrendi, pene e furori, rimpianti e denunzie, malinconie e invettive.
Credo sia questo il destino d’ogni ulisside d’oggi, di tornare sovente nell’Itaca del distacco e della memoria e di fuggirne ogni volta, di restare prigioniero nella reggia d’Alcinoo, in quel regno di supposta utopia, d’irreale armonia, condannato a narrare all’Infinito, come un cieco cantore, un vecchio svanito, i suoi nostoi, le sue odissee.
È questo che sto facendo ancora da alcuni mesi, faccio in questo giorno di scorcio d’aprile: narro del mio ultimo viaggio dell’estate scorsa in Sicilia, scrivo un libro che titolo, L’olivo e l’olivastro, colto in Omero, nell’episodio in cui Ulisse naufrago della grande tempesta nudo e martoriato, mette piede a Scheria, sulla terra dei Feaci, si rifugia sotto due arbusti nati da un medesimo ceppo: uno d’olivo, ‘altro d’olivastro. Mi è sembrata l’immagine, un simbolo della biforcazione, dei due sentieri o destini che s’aprono nella vita d’un uomo, nella storia d’un paese: del coltivato e del selvatico, del civile e del barbarico. Mi è sembrato il simbolo più pregnante della Sicilia, la quale diventa sempre, come si dice, metafora dell’Italia (dell’Europa, del mondo?). In questo penultimo giorno d’aprile, dopo aver attraversato lo Stretto di Messina, aver scansato il rischio mortale di Scilla e Cariddi, aver lasciato sulle falde dell’Etna i mostruosi Ciclopi, dentro la sua caverna di lava il bestiale Polifemo, mi trovo a girare per Siracusa, a muovermi nel cuore d’Ortigia, nelle altre parti di questa antica metropoli, il Tiche, Acradina, Epipoli, Neapoli, nel presente suo squallido e oscuro e il passato suo di potenza e splendo re. Muovermi tra la retta e la spirale, il rigore e la grazia, il teorema d’Archimede e la poesia di Pindaro, l’equilibrio dorico e il capriccio barocco, Nella Piazza una forma d’occhio dove regna Lucia, la signora della luce e della vista. Sta la santa Sibilla dei messaggi visivi nell’antro dove sono ingemmate, in trionfo di mura cristiane, greche colonne di pura geometria, dov’è incastonato il tempio d’Atena, la dea dell’olivo e dell’olio, del nutrimento e della luce, della ragione e della sapienza. Mi trovo, confuso, smarrito, in questo teatro di pro fonda memoria, di continui richiami, in questa scena odierna di degrado e macerie, deserta di parola, poesia, in questa cavea di urla e fragori, sotto un cielo di spesse caligini, presso un mare di petroli e liquami. In Siracusa è scritta la storia dell’infinito tramonto della civiltà nostra e cultura, dell’umano sentire, è impressa la notte della ragione e della pietà. Questo ventinove aprile mi alzo all’alba, come ogni mattina, scrivo dell’ultimo tramonto di Siracusa attraverso Il racconto di personaggi che in quella città son passati nel momento più drammatico della loro vita, uomini prossimi alla fine. Racconto del disperato Caravaggio che, fuggito dal carcere di Malta, approda in una Siracusa stremata da terremoti, carestie e pesti, immersa nel buio della controriforma, dipinge per una chiesa Il grande quadro del Seppellimento di Santa Lucia: il cadavere gonfio d’una fanciulla posto a terra, due ignudi becchini in primo piano che scavano la fossa, gli astanti schiacciati alla parete alta d’una latomìa, la luce livida d’una catacomba. Racconto del ceroplasta siracusano Zummo che crea Teche, teatri di peste, di contagio, di cataste di cadaveri in decomposizione, di avelli di scheletri, di mummie su cui scorrazzano topi, gechi, degli effetti sui corpi della sifilide; crea con le cere colorate perfette anatomie di teste, membra, organi … Racconto di un’arte necrofila, maniacale per cui lo Zummo è onorato alla corte di un Medici a Firenze e a quella del Re Sole a Versailles: la rivoluzione spazzerà via la sua tomba a Saint-Sulpice, spazzerà via gli altari per dare luce spazio alla dea Ragione. Racconto del Poeta von Platen che a Siracusa finisce i suoi giorni, in una misera locanda presso la fonte Aretusa, consumato dalle febbri de colera, dal vomito, dalla dissenteria. E racconto ancora di Guy de Maupassant che a Siracusa, rapito davanti a corpo luminoso della Venere Anadiomene, cova nel sangue il bacillo dell’infezione, della malattia che lo porterà alla demenza, alla morte. Nella scansione del tempo che m’impongo, a mezzogiorno interrompo il lavoro e vado, con desiderio e Insieme titubanza, a comprare i giornali. È il momento quello, della frattura, del ritorno brusco Nella prosa offensiva del presente, dell’ingresso nel grigio miserevole teatro di questo regno dei Feaci, di questa Milano in cui sono approdato da più di venticinque anni e da cui non riesco più ad imbarcarmi per l’Isola che un giorno abbandonai. Non riesco lasciare questa città del disinganno, dell’utopia crollata, della mediocrità più squallida, della nevrosi e dell’aggressività, del deserto d’ogni gioia, d’ogni bellezza, perché non ce più un’Itaca dove ridurmi e conciliarmi, in cui ricomporre l’armonia perduta, non c’è più espiazione e liberazione dalle colpe dopo il lungo racconto di mostri, di malìe e di tempeste ;perché i mostri non abitano più nel nostro subconscio, nei nostri sogni, non abitano più in ignote dimore abissi marini o caverne etnee, non sono dei mondi pre-civili, dei regni dell’olivastro, ma sono della nostra storia, del nostro tempo sono reali e ovunque presenti, sono quelli che ci hanno predetto Kafka, Baudelaire, Eliot, Joyce, Camus, Pirandello,tutti i poeti – profeti, sono quelli comparsi ieri ad Auschwitz, Hiroshima, Siberia, quelli comparsi oggi a Sarajevo, in Ruanda , in tanti altri luoghi di morte e di massacro; sono quelli che, dopo cinquant’anni, minacciano di ricomparire, ahinoi, in Italia.
L’amico giornalaio Bruno mi dà subito le prime notizie con l’espressione del volto, col modo d guardarmi, col far svolazzare, da dentro la nicchia della sua edicola, simile all’antro della Sibilla Cumana, qualche parola che può sembrar casuale, ma che è carica d’allusioni, messaggi. Ha sentito che cattivo odore, che puzza nell’aria stamane? Sarà scoppiata qualche fogna qui attorno, sarà sfuggito veleno da qualche fabbrica chimica…»
Capisco Allora, mentre Bruno mi porge i Giornali che le notizie sono pessime, come del resto ogni mattina da molto tempo a questa parte; lo capisco dal malumore, dal brontolare di Bruno che ogni giorno diventa sempre più cupo.
E la che era nell’aria, che già si temeva dopo la stragrande vittoria alle elezioni della destra del partito del signor Berlusconi, alleato con i revanscisti, i vandeani del signor Bossi e con i vecchi fascisti (neo o post-fascisti loro pretendono d’esser chiamati) del signor Fini, eccola qua, in prima pagina su tutti i giornali, con titoli a caratteri cubitali: Berlusconi al potere- Berlusconi vi darò la miglior squadra – il regime all’opera – Governo, è l’ora di Berlusconi – Silvio Berlusconi s’appréte un accéder au pouvoir…
Si, è fatta, il leader di Forza Italia è stato Incaricato dal capo dello stato di formare Il nuovo governo, il cinquantatreesimo dalla fine del fascismo, dall’avvento della Democrazia.
Illusione, sogno, felicità da spot pubblicitario, mondo d’inganno, di ombre televisive, di degradata, miserabile caverna platonica, regime telecratico, potere d’urna, squadra di samurai dell’azienda, d’un manipolo di sacerdoti della religione della bottega, di mistici della réclame e del profitto: di questo parlano i giornali. Riportano anche oggi in prima pagina la condanna a otto anni di carcere del finanziere Sergio Cusani, un giovanotto di buona famiglia napoletana, d’un passato a Milano di militanza nel Movimento Studentesco, di marxista rivoluzionario. La sentenza arriva dopo sei mesi di processo trasmesso alla televisione e goduto dai telespettatori come un grande , appassionante spettacolo, in cui sono sfilati i più grandi finanzieri e Industriali, i leaders politici, in cui si è mostrato la corruzione, il disfacimento di un potere, il crollo di un sistema simile a quello di Bisanzio prima dell’arrivo dei barbari, quel mondo che ci ha narrato Procopio di Cesarea.
La gente che aveva mandato al potere Andreotti e Craxi ha guardato Il processo, ha tifato per il giudice di Mani Pulite Di Pietro, si è assolta, e in marzo ha votato per Berlusconi, per Bossi e per Fini.
«È disperante, andiamo via, via da quest’orrenda città, via dall’Italia…» dice mia moglie. «Aspettiamo … Almeno fino a domani» rispondo scherzando.
Sappiamo, l’indomani, che Papa Giovanni Paolo II, uscendo dalla doccia, è caduto e s’è rotto il collo del femore, doveva partire quest’oggi per Siracusa, avrebbe dovuto in quella città consacrare un santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime, a un piccolo bassorilievo di gesso colorato che negli anni cinquanta, in occasione di una tornata elettorale, si dice abbia pianto nella casa di un operaio comunista.
Il santuario, un alto edificio in cemento a forma di cono scanalato, una sorta di rampa per il lancio di missili, è stato costruito di fronte al museo dov’è custodita la Venere Anadiomene, nel giardino dov’è la tomba di von Platen.
Tutto ormai in questo paese è di banalità e orrore, di degrado e oblio, è tramonto infinito, è Siracusa, fiammella d’olio o di candela che si spegne, è buio di catacomba: tutto è Milano del fascismo, del leghismo e del berlusconismo, è squallore e ignoranza, è ricchezza volgare che corrompe, aggredisce e offende.
CAPITOLO 21
L’ORA SOSPESA
E ALTRI SCRITTI PER ARTISTI.
L’ARTE A PAROLE: Strategie di laboratorio nella organizzazione della struttura narrativa intertestuale e nel paradigma poematico della spaziatura architettonica del magma testuale e nella trasparente topografia dei personaggi.
– Nota dello scrittore –
Nel 2004, negli appunti inediti per una conferenza su Antonello e altri pittori tenuta nel mese di febbraio all’Accademia Carrara di Bergamo, scrive Vincenzo Consolo:
L’ispirazione della letteratura alla pittura può essere esplicita […] oppure implicita, nascosta. Voglio dire che un disegno, un’incisione, una pittura, una scultura può dare modo a uno scrittore di piegare il racconto verso inflessioni visive, verso l’icasticità.
Ho voluto sottolineare l’aggettivo nascosta come un segno della scoperta che L’ora sospesa riserva ai suoi lettori.
Ma andiamo alle origini; partiamo da un brano de I padri putativi (1960), primo inedito abbozzo manoscritto de La ferita dell’aprile: Gesù con la tunichetta bianca e il cuore rosso e infiammato in una mano, là nel grande affresco dietro l’altare maggiore, scendeva una lunghissima scalinata che si perdeva nel cielo, una scalinata bordata da siepi di gigli bianchi, alcuni recisi e sparsi per i gradini, gigli che si perdevano anch’essi nel cielo e si confondevano con le nuvole. […] muoveva un piede sul gradino inferiore e gliene mancavano ancora tre per scendere sopra il piano dell’altare e poi lì, in mezzo ai ragazzi.
Don Bosco, dal vetro dell’altare di destra, […] – Da mihi animas – diceva dal piedistallo […].
E leggiamo ora la scena nella versione definitiva, nel capitolo V del romanzo del ’63: Gesù, cuore infiammato su tunica bianca, scende una celeste scalinata bordata di gigli immacolati, muove un piede scalzo e fiorito d’una piaga sui gradini e gliene mancano ancora tre per essere a terra, tra i bastasi della refezione. Don Bosco sorridente […] da mihi animas, e pure il cuore […]. Nel passaggio dalla prima alla seconda stesura assistiamo all’imporsi di alcuni degli espedienti stilistici che contraddistinguono la prosa consoliana: la frase nominale, il ritmo endecasillabico. Ma assistiamo pure a qualcosa di meno evidente, e tuttavia di più trascendente: l’escamotage dell’ecfrasi nascosta; ovvero il passaggio da un’esplicita rappresentazione ad una sorta di presentazione. Spariti affresco e piedistallo, altare e vetro, al lettore resta non la descrizione di un’immagine ma la sua immediatezza: l’occultamento della dimensione ecfrastica del testo finisce per far diventare l’immagine un’alterità senza equivalenza, senza punto di riferimento: un’alterità assoluta; le figure si palesano in una loro ambiguità atopica, all’interno della quale la persistenza di segni elocutivi descrittivi potrebbe essere interpretata – non solo, ma almeno anche – come indizio del flusso di coscienza, come l’apparire in ogni caso di una diversa voce narrante.
Benché nell’esigua misura di una tra le prime prove narrative dell’autore, abbiamo forse qui l’archetipo di una strategia di ambiguazione da annoverare fra le più cospicue della scrittura consoliana.Non mancano, i romanzi di Consolo, di momenti di stasi narrativa, di still moments (Krieger, Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign), di passaggi in cui l’impiego di alcune risorse stilistiche (quali appunto la frase nominale, l’elencazione, la ritmicità della prosa, la rima interna, ecc.) sembrerebbe “voler trasformare il moto in quiete” (Mengaldo, Tra due linguaggi. Arti figurative e critica). L’ora sospesa rivela l’intimo legame tra l’occasione figurativa e la stesura di pagine dominate (per dirla pasolinianamente) da “l’immediatezza allucinatoria della poesia che fissa le figure in un loro momento assoluto” (Pasolini, La volontà di Dante a essere poeta). Il libro immette il lettore in un laboratorio; soprattutto nelle sezioni «Bozze di scrittura» – che ospita alcune tra le prime stesure di certe pagine confluenti poi in ulteriori e più larghi discorsi narrativi – e «Prove di saggi» – campionario di alcuni dei leitmotiv della riflessione poetologica consoliana.Queste pagine si pongono quindi come l’occasione per la rilettura trasversale di un intero universo letterario, onde cogliere d’altronde la portata di un’operazione tesa spesso a cancellare le tracce d’una scrittura originale tendenzialmente ecfrastica; ad ulteriore riprova di una prassi letteraria che si serve consapevolmente di strategie di opacizzazione referenziale, e conferma, nel contempo, dei particolarissimi rapporti tra l’immaginazione figurativa e alcuni momenti testuali dove la semantica dell’ambiguità raggiunge la più alta densità stilistica; rapporti tutt’altro che scontati se si considera che spesso in Consolo la visività verbale si pone come controfigura di un’immagine non dichiarata; rapporti, in definitiva, basati su convergenze o parallelismi che incrinano, mostrandone l’obsolescenza, le tradizionali ed escludenti collocazioni delle immagini su un asse spaziale in rapporto al logos che si svolge sulla temporalità (Mitchell, Picture Theory).L’attenzione – o l’intuizione –, i dubbi che la lettura del testo suscita nell’interprete che predispone lo sguardo verso un preciso orientamento (ché, Kant insegna, l’occhio innocente è cieco), finiscono per confermargli che alcune significative pagine di Consolo siano scaturite – nella loro concreta testura verbale, non soltanto nelle loro valenze simboliche – da un’ispirazione figurativa: che l’occasione iconografica sia diventata momento fondante della scrittura. Tale è ormai il collaudato orizzonte di precomprensione di ogni attento lettore consoliano. Non pensiamo ora però – a questo ci invita L’ora sospesa – a quelle pagine in cui i riferimenti sono espliciti, dichiarati mediante meccanismi testuali o paratestuali (la dettagliata descrizione del Ritratto d’ignoto che chiude il capitolo primo del Sorriso); né alla presenza di quelle che potremmo chiamare icone autoriali (Antonello nel Sorriso, Clerici e Serpotta in Retablo, ne L’olivo e l’olivastro Caravaggio: nomi che il lettore attiva in modo funzionale tramite una successione di immagini: le loro opere); nemmeno, ancora, alla comparsa di titoli la cui iscrizione quasi epigrafica scandisce intere sequenze narrative (quelli dei Desastres di Goya nel Sorriso), o alle palesi citazioni pittoriche (l’Angelus di Millet che apre il capitolo quinto, sempre nel Sorriso; la Melancholia I del Dürer in Nottetempo, casa per casa). Tutta questa dimensione più o meno dichiarata, o appena velata, della scrittura di Consolo è ben nota.Pensiamo ad altri frammenti – altri momenti, altri spazi – nei quali la rappresentazione verbale di un’altra rappresentazione, di tipo visuale, non è dichiarata: a frammenti nei quali l’evidenza dell’operazione ecfrastica, della meta-rappresentazione (quella letteraria che prende forma da quella pittorica), si direbbe che fosse, programmaticamente a volte, nascosta al lettore; oppure intensamente schermata all’interno di scene di forte contenuto referenziale che sembrerebbero escludere l’esistenza di una doppia mediazione stilistica, di una doppia semiosi. Questo libro permette di leggere quei frammenti nella loro forma originaria, prima che fossero sottomessi alle diverse operazioni del trasferimento testuale (varianti, omissioni, procedure d’inserimento) in un tessuto narrativo di più ampio respiro. Penetrare in questo laboratorio dovrebbe suscitare delle domande sulla natura del rapporto tra letteratura e arti figurative nell’opera di Vincenzo Consolo; non però allo scopo di rinsaldare o smentire alcuni topoi – tutti quelli che girano attorno alle cosiddette, in modo alquanto ingenuo, «arti sorelle» poesia e pittura, e alla secolare discussione teorica in merito – ma per indagare nella funzionalità che tale rapporto può aver assunto nella scrittura narrativa consoliana; ricercare, ad esempio, come l’allusione a un intertesto figurativo dinamizzi la percezione del testo letterario. Una simile indagine sarebbe volta a gettare luce sui meccanismi della formatività testuale, sulle strategie e sulle materie della costruzione narrativa, sulla poetica implicita nell’opera. Una lingua così materica, un narrare così sussultorio, il ritmo metrico della prosa, un così ricco intarsio strutturale di discorsi; una dimensione di poematicità (meglio che poeticità) che non può non compromettere strutturalmente la narrazione, e che sarebbe riduttivo identificare soltanto con l’andante tonale e timbrico della frase; un narrare macroscopicamente ritmico nel susseguirsi ellittico di frammenti di racconto, a cui fa capo microscopicamente la ritmicità prosodica della frase; l’esplosione interna degli assi crono-spaziali della narrazione, che provoca nel lettore momenti di smarrimento.Tutti questi tratti distintivi della scrittura consoliana, di un narrare che contamina finzione e dizione (romanzo e poesia a, cunto e canto), trovano una loro cifra, una loro matrice nella dimensione ecfrastica del testo, sia essa velata o meno. L’ora sospesa ne è prova. Vorrei, per chiudere, proporre ancora qualche brano di Consolo. Dal testo si parte e al testo si deve sempre tornare, ammonisce Steiner. Risalgono al 1966 le prime pagine scritte dall’autore per una mostra pittorica, pubblicate senza titolo nella brossura di una personale di Oscar Carnicelli alla Galleria d’Arte Il Cannone di Trapani nel mese di novembre. La nota si apre con un brano virgolettato in carattere corsivo, che si presenta come un frammento, incorniciato com’è da punti di sospensione, come una citazione espunta da un’opera che non si dice:
« …E giurammo sulla Santa Vergine, su nostra madre, sui figli nati, sugli uomini che in terra ancora vivono, che mai, mai… Batteva a tempo sulla crosta del suolo di dicembre un tacco (forse mazza o sfera) che rompeva lo stridere di croci di fili in altissime campate. La schiera si allargava e si stringeva muovendosi agli estremi; e regrediva, avanzava (le teste gonfiano e l’orlo della calotta affonda nella fronte e nella nuca: come farà la madre, ma hanno nostalgia d’una mano?).Le monche braccia e le anche a branche di tenaglia, mostrò il congegno pel quale all’incastro d’un dente di quindici gradi ruotava la celata (quell’occhio, quel tondo occhio di vetro come scivola e gela la tua pelle). Gridammo (forse solo pensammo) che se non per noi, per la tenera età dei nostri figli… Un sale spesso scorreva per la gola (il ferro ne uscì pulito, ancora più acuto). Si scostassero, ah, si scorgesse un momento una luna di cielo in mezzo a loro ( – O mia pudica, la tua calda camicia sopra la testa! – gemeva l’orgoglio. E la pietà chiedeva di non piegarti sopra l’erbe e i fiori, questi cardi maligni e rose di cianuro). Il vento derisorio (rintronava nelle volte di lamiera) ci sferzava l’onore e il sesso, e noi ancora sperando rigiurammo sulla santissima Vergine… ». Sempre nello stesso testo, più avanti, già in carattere tondo, si legge il seguente microracconto:
[…] la sentenza è stata pronunciata e la condanna, la violenza, sta per essere compiuta. Nell’attesa dell’esecuzione, in questo fermo tempo, la sofferenza, la tragedia: lo scatenarsi di ansie, di tremori, di freddi sudori, incubi dove guglie lance pinnacoli, fili intersecantisi, fiori e foglie malignamente coriacei e spinosi, formano una trama, una maglia che inceppa e dilania il condannato che cerca di evadere da quel mondo cunicolare, di paura e buio ancestrale. Alla cui uscita, contro un cielo impietoso, attendono schiere fitte di cavalieri e fanti, sicuri esecutori della sentenza, massa scura, testuggine, perfetta macchina di inquietante minaccia e di brutale violenza.
Dalla brossura si evince che, almeno nel caso del secondo dei brani, siamo davanti ad un’ecfrasi di uno dei dipinti che vi si riproducono. Abbiamo buone ragioni per pensare che forse anche il primo parte da suggestioni figurative. La strategia della citazione (probabilmente autocitazione) non sarebbe che un pudico velo che nasconde appena il palesarsi di un esercizio di penna, una prova di scrittura che troverà – senza alcuna precisa corrispondenza testuale, sia chiaro – la sua misura ne Il sorriso dell’ignoto marinaio. Ne funge, se non da conferma almeno da spia, la asfissiante atmosfera cunicolare abbozzata nel secondo dei brani. Si ricordi inoltre che per le prime testimonianze manoscritte della stesura del romanzo del ’76 (Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo. «Il sorriso dell’ignoto marinaio») si potrebbe azzardare la data 1965, essendo comunque accertato che si tratta di prove anteriori al ’69. Qualche volta soluzioni di compromesso, e nati spesso da circostanze del tutto occasionali (il pittore, lo scultore che chiede il solito pezzo all’amico scrittore), i testi sull’arte e sugli artisti – almeno nei casi di quelli raccolti ne L’ora sospesa – si dimostrano tutt’altro che scritti d’occasione: a onor del vero, di occasioni di scrittura bisognerebbe piuttosto parlare, di occasioni alte ed altre, se sono servite per mettere a fuoco le tensioni espressive di Consolo: se hanno dato luogo, o corso, al racconto o alle domande sulla sua liceità, a delle riflessioni sulla sua incombente impraticabilità, allo strenuo assottigliarsi del dire.
Miguel Ángel Cuevas
Oggi ricordiamo con affetto Vincenzo Consolo a 10 anni dalla morte. con affetto. E anche da Berlino lo scrittore e poeta Joachim Sartorius, che frequentemente torna a Siracusa, gli dedica due poesie nella traduzione di Anna Maria Carpi.
su suggerimento di Etta Scollo.
da Joachim Sartorius | Feb 16, 2022
Quattro poesie nella traduzione inedita di Anna Maria Carpi.
Auf der Terrasse, piazza del Precursore
für (und nach) Vincenzo Consolo
Sulla terrazza, piazza del precursore
a (e a la maniera di) Vincenzo Consolo
Davanti a noi il mare, all’altezza dei nostri occhi,
lenti vanno i pescherecci, domani
avremo sardine, sebastes o il grosso pescespada.
Lui, solo lui, al mercato avrà due garofani negli occhi,
il muso colmo di melissa al limone, le squame di basilico,
e il mercante taglierà, oh, oh, col coltellaccio
taglierà il pescespada finché non restano che testa e spada
e sangue sull’uncino. E qui io penso ai razzi colorati
che ieri al matrimonio
a San Giovannello si spararono in aria
e caddero in acqua, friggendo come pesci, friggendo
come il pescespada nella nostra cucina – domani.
Domani, al pranzo, negli odori di mirra e melissa
penseremo a Mitilene, di fronte alla costa dell’Asia Minore,
la capitale di Lesbo. E’ vero quello che diceva Cicerone,
che hanno messo una statua di Saffo nel salone cittadino di Siracusa?
Di porfido? Non sappiamo come ricomporre i frammenti,
le voci dei navigli in pezzi.
*
Die Nekropole von Pantalica
La necropoli di Pantalica
L’airone vola nei boschi e si colma le ali di spezie.
Il cielo è teso come una pelle, grigio chiaro.
Io sono il pastore che spacca i fichi.
Mi diffondo a parlare delle pecore grigie.
E ancora più bello è sopra le tombe scure.
La prima farfalla, bruna e nevosa.
Aperto in cima al monte c’è il libro
che decide le forme del suo volo.
*
Téléphone arabe
Telefono arabo
alla memoria di Ibn Hamdis
1
Ci sono due copie del suo Divan, scritto da lui
in accurata agile calligrafia.
Un esemplare impolverato nella Biblioteca Vaticana.
L’altro nel Museo Asiatico di S. Pietroburgo.
Come ci sono pervenuti? Le poesie tarde
parlano dell’invecchiare. Lui è morto a Palma di Mallorca,
dopo qualche peregrinazione, a settantasette anni.
2
Sino alla fine la sua chioma era riccia e scura.
Ma agli amici della corte di Siviglia pareva che si fosse cinto
il capo di un’aura bianca. Così lo chiamavano il Bianco (o il Robusto o il Saggio).
Nelle sue poesie la sua fragilità era tutt’uno col declino degli Arabi in Sicilia e Andalusia.
Da Siracusa era fuggito in nave a Sfax.
3
Fuggito alla venuta dei Normanni. La sua nave si arenò. Nessuno
scrive della perdita del suo cuore. Lui scrive
sulla perdita di Jawhara, annegata,
delle belle nostalgiche elegie. Ancor oggi giacciono
come pelli di serpente al bordo della nostra strada.
Téléphone arabe, posta crepitante fino alle Baleari,
lungi dal Vaticano e ancora di più da S. Pietroburgo.
*
Replik
Replica
Io voglio ammirare l’estate d’estate.
Io voglio ammirare in mare il mio mare.
Voglio portare tre delfini ad Arethusa.
Siamo in quattro ad ammirare il loro dorso d’argento.
Ma sulle monete non c’è il dorso.
Solo testa e collo, in un alone d’argento.
Pound e Yeats al Museo Archeologico avevano
studiato accuratamente le collezioni.
Questa moneta è la più bella
del mondo antico, scrisse Yeats ai suoi.
Arrivarono alla conclusione cui erano arrivati già tutti.
Pound comprò una replica.
JOACHIM SARTORIUS
Joachim Sartorius, nato nel 1946 a Fürth, è cresciuto a Tunisi e vive fra Berlino e Siracusa.
Poeta e traduttore di poesia americana, soprattutto di John Ashbery e Wallace Stevens.
Ha pubblicato molti libri di poesia e prosa. Ha anche lavorato a diverse antologie. Il suo lavoro poetico è tradotto in quattordici lingue ed è l’editor delle versioni tedesche delle opere di Malcom Lowry e William Carlos Williams.
La sua ultima pubblicazione è “Wohin mit den Augen. Gedichte” (2021). Membro del PEN per la Germania e della Deutschen Akademie für Sprache und Dicht
POSTFAZIONE
di LUCIO ZANIBONI
In occasione del centenario dalla nascita di Vincenzo Consolo, Carmelo Aliberti gli dedica un saggio, facendolo precedere da un poemetto che ha chiara relazione con il romanzo “Nottetempo-Casa per Casa” in cui un uomo corre nella notte in preda a depressione che nell’accezione popolare è il licantropismo o male di Luna. Vincenzo Consolo è nato a Sant’Agata di Militello (Messina) il 18 febbraio 1933.La sua attività artistica ha avuto ampio raggio dagli anni 60 ai novanta con le maggiori case editrici (Mondadori, Mursia, Einaudi, Sellerio). Gran parte dei volumi editi è stata compresa nel “Meridiano”; l’opera completa curata da G. Turchetta, accompagnata da un profilo critico di Cesare Segre (2016). Voluminoso il suo lavoro letterario con romanzi, saggi critici, articoli, poesie. Fra i romanzi di particolare importanza “Le ferite dell’aprile” (’63) con Mondadori, “Il sorriso dell’ignoto marinaio” (’76) Einaudi, “Retablo” (’87) Sellerio e “Nottetempo-Casa per Casa” (’22) Mondadori, libri che hanno ottenuto premi di primo piano fra cui Roccalmare, Leonardo Sciascia e lo Strega. Aliberti in questo appassionato, aderente, vissuto iter artistico di Consolo ne mette in luce tutta l’inquietudine, conseguenza di vari fattori. In primo luogo è avvinto a una terra, la sua Sicilia che rappresenta un’Itaca a cui si vorrebbe tornare, ma che ogni volta che ciò avviene fa nascere la delusione nel confronto di ciò che era stata e di come è diventata. Nasce così la contrapposizione di storia e memoria. Quella mitica terra, circondata dall’azzurro, la gloriosa Magna Grecia di un tempo, ha un presente degradato e desolante. C’è quindi un assillo di fughe e ritorni, alla ricerca di un Eden ormai perduto. Non è solo questo a creare spasimo nello scrittore, con i baroni, i feudi, la condizione dei coloni sfruttati e maltrattati, i latifondi e le terre trascurate, la rivolta degli agricoltori, sanguinosamente domata dai garibaldini di Bixio; è l’instaurazione del fascismo che rappresenta l’apocalisse. A questo complesso di fattori si associa anche la visione della storia nella sua duplice veste. C’è un’altra storia oltre quella che viene raccontata e Consolo la indica con il simbolo della chiocciola che ha vaste entrate e un’uscita tortuosa. L’altra storia è quella della sofferenza e dei sofferenti ed è questa che volutamente non viene ricordata. Anche questo non basta a significare interamente il travaglio del romanziere. Egli si interroga sulle possibilità dell’espressione. Pensa che non vi sia possibilità per il romanzo, perché inganna il lettore, quindi cerca di dare corpo a un dettato che sprigioni aliti elegiaci. La sua scrittura si avvale di elementi stilistici, del dialetto, delle figure retoriche, assonanze, operazioni di orchestrazione… che insieme a memoria e attualità, in particolare siciliane, cerchino di assurgere a poesia. Poiché rifiuta l’uso di un linguaggio comune, si rende conto che la continua modificazione del reale crea la difficoltà di realizzare l’espressione; da ciò la conclusione che allo scrittore rimangano ben poche possibilità di manifestare pensiero o e cuore. Ne “L’olivo e l’olivastro” in cui si connotano i due elementi, il naturale e l’artificiale tratta il concetto della violenza e follia nel superamento dell’umano. Solo attraverso la dimensione umana si ha la giusta equazione di vita. È voce la sua che non si spegne col passare degli anni ed è altrettanto potente oggi in cui la genetica arrischia folli stravolgimenti. Ritorna nella sua narrazione la Sicilia. L’ulivo è una delle piante dell’isola, anche se di provenienza asiatica (Asia Minore, Siria). Lì la comunicazione è “sequestrata e pietrificata”. Non vi è alcuna possibilità di mutare le cose. Chi ha provato a farlo è stato costretto al silenzio. L’isola è quindi una specie di Limbo, “una metafisica paralisi”. Qui ecco allora la metafora della pietra e la caverna della pomice con i cavatori silicatici. La pietrificazione assume carattere esteriore e interiore. È evidente l’assillo della sua scrittura che si pietrifica in una immagine di vera sofferenza. È l’immagine della Gorgona che ha la capacità di trasformare in pietra chi la fissa. In questa rappresentazione viene proiettato non solo il presente, ma anche il dolore, il male di vivere, quella sofferenza che Consolo prova nella narrativa usando una lingua menomata da forme vane, conscio del pericolo di pietrificarsi, contagiarsi fissando la Medusa. In Consolo si incarna anche uno spirito liberale, alieno da condizionamenti (mafia, fascismo) e questa sua anima libera viene messa in luce, particolarmente riferita al romanzo “Nottetempo-Casa per Casa”. Qui il fascismo è un male storico dal quale per vent’anni non c’è stata possibilità d’uscita. Contemporaneamente però il romanziere affida alle sue righe la speranza di una nuova dimensione sociale, di un utopico futuro di rinascita. Fra i meriti di Consolo non manca anche quello del senso vero della cultura e della storia, nel rispetto delle tradizioni, con pari dignità in ogni paese. Un lavoro questo di Aliberti che, celebrando la validità narrativa di Vincenzo Consolo, stimola siciliani e non, a una risalita dal bivio del consumismo dell’usa e getta e dei messaggini a una letteratura che sia ancora vanto come lo fu quella della seconda parte del Novecento. Mi piace terminare questo mio breve intervento con i versi di Consolo in “Poi”: “Poi, quando sorge e sale nel cielo/ pallido e regale il faro familiare,/ lo schermo opalescente,/ il sipario/ consolante dell’infinito e dell’eterno,/ torna incerta/ tremante la parola,/ torna per dire/ solo meraviglia”.
Sant’Agata di Militello (2011)
Lucio Zaniboni
VINCENZO CONSOLO: ROMANZI, RACCONTI, OPERE E FONTI BIBLIOGRAFICHE
La ferita dell’aprile, romanzo, Milano, Mondadori, 1963; Torino, Einaudi, 1977; Mondadori 1989 (con introduzione di Gian Carlo Ferretti). Per un po’ d’erba ai limiti del feudo, racconto, in Narratori di Sicilia, a cura di Leonardo Sciascia e S. Guglielmino, Milano, Mursia, 1967. Il sorriso dell’ignoto marinaio, romanzo, Torino, Einaudi, 1976; Milano, Mondadori, 1987 (introduzione di Cesare Segre). Un giorno come gli altri, racconto, in Racconti italiani del Novecento, a cura di Enzo Siciliano, Milano, Mondadori, 1983. Lunaria, racconto, Torino, Einaudi, 1985; Milano, Mondadori, 1996. Retablo, romanzo, Palermo, Sellerio, 1987; Milano, Mondadori, 2000. (Premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia 1988) [3] Le pietre di Pantalica, racconti, Milano, Mondadori, 1988; 1990 (con introduzione di Gianni Turchetta). Catarsi, racconto, in Trittico, a cura di Antonio Di Grado e Giuseppe Lazzaro Danzuso, Catania, Sanfilippo, 1989. Nottetempo, casa per casa, 1922, Mondadori, il romanzo ha vinto il Premio Strega lo stesso anno.
OPERE
Gran parte dei volumi editi sono ora raccolti nel «Meridiano» L’opera completa, a cura di G. Turchetta con un profilo di C. Segre, Milano 2015, da cui si cita e cui si rimanda anche per una esaustiva bibliografia degli scritti (che include articoli, saggi in volume, traduzioni, riscritture e altri scritti sparsi), insieme con una dettagliata bibliografia critica.
Il volume comprende (nell’ordine delle prime edizioni): La ferita dell’aprile, Milano 1963; Il sorriso dell’ignoto marinaio, Torino 1976; Lunaria, ibid. 1985; Retablo, Palermo 1987; Le pietre di Pantalica, Milano 1988; Nottetempo, casa per casa, ibid. 1992; L’olivo e l’olivastro, ibid. 1994; Lo spasimo di Palermo, ibid. 1998; Di qua dal faro, ibid. 1999.
Ci si limita qui a segnalare i volumi non inclusi in quella edizione (anche postumi) e i saggi critici citati: Marina a Tindari. Poesie, Vercelli 1972; Vincenzo Consolo – N. Rubino, Fra contemplazione e Paradiso. Suggestioni dello Stretto, Messina 1988; Catarsi, in Vincenzo Consolo – Gesualdo Bufalino – Leonardo Sciascia, Trittico, a cura di A. Di Grado – G. Lazzaro Damuso, Catania 1989; La Sicilia. Passeggiata, Torino 1991; Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Roma 1993; Neró metallicó, Genova 1994; Vincenzo Consolo – M. Nicolao, Il viaggio di Odisseo, introd. di M. Corti, Milano 1999; Il Teatro del Sole. Racconti di Natale, Novara 1999; Vincenzo Consolo – F. Cassano, Lo sguardo italiano. Rappresentare il Mediterraneo, Messina 2000; Oratorio, Lecce 2002; Isole dolci del Dio, Brescia 2002; Reading and writing the Mediterranean. Essays by Vincenzo Consolo, a cura di N. Bouchard – M. Lollini, Toronto 2006; Il corteo di Dioniso, Roma 2009; Pio La Torre, orgoglio di Sicilia, Palermo 2009; L’attesa, Milano 2010; La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, ibid. 2012; Esercizi di cronaca, a cura di S. Grassia, Palermo 2013; Accordi. Poesie inedite di V.C. a cura di F. Zuccarello – C. Masetta Milone, S. Agata di Militello 2015.
FONTI E BIBLIOGRAFIA
M. Sinibaldi, La lingua ritrovata: V. C., in Leggere, II (1988), pp. 8-15; C. Segre, Introduzione a V. Consolo, Il Sorriso dell’ignoto marinaio, Milano 1987, pp. V-XVIII (poi in Id., Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino 1991, pp. 71-86); F. Di Legami, V. C. La figura e l’opera, Marina di Patti 1990; V. C., Nuove Effemeridi, VIII (1995/I), 29 (n. monografico); P. Farinelli, Strategie compositive, motivi e istanze nelle opere di V. C., in Italienisch, XXXVII (1997), pp. 38-45; F. Parazzoli, Il gioco del mondo, dialoghi sulla vita, i sogni, le memorie, Cinisello Balsamo 1998, pp. 21-33; G. Traina, V. C., Fiesole 2001; E. Papa, V. C., in Belfagor, LVIII (2003), 2, pp. 179-198; Per V. C., Atti delle giornate di studio… 2003, a cura di E. Papa, San Cesario di Lecce 2004; Leggere V. C. – Llegir V. C., a cura di M.A. Cuevas, in Quaderns d’Italià, X (2005), pp. 5-132; «Lunaria» vent’anni dopo, a cura di I. Romera Pintor, Valencia 2006; La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di V. C., a cura di G. Adamo, San Cesario di Lecce 2006; V.C. Éthique et écriture, Atti del Convegno… 2002, a cura di D. Budor, Paris 2007; L. Terrusi, L’onomastica nel «Sorriso dell’ignoto marinaio» di V. C., in Il Nome del testo, XIV (2012), pp. 55-
CARMELO ALIBERTI
BIBLIOGRAFIA
È nato nel 1943 a Bafia di Castroreale (Messina). Laureatosi in Lettere, ha insegnato nei licei di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).
Dopo un soggiorno a Trieste, ha definitivamente deciso di risiedere nella città giuliana, dove continua a svolgere la sua attività letteraria.
È cultore della materia in letteratura italiana presso l’Università di Messina. È stato insignito dell’onorificenza di Benemerito della Scuola, della cultura e dell’Arte da parte del Presidente della Repubblica.
A Trieste, da 10 anni, ha fondato e dirige la Rivista Letteraria e di Cultura Varia NO PROFIT TERZO MILLENNIO, a cui collaborano insigni docenti di Università italiane e straniere.
Ha scritto circa 100 volumi, di critica letteraria, di saggistica, di poesia, di tradizioni popolari e ha curato per 35 anni, nella piazza del suo paese, il dramma sacro: Vita, Passione, Morte e Resurrezione di Gesù in 37 scene variabili ad ogni edizione.
Con i suoi allievi del Liceo Scientifico di Barcellona Pozzo di Gotto ha fondato la Rivista Scolastica IL LEONARDO e realizzato un ponderoso volume di circa 456 pp., intitolato AUTORI DI BARCELLONA E DINTORNI, vincitore del Premio Letterario per le Scuola Superiori IL CONVIVIO (2005), pubblicato dalla Bastogi.
Le sue opere sono state tradotte in molte lingue. Particolarmente il suo poemetto ITACA è stato tradotto in 18 lingue. In Francia nella circostanza della traduzione della sua poesia nella collana universitaria CELIS della Blaise Pascal, è stato organizzato un convegno sull’opera di Aliberti e nella circostanza del recente Convegno sulla gravità delle frontiere, il suo intervento su la frontiera in Fulvio Tomizza, è stato pubblicato recentemente, in francese e in italiano, negli Atti, pubblicati dalla Università organizzatrice.
È stato invitato anche al Convegno sull’opera di Carlo Sgorlon, organizzato dall’Università di Udine e la sua relazione “Poetica e Filosofia” sullo scrittore friulano è stata pubblicata nei relativi atti. Ora il poeta, scrittore e giornalista Gabriel Impaglione, fondatore e direttore della rivista ISLA NIGRA, organo ufficia le dei poeti internazionali dell’UNESCO, ha tradotto in spagnolo, con prefazione dello stesso traduttore e postazione del prof. Nino Grillo (Università di Messina) e del docente Jean Igor Ghidina, maitre de conference Università Blaise Pascal.
Da qualche settimana la Bastogi-Libri di Roma ha pubblicato un saggio di Aliberti sul grande scrittore Andrea Camilleri, presente nelle migliori librerie italiane o sui più importanti siti di vendita one line, tra cui la Feltrinelli, che ha inserito nel suo catalogo 18 volumi, la libreria Universitaria, La Mondadori, Amazon ed altri, riscuotendo molto successo.
OPERE/POESIE
Una spirale d’amore (1967), Padova-Una topografia (1968), PadovaIl giusto senso (1970), Firenze. C’è una terra (1972), Milano. Teorema di poesia (1974), Milano. Il limbo la vertigine (1980-1981), Castroreale (ME). Caro dolce poeta1981-1991 Bastogi Editrice Italiana-Poesie d’amore (1984), Castroreale Marchesana (1985), Castroreale. Aiamotomea (1986), Castroreale Nei luoghi del tempo (1987), Castroreale-Elena suavis filia (1988), Castroreale-Vincenzo Consolo, poeta della storia (1992), Rhegium Julii, Reggio Calabria. Le tue soavi sillabe 1999, Castroreale Il pianto del poeta,2 002 Foggia – La ferita del tempo (2005), Bastogi Foggia “Itaca” (poemetto, dramma lirico per voce sola, tradotto in varie lingue), MGgraph, Terme Vigliatore. Il Convivio 2006. Tra il bene e il male (con introduzione di Cristina Saja e G. Barberi Squarotti, prefazione e traduzione in francese di Jean Igor Ghidina.
CRITICA LETTERARIA
Come leggere Fontamara di Ignazio Silone, Mursia editore (edizioni 1977, 1989, 1998); Guida alla lettura di Lucio Mastronardi (1986), Bastogi, Foggia; Come leggere la Famiglia Ceravolo di Melo Freni (1988) – Ignazio Silone (1990, Bastogi, Foggia; Michele Prisco (1993), Bastogi Foggia; MICHELE PRISCO -un uomo e uno scrittore nel buio della coscienza. (ed. Terzo Millennio (2017), Aracne Editrice,2020, Roma. Testi, traduzioni e interviste a poeti e scrittori contemporanei (1995), Bastogi Foggia; La questione meridionale e altre questioni in letteratura, (1997), Barcellona P.G. Messina – Sul sentiero con Bartolo Cattafi (2000, 2001, 2014), Bastogi, Foggia; Fulvio Tomizza e la frontiera dell’anima (2001, Bastogi, Foggia (tradotto in croato nel 2006 a cura dell’Università Popolare, Patrocinio M.P.I. – Umago-Croazia); Fulvio Tomizza e la frontiera dell’anima, Edizioni Terzo Millennio La narrativa di Carlo Sgorlon (2003), Bastogi, Foggia; Carlo Sgorlon, “Cantore delle minoranze 566 emarginate”, ed. Terzo Millennio, 2017 Poeti siciliani e non del Secondo Novecento, (2 volumi, 2003 e 2004), Bastogi, Foggia; Poeti Siciliani e non del Terzo Millennio (2005), Bastogi, Foggia; Letteratura siciliana contemporanea e post-contemporanea. Da Capuana a Verga, a Quasimodo, a Camilleri, Luigi Pellegrini Editore (2008). 50 anni d’amore per la letteratura, ed. Terzo Millennio, 2014. Ha curato l’edizione scolastica di “Stalag 307, diario di prigionia di Carmelo Santalco”, Bastogi editore, Foggia 1998 100 Poeti per L’Europa del Terzo Millennio. Ha fondato ed è direttore editoriale della Rivista Internazionale di Letteratura e Cultura Varia TERZO MILLENNIO, 2009. Ha pubblicato su Terzo Millennio, Monografia su G. Verga, I. Silone. V. Consolo, S. Quasimodo, Stefano D’Arrigo, Leonardo. Sciascia, Claudio Magris, Sebastiano Saglimbeni, Lucio Zinna, Nino Pino, Ignazio Silone, eroe dei cafoni della Marsica, Matteo Collura, Luigi Pirandello, Vitaliano Brancati, Beniamino Joppolo, Guglielmo Jannelli, Turi Vasile, Lucio Piccolo. Giovanni Occhipinti, Bartolo Cattafi, Lucio Mastronardi 1983-2008, e molti altri. L’altra letteratura Siciliana Contemporanea, La Medusa (2013, per le Scuole Superiori e per le Università. Ha organizzato in piazza, trasformata in Teatro, annualmente e con continui aggiornamenti, i testi sacri della Vita, Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. A scuola con i suoi allievi ha realizzato il volume: Poeti di Barcellona e dintorni, al Liceo scientifico di Barcellona P.G (pubblicato da Bastogi e vincitore del Premio Nazionale per le Scuole Superiori e I miti dello Stretto, 2008.
Da poco è uscita Letteratura e società Italiana dal II Ottocento ai nostri giorno, in 6 volumi di circa 4000 pp. e le monografie DACIA MARAINI, BARTOLO CATTAFI, il poeta che cercò disperatamente Dio e lo trovò nell’Arcipelago del cuore: LUCIO MASTRONARDI, scrittore scomodo e dimenticato.
NARRATIVA
BRICIOLE DI UN SOGNO, romanzo, Bastogilibri, Roma 2021;
IL MIO MONDO FINIRA’ CON TE – romanzo. Edizioni Terzo Millennio, gennaio2022.
PREMI
Premio “Rhegium Julii. Una vita per la cultura” (Reggio Calabria, 1999)- Premio Mediterraneo, 2001, Premio alla Carriera.-Premio Inter. nazionale “Il Convivio 2004” per la saggistica (per La narrativa di Carlo Sgorlon (Catania)Premio alla carriera “Messana”, Messina 2005-Premio letterario nazionale per la critica letteraria “Giorgio La Pira” (Milazzo,ME, 2008) Premio AGENDA “2019” AQUILA D’ORO per l’intera opera. Premio alla Cultura Terzo Millennio-24live,2021, per il romanzo BRICIOLE DI UN SOGNO”, Bastogilibri, Roma.
SAGGI SULL’OPERA DI CARMELO ALIBERTI
Orazio Tanelli: Carmelo Aliberti, poeta cosmonauta; Placido Conti: Carmelo Aliberti un uomo, un poeta, un cittadino – Paola Bianco: Da Quasimodo, a Cattafi, ad Aliberti; Francesco Puccio: Carmelo Aliberti, poeta della dialettica esistenziale (2004); Giuseppe Manitta: Carmelo Aliberti archeologo dell’anima, in G. Manitta, Stefano Pirandello e altri contemporanei, Il Convivio, 2007, Giorgio Barberi Squarotti: Carmelo Aliberti: poeta civile sul sentiero metafisico.
INDICE
PREFAZIONE di Francesca Romeo 1
Capitolo 1 5
A VINCENZO CONSOLO – Poeta della storia
Capitolo 2 7
IL LICANTROPO E LA LUNA – Rime di Carmelo Aliberti –
CLAUDIO TOSCANI (Critico letterario – da AVVENIRE)
Capitolo 3 13
VINCENZO CONSOLO
Capitolo 4 19
I PRIMI GRANDI ROMANZI
Capitolo 5 24
GLI ANNI OTTANTA E IL DITTICO BAROCCO DI LUNARIA
E RETABLO
Capitolo 6 26
LA TRILOGIA DEGLI ANNI NOVANTA
Capitolo 7 29
IL SILENZIO DELLO SCRITTORE
Capitolo 8 30
VINCENZO CONSOLO, IL POETA DELLA STORIA
E LA METAFORA DELLA CONCHIGLIA
Capitolo 9 41
NOTTETEMPO CASA PER CASA, METAFORA DELL’APOCALISSE
Capitolo 10 53
LA TORRE DELL’URLO E DEL SILENZIO
Capitolo 11 64
ESERCIZI DI CRONACA
Capitolo 12 68
VINCENZO CONSOLO E LA SICILIA
Capitolo 13 70
VINCENZO CONSOLO, GLI ORRORI DELLA STORIA, LO SPASIMO DELL’UOMO, LA SCHIAVITÙ DEGLI OPPRESSI, LA MORTE DELLA LETTERATURA E LA UTOPISTICA E OMOLOGATA SOPRAVVIVENZA NELLA MEDIOCRITÀ DEI GESTI E NELLA FUGA DALLO SQUALLORE NEL MITO DI EMPEDOCLE.
Capitolo 14 90
INTERVISTA A VINCENZO CONSOLO (RAI)
Capitolo 15 93
IL VOLTO DEL MEDITERRANEO HA IL SORRISO DI CONSOLO
Capitolo 16 97
UN MESE CON VINCENZO CONSOLO
Capitolo 17 98
IL SIMBOLO DELLA LUMACA
Capitolo 18 112
SCRITTI DI SICILIA – “COSE DI COSA NOSTRA”
Capitolo 19 123
LA METRICA DELLA MEMORIA
Capitolo 20 138
VINCENZO CONSOLO: “ANDIAMO VIA DA QUESTA ORRENDA CITTÀ”
Capitolo 21 144
L’OPERA SOSPESA
POSTFAZIONE di Lucio Zaniboni 155
VINCENZO CONSOLO: ROMANZI, RACCONTI, OPERE
E FONTI BIBLIOGRAFICHE 158
CARMELO ALIBERTI – BIBLIOGRAFIA 161