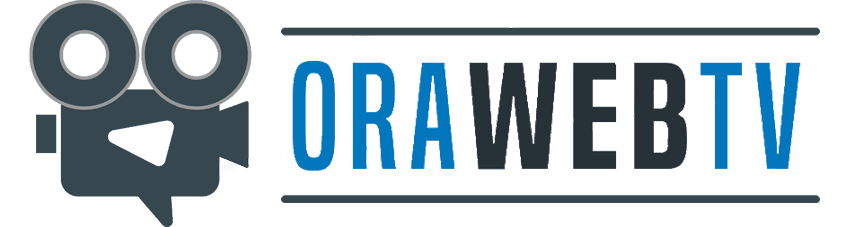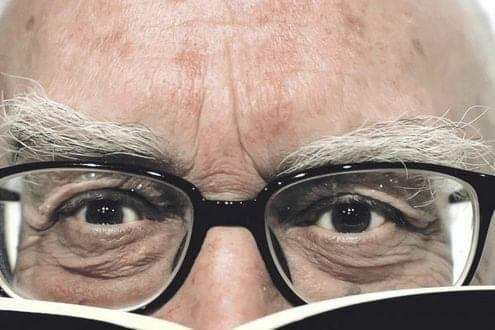Abbiamo pubblicato nelle settimane scorse le prime quattro parti della copiosa opera omnia ricevuta dal Prof. Carmelo Aliberti sulla figura del grande Andrea Camilleri. Dopo i cenni generali sulla biografia e sulle opere continuiamo ad addentrandoci nei tanti lavori dello scrittore siciliano con questa V Parte. Buona lettura.
La Strage Dimenticata
La preziosa scoperta della strage sconosciuta compiuta nel 1948 con cui Camilleri anticipa le successive rivolte narrate ne ‘Il Gattopardo’ e ne ‘Il sorriso dell’ignoto marinaio’ di Vincenzo Consolo.
Dopo il successo incredibile, della serie investigativa de “Il
Commissario Montalbano”, magistralmente interpretato da Luca
Zingaretti per la Rai Tv che rese popolare l’attore e la serie fu
molto apprezzata dai telespettatori con un’audience da record e
replicata più volte dalla TV italiana con incessanti richieste di
numerose televisioni straniere che pagano i diritti relativi per
poterlo proiettare sui propri schermi con altrettanto entusiasmo,
consolidato anche dalle trenta milioni di copie vendute dei suoi libri
polizieschi in tutto il mondo, in numero sempre crescente. Andrea
Camilleri, dopo aver curato le sceneggiature di molti romanzi
televisivi, quasi in sordina, si è occupato anche della regia di
diversi sceneggiati a puntate con successo. Gli editori, dopo
l’exploit dell’eccezionale produzione narrativa che vede sempre alla
prova gli stessi attori, divenuti originali interpreti specializzati
nella originale lingua espressiva, inventata dallo scrittore
attraverso la struttura generale dei testi che, nello scorrere della
linea di sviluppo della trama, progredisce anche in lacerti
linguistici di provenienza popolare, ingioiellando il periodo, i
dialoghi dei personaggi e le inchieste, con l’innesto di perle
linguistiche personali e lontani da ogni forma di sperimentalismo, che
attraggono l’attenzione e la riflessione anche dei linguisti per
l’inserimento della parlata dialettale della sua terra ,resa ancor più
realistica in sintonia con il realismo delle indagini dei diversi
“casi” di reato e degli interpreti, indagati o testimoni, dalle cui
labbra si espandono emissioni di una lingua spezzata con il prezioso
termine licatese nell’articolazione espressiva, con il rafforzamento
armonioso del termine nello sviluppo del discorso e nella prosecuzione
del racconto, in cui lo scrittore distribuisce nel testo i termini
allogeni che il lettore attento riesce a comprendere. Del resto
sappiamo bene che la lingua italiana è quella studiata a scuola, a cui
molti hanno rinunciato per semplificare ogni dialogo con i propri
simili e con i genitori, che altrimenti si sarebbero “liquefatti” nel
faticoso lavoro e in tutte le altre incombenze della cura dei campi.
Occorre anche notare che, al tempo in cui Montalbano opera, la lingua
italiana era parlata da non molti cittadini, per cui Camilleri intuì
che per rendere credibili tante storie criminali e accostarsi più
facilmente al pubblico dei lettori, quella lingua doveva avvicinarsi a
quella usata nella quotidianità con spontanea trasparenza. Le
strategie investigative non sono adoperate con i ben noti, rigidi e
protocollari interrogatori dei precedenti commissari televisivi, che
spesso nella procedura giudiziaria finiscono con la prescrizione del
reato perseguito o per mancanza di prove schiaccianti o per il
prolungamento di ricerca delle prove a danno dell’indagato, che spesso
riesce a dissolvere ogni traccia di elementi accusatori. Il
commissario di Camilleri, saldo punto di riferimento protettivo per
gli abitanti di Licata, (denominazione inventata per indicare la sua
Porto Empedocle, in gran parte gente povera e onesta), che si rendono
subito collaborativi all’indagine, fornendo informazioni determinanti,
garantiti dalla segretezza e sicuri di non essere traditi, con il
rischio di divenire oggetto di vendette, di rappresaglie e anche di
attentati alla propria persona, ai propri familiari e ai loro beni. Il
commissario non ricorre a toni arroganti con gli indiziati per
estirpare la confessione di un reato, ma accoglie con cordialità
l’imputato e, attraverso un colloquio familiare ,quasi amicale, lo
avvolge in una invisibile ragnatela di contraddizioni che riesce ad
imboccare la pista della verità e a spiegare con limpida certezza la
dinamica del delitto, riuscendo a stimolare nel presunto colpevole i
meccanismi invisibili del rimorso che lo inducono volontariamente a
confermare ogni dettaglio criminoso del suo folle gesto e a liberarlo
dal tarlo del rimorso. Lo scrittore, in tal modo, dimostra come si può
amministrare la giustizia, senza la ghettizzazione del colpevole,
senza umiliarne la dignità di creatura umana, che accetta la giusta
condanna per poter essere riaccolto, senza pregiudizi nella società.
Infatti, il Commissario senza pistola svolge un’azione repressiva, ma
anche formativa, particolarmente quando ricostruisce le sequenze del
delitto, con razionale documentazione di prove, che trafiggono il
colpevole, lo fanno crollare e confessare la propria colpa. La
struttura dei romanzi polizieschi di Camilleri e il linguaggio
italo-licatese, e talvolta gergale, evidenziano una rara e semplice
elaborazione espressiva, che affascina il lettore sprovveduto, lo
induca a capire la vicenda narrata, risucchiato nelle carambole
linguistiche degli accadimenti ed estrarne il messaggio dell’episodio,
che lo scrittore vuole stimolare verso al rispetto della legalità per
poter vivere in un mondo meno crudele. Lo scrittore riesce qui, come
negli altri suoi racconti di commissario, a conciliare l’istinto a
delinquere dell’uomo con la capacità razionale del suo possibile
“recupero” del suo codice morale per potersi riscattare dalle
seduzioni del Male e riprendere il cammino terrestre verso orizzonti
più limpidi e sereni.
“La Strage dimenticata” non è un romanzo poliziesco simile a tutta la
serie delle opere poliziesche riconducibili al giallo, ma è la
ricostruzione argomentativa di alcuni sanguinosi episodi, rimasti
avvolti nell’ombra del mistero, appresi dai racconti della nonna,
quando Andrea era bambino e che, in parte, furono il nucleo ispiratore
di tanti intrighi tematici di alcune opere memorabili. “La strage”
racconta una di quelle vicende, che rimasero dimenticate, perché
incomprese dagli abitanti contemporanei, ma, durante una solita
passeggiata pomeridiana, sulla strada che, attraverso un vecchio
ponte, conduce verso la vecchia Torre, in cui era avvenuta la strage
raccontata dalla nonna. A contatto con il memorabile paesaggio, si
ridesta nei suoi pensieri l’eco del mistero o dei tanti dubbi rimasti
irrisolti su quel sanguinoso episodio che coinvolse in una morte
misteriosa 114 detenuti nella Torre e che nessuno riuscì a capire né
la causa, né la dinamica di quella strage, Contemporaneamente a
Pantelleria Altre 15 persone furono fucilate senza alcuna colpa, ma in
seguito ad infamanti calunnie, circolate strumentalmente. In atri
paesini periferici del Meridione avvennero simili stermini di
innocenti. Per “la tragedia” della Torre penitenziaria, la gente pensò
ad un’operazione repressiva per un tentativo di fuga dei detenuti. In
realtà, lo scrittore li inquadra nelle rivolte che divamparono in
Europa, che illusero alcuni popoli del vecchio continente,
schiavizzati dall’azione punitiva del vecchio regime, riportato al
potere dalle decisioni della restaurazione. La strage fu consumata su
iniziativa del maggiore Sarzana, custode responsabile della Torre che,
precedendo una presunta rivolta dei detenuti, già in fermento per le
nuove idee rivoluzionarie circolanti in Tutta l’Europa, per precedere
un’eventuale rivolta dei detenuti che avrebbero travolto anche lui,
rinchiuse i detenuti in una cella del luogo di pena e li bruciò vivi,
alcuna pietà. Le vittime di tanto orrore, in realtà, si sentirono
infiammati dalle nuove idee anti-tiranniche ed erano sull’orlo di
un’azione di rivolta. Nessuno intervenne per chiarire le vere ragioni
della strage e i responsabili, perché momentaneamente nel Sud
borbonico la rivoluzione fu rinviata. Camilleri individua, attraverso
episodi paralleli avvenute altrove, le radicali cause delle sparse
rivolte siciliane, generate dai soprusi subiti dalla plebe
meridionale, particolarmente a Palermo nel 1848,quando il 9 gennaio la
folla si ribellò, anticipando i successivi movimenti di liberazione
ripresi da Consolo nel romanzo “Il sorriso dell’ignoto marinaio” e nel
Gattopardo di G. Tomasi di Lampedusa, che evidenziarono anche i primi
tentativi di sostegno clandestino dei nobili , dei possidenti e di
quanti volevano mantenere il potere, anche a costo di un vituperevole
voltafaccia. Ma sotto la spinta di tali coraggiosi episodi di Rivolta,
Ferdinando II concesse a Napoli la prima costituzione.
Il testo
Il nove gennaio 1848 i muri di Palermo furono tappezzati da un
proclama che principiava così: «Siciliani! Il tempo delle preghiere
inutilmente passò! Inutili le proteste, le suppliche, le pacifiche
dimostrazioni. Ferdinando tutto ha sprezzato. E noi, popolo creato
libero ridotto fra catene e nella miseria, tarderemo ancora a
riconquistare i legittimi diritti? All’armi, figli della Sicilia! La
forza di tutti è onnipossente: l’unirsi dei popoli è la caduta dei re.
L’alba del 12 gennaio 1848 segnerà l’epoca gloriosa della universale
rigenerazione». In queste parole due cose impressionano, una delle
quali sommamente. La prima è che un’insurrezione sia annunciata non
solo pubblicamente ma addirittura con tre giorni d’anticipo, segno –
come spesso avviene – non tanto d’incoscienza o di inarrestabile
«geometrica potenza» degli insorgenti quanto di imbecille sordità dei
tutori del momentaneo ordine costituito. La seconda, quella che ci fa
restare del tutto intronati, è che l’insurrezione sia poi scoppiata
davvero e – a Palermo! – alla data stabilita. (…) Se al manifesto di
Francesco Bagnasco sia De Majo sia gli alti comandi borbonici non
avevano dato orecchio, meno che mai glielo poteva dare il maggiore
Emanuele Sarzana che comandava il presidio della Torre alla Borgata
Molo. Lì tutto appariva tranquillo, il botto non si era sentito.
Scrisse Marullo: «Nessun fuoco di odii animava i buoni e pacifici
cittadini. Avevano essi sentito parlare di libertà, ma di questa dea
fascinante non intuirono che il mistero del nuovo: essi onesti,
laboriosi, ossequienti alle leggi, nulla seppero della tirannide, la
quale non li aveva notati e, perciò, non li aveva investiti». Può
darsi, ma la Borgata Molo era un paese di mare, ed è risaputo che ogni
buon marinaio, prima di alzare la vela, deve calcolare esattamente da
che parte tira il vento e sapere se quel vento tiene. Però c’erano, in
paese, almeno duecento persone che della «dea fascinante» avevano
preciso concetto, e questa «dea» non aveva «il mistero del nuovo»,
anzi, aveva tutto di vecchio e di conosciuto: la famiglia non più
vista da anni, le facce degli amici quasi dimenticate, il ritmo di una
camminata fatta in campagna senza la palla al piede, l’odore di una
femmina. E loro dall’occhio della tirannide erano stati sì notati, o
almeno di questo erano certamente convinti, perché è risaputo che ogni
carcerato è pronto a proclamarsi vittima innocente delle macchinazioni
del potere. La quarantottesca rivolta degli abitanti della Borgata
inizialmente – sempre secondo Marullo – «non si ridusse che allo
scampanellare del tempio e un vociare incomposto di abbasso e di
evviva a perdersi tra la collina e il mare». È vero, ma bastò perché
una squadra di forzati, quella che era addetta ai lavori agricoli,
sopraffatte le guardie, si desse alla fuga. La notizia arrivò in un
attimo in paese e fece sprofondare nel terrore i notabili e i
commercianti, che si barricarono in casa. (…) Allora, visto che si
cominciava a sentire feto di bruciato, pure Sarzana si rinserrò nella
Torre con i suoi soldati e con gli ergastolani, sicuramente
maledicendo il giorno in cui, trecent’anni prima, era stata decisa
l’abolizione del ponte levatoio. (..) La mattina dopo, visto che degli
ergastolani scappati in paese non era rimasto manco l’ombra, la vita
nella Borgata tornò ad essere normale, con Sarzana sempre intanato
dentro la Torre. Ma il giorno 25 arrivò la notizia che De Majo se ne
era andato dal palazzo reale di Palermo e che De Sauget con i suoi
cinquemila soldati stava faticosamente ritirandosi su Messina. (…)
Sicché a rappresentare il regno borbonico in Sicilia rimanevano il
forte di Castellammare, la Cittadella di Messina, la Torre della
Borgata Molo, e qualche altra fortificazione sparsa, che praticamente
non erano in condizioni di svolgere un’azione comune, ammesso che ne
avessero sentito la voglia. I borbonici rimasti in Sicilia erano in
sostanza degli assediati. E a rendere concreto l’assedio, al tramonto
del giorno 25, una folla di un centinaio di persone si spinge,
vociando, sotto le mura della Torre. È sbagliato credere che gli
abitanti marinari della Borgata avessero deciso che il vento della
rivoluzione teneva: in mezzo a quella gente i borgatanti veri e propri
saranno stati una trentina, la maggior parte dei quali «saccaroli»,
vale a dire trasportatori di sacchi, quelli che in paese svolgevano il
lavoro più duro ed erano i meno pagati. «In quei giorni erano arrivati
molti forastieri» contava mia nonna. E si spiega: parenti e amici
avevano avuto tutto il tempo di correre dai loro paesi alla Borgata
per organizzare la liberazione dei forzati, e molti di questi
forestieri, approfittando dell’ammaino generale, erano arrivati
armati. (…)
Quando i carcerati sentono le voci da fuori, eccitatissimi, non
sapendo precisamente quello che sta succedendo ma comprendendo che
comunque sia qualcosa si muove a loro favore, si mettono a fare un
tirribìlio di voci e rumori. Di fronte a questa situazione, Sarzana,
contrariamente a quanto pensa Marullo, non perdette la testa né fece
ciò che fece mosso da cieca rabbia. Capì subito infatti che se tutti
gli uomini gli servivano per parare il pericolo esterno, bisognava che
a sorvegliare i carcerati non restasse manco un soldato. Ordinò quindi
che a botte, a colpi di calcio di fucile, a catenate, tutti i forzati
sparsi per la Torre fossero obbligati a calarsi nella fossa comune.
(…) Una volta al sicuro gli ergastolani, Sarzana comandò ai soldati
di salire sulla terrazza, attraverso la scala che era dentro il
cilindro, e di isolare poi la scala stessa con le due chiusure, quella
superiore e quella inferiore, per evitare di essere attaccato alle
spalle se, per caso, i galeotti fossero riusciti a scardinare la grata
della fossa comune. (…) A questo punto dalla folla comincia a
partire qualche colpo di fucile e per i soldati dare la risposta si
presenta subito difficile: la Torre non ha mai avuto merli dietro cui
ripararsi, sparare dalla terrazza significa perciò alzarsi in piedi ed
esporsi per qualche secondo al fuoco avversario protetti solo a metà
dalla balaustrata che corre torno torno. La sparatoria, che non può
ottenere apprezzabili risultati da una parte e dall’altra, si allunga
nel tempo fiaccamente. Quanto basta però perché i forzati nella fossa
vengano a trovarsi completamente senz’aria. (…) Contrariamente ai
tonni che muoiono in uno spaventoso silenzio, i forzati fanno voci da
disperati. Sarzana a un certo punto sente che il registro di quelle
urla è cambiato e manda due soldati a vedere cosa sta succedendo. I
soldati glielo riferiscono e gli dicono magari che la grata rischia di
cedere sotto la pressione dei carcerati letteralmente impazziti per la
mancanza d’aria. Perciò il maggiore capisce di non avere più via
d’uscita: farli uscire ora come ora dalla fossa è uguale a liberare
cento gatti inferociti da dentro un sacco all’interno di una stanza,
il minimo che possono fare è saltargli agli occhi; lasciare aperta la
presa d’ aria non si può nemmeno, con la grata che sta per cedere.
L’unica è alleggerire la pressione che contro di questa i forzati
esercitano: dà ordine, allora, di lanciare tre petardi nella fossa e
di isolare nuovamente, subito dopo, la scala. (…) Il botto dei tre
petardi sparati all’interno raggiunge gli assedianti i quali, poco
dopo, sentono progressivamente affievolirsi le voci degli ergastolani.
Dalla folla allora non sparano più, tutti si rendono conto che
qualcosa di grave deve essere accaduto e questo, invece di aizzare la
violenza, la tramuta in una sorta di sudata perplessità. Manco i
soldati dalla terrazza tirano più colpi. «La popolazione – scrive
Marullo – fatta per ansia muta, intuisce, si smarrisce e si dirada
silenziosa a occultare tra le atterrite famiglie, il tormento
angoscioso della propria anima, in cui la sospettata sciagura gravava
già col rimorso di una colpa inconsapevolmente commessa!». (…)
Continuando nella sua esposizione, Marullo afferma che il giorno dopo
(…) «Carri carichi di uccisi, buttati alla rinfusa, l’uno sull’
altro – teste e gambe penzoloni – le carni violacee, sanguinolenti
ancora, lacerate dalle schegge delle bombe, passano per l’unica via
del paese, per trovare sepoltura su la lontana spiaggia, come se
responsabili essi fossero della loro morte violenta e, perciò, dovesse
essere loro negata la pace nel cimitero del paese! Carri molti
passarono così, tra il profondo cordoglio della nostra gente, che nel
proprio cuore non trovò che una prece pietosa per le vittime
infelici». (…) Secondo (…) altra versione, più credibile, il
trasporto di alcuni morti solamente ci fu sì, ma molti giorni dopo.
Coincide però il luogo del seppellimento: la spiaggia proprio sotto il
Caos, il posto dove nascerà Pirandello. Per indicare che lì c’ erano
dei morti, ci misero una croce di legno e per questo la località, che
prima era anonima, da allora in poi si chiamò «’a crucidda».
Nell’appendice del primo racconto storico, Camilleri dimostra la sua
eccezionale modestia (e si sa che tale dote è dono degli Uomini
Grandi) nel non attribuirsi il merito della scoperta dell’elenco dei
nomi trucidati nella rivolta siciliana del 1848 e titola le fasi della
strage di 114 martiri indifesi e innocenti e velocemente dimenticata
in una nota introduttiva al racconto in cui rivela le sequenze e i
motivi di “una carneficina di innocenti”, sospettati maldestramente di
volersi unire agli insorti in varie parti dell’isola per potersi
finalmente liberare dall’atroce condizioni di vita, di cui erano da
secoli reclusi.