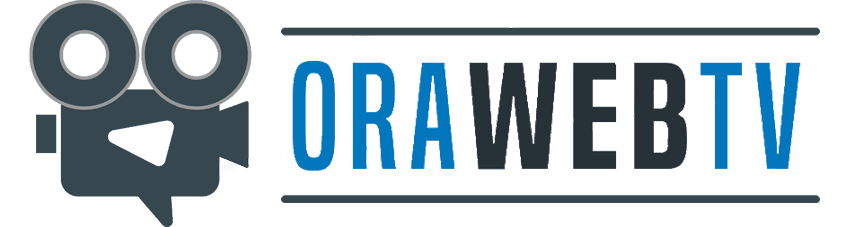Siamo giunti alla X ed ultima parte della lunghissima opera omnia del Prof. Carmelo Aliberti dedicata al grande scrittore siciliano Andrea Camilleri, che in questi mesi abbiamo pubblicato ricevendo ampi consensi dai nostri lettori. In questa occasione fra le altre il Prof. Aliberti si sofferma sul come Camilleri tratta il tema mafia, sull’intreccio fra poliziesco e linguistica nei propri romanzi. Buona lettura.
IL GIOCO DELLA MOSCA
A BADDRUZZA O’ PAPA’ La pallina al papà. A commentare un’azione che
può apparire disinteressata, altruista, ma in realtà è assai
redditizia per chi la compie. Gnazio Spidicato faceva il contabile
nello scagno di mio nonno che si occupava di commercio di zolfi. Aveva
uno stipendio minimo, a casa l’aspettavano una moglie e cinque figli
piccoli, di cui tre gemelli. Certamente doveva fare i salti mortali
per nutrire la numerosa famiglia e lui pubblicamente si vantava di
farli, a destra e a manca raccomandando come alla lettera si levasse
il pane di bocca per darlo ai suoi, come il suo unico nutrimento fosse
vedere i suoi familiari che mangiavano. ‘E in allegria’ aggiungeva.
‘Non faccio pesare il mio sacrificio. ‘E voi come fate?’. ‘Niente. Mi
basta una crosta di pane’. Cominciò ad essere in sospetto di santità”
Sentenze, detti, mimi, proverbi del parlare siciliano, raccolti e
spiegati «geneticamente», al modo del loro nascere da microepisodi
variamente tramandati, micronarra zioni, o – come dice Camilleri – da
«storie cellulari»: «Il mio era un paese di terra e mare. Aveva un
hinterland abbastanza grande da potervi fare allignare i germi di una
cultura contadina che s’intrecciavano, si impastavano con quelli di
una cultura, più articolata e mossa, che era propria dei pescatori,
dei marinai. Dal tempo della mia infanzia molte cose sono naturalmente
cambiate, in meglio o in peggio non m’interessa, ma proprio perché
cambiate rischiano di perdersi, di svanire anche all’interno della
memoria»
IL NIPOTE DEL NEGUS
Il libro di genere storico, come espresso dall’autore, ha la stessa
struttura narrativa de “La concessione del telefono” documentazioni
d’archivio o missive che sembrano dispacci perentori s’intersecano a
frammenti dialogici-narrativi in un rimando continuo di stampo tipico
camilleriano. Secondo notizie veritiere, si narra di un nipote del
Negus etiopico Haileè Sellassiè che negli anni 1929-1930, frequentò a
Caltanissetta la Regia Scuola Mineraria presso la quale si diplomò
perito minerario nel 1932. Qui finisce “la verità” e da qui inizia la
fantasia! Sì, lo sfondo storico fa da fondale alla rappresentazione
teatrale della vicenda, ma i cerchi concentrici che attorniano i
fatti, i personaggi, sono frutto esclusivo dell’inventiva dello
scrittore: la retorica tronfia dell’epoca investe come vento impetuoso
e trascina sentimenti e azioni in una sorta d’irriverente pantomima di
memoria goliardica. Tra le righe entriamo da spettatori in una sorta
di film in 3D, ci sembra di rivivere, certo in toni farseschi e
burleschi, situazioni quasi reali ed attuali e non già fantasmi del
passato ormai desueti. Come non ridere con un retrogusto amaro agli
ossequi inverecondi verso i superiori, ai titoli onorifici così
ridondanti ed enfatici, alla supponente grandeur di una nazione
piccina piccina. Con sarcastica vis Camilleri ci presenta una verità
storica in modo talmente burlesco da risultare falsa e una falsità
storica così pronunciata da risultare vera. E’ il gioco degli inganni
di chi si crede furbo e s’inganna e a sua volta viene ingannato. Una
farsa che ha le movenze di un minuetto e il tono scanzonato e
irriverente di uno sberleffo. L’ intreccio ricorda una novella
boccaccesca, tra intrighi ed intrecci amorosi, tra ragion di stato e
convenienze personali, tra vizi confusi con desideri in un carosello
umano più farsesco che reale. Camilleri ci diverte e ci delizia, ma
forse avremmo voluto ridere meno su noi stessi, su quello che siamo
stati e siamo, perché c’è poco da ridere quando i sogni dei più
vengono meno e non albergano speranze di reali cambiamenti positivi
per tutti.
LA FABBRICA DI UNA SCRITTURA
In principio furono le aste. Pagine e pagine prima di passare alla
lettera a. Ma in prima elementare Andrea Camilleri sapeva già leggere
e scrivere e fu la noia a fargli iniziare a raccontarsi delle storie,
a giocare con le parole, una confidenza con la lingua che continuò per
tutti gli anni della scuola quando italiano e dialetto avevano confini
precisi e insormontabili. Si innamorò della lingua, gli piacevano le
assonanze, le rime, combinava le parole tra di loro, se le ripeteva
perché è il suono quello che conta: scoprì la poesia. «Poeta si nasce,
non perché dentro di te sgorghino le rime, ma perché si formano le
immagini. È come una musica di sottofondo». Scriveva versi, ma poi
smise del tutto: l’ammissione come allievo regista all’Accademia
nazionale di arte drammatica con Orazio Costa – che Camilleri
considera il suo vero e unico maestro – gli aprì un mondo, quello del
teatro. Camilleri si è raccontato tante volte, ma mai ha messo a nudo
in maniera così lucida e articolata la sua formazione di scrittore e
la sua avventura linguistica; dal significato dell’esperienza teatrale
– da cui ha ricevuto l’arte del dialogo e quella di far muovere i
personaggi in un dato spazio – alla radio – 1.000 le sue regie
radiofoniche – alla TV, al romanzo. La fabbrica di una scrittura che,
partendo dalla parlata familiare fatta di siciliano e italiano, aveva
però tutt’altra ambizione: quella di costruire un proprio idioletto,
una lingua individuale, irripetibile, che è poi la magnifica prosa che
tutti conosciamo. Una sperimentazione che non si e fermata nel corso
degli anni né per la lingua né per la struttura delle sue storie
(basti pensare al Birraio di Preston in cui viene abolita la logica
della successione temporale – soluzione presa a prestito dal Pianista
di Vázquez Montalbán – o a La concessione del telefono, un
romanzo/faldone). Infine la scelta del «giallo» scaturita dalla
lettura del Pasticciaccio di Gadda. «Trovai così bene raccontata
l’epoca del fascismo da restarne senza parole. E allora mi venne
l’idea di rovesciare il campo, di dare più importanza al contesto
storico in cui avviene il fatto piuttosto che al fatto stesso… In
tutti i romanzi di Montalbano c’è un interesse laterale che pare in
secondo piano ma che invece non lo è… Scrivo di Montalbano non tanto
per risolvere casi ma per sollevarne». E poi la magarìa della memoria,
quella biblioteca archetipa di cui parlava Calvino alla quale gli
scrittori inconsapevolmente attingono. Una magarìa che è l’incantesimo
della scrittura di Camilleri. Una conversazione durata vent’anni con
Valentina Alferj – sua preziosa collaboratrice – una lunga
consuetudine fatta di appunti, annotazioni, ricordi che esplora la
fabbrica della scrittura di un narratore unico, entra nella sala
macchine con la consapevolezza dello specialista, con la vivacità di
un lettore accorto e curioso. In appendice saranno pubblicati per la
prima volta degli inediti giovanili (il racconto Sweet Georgia Brown e
alcune poesie) e le riproduzioni di pagine di taccuini giovanili.
… un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo sull’estremo confin del
mare. E poi la nave appare… Illica – G. Giacosa, Madama Butterfly,
atto II, parte prima.
IL CAMPO DEL VASAIO
La lettura d’un romanzo può essere ancora un divertimento, una festa?
Camilleri lo crede, se traspone in balletto scatenato, in farsa
grottesca il suo mondo siciliano, di cui nel primo libro Il corso
delle cose aveva mostrato gli aspetti misteriosi e crudeli. Siamo a
Vigàta, paese marino e mercantile, dove un vasaio si è innalzato nella
scala sociale seguendo come un’anguilla le correnti mobilissime del
trentenni o venuto dopo l’unità. Un’aria di operetta, di
belle-époque, circonda uomini e fatti; la nave russa che deve
arrivare a caricare lo zolfo, un prete che ama la poesia pornografica,
la disinibita straniera e il suo mistico marito isolano sempre in
preghiera; tutto un “coro” è in attesa del filo di fumo che annuncerà
la nave punitrice dell’intollerabile potere della nuova razza
padrona. Ma i miracoli esistono, e premiano chi vogliono. Un miracolo
appunto è al culmine di questa costruzione-regia che Camilleri, uomo
di spettacolo, conduce con calcolata sapienza, e che si colorisce di
un impasto linguistico insolito, siculo certamente, ma dove ogni
vocabolo è un’invenzione.
IL LADRO DI MERENDINE
Dopo la forma dell’acqua e il Cane di terracotta questo e’ il terzo
“giallo” di Andrea Camilleri ad avere come protagonista Salvo
Montalbano, il commissario di stanza a Vigata, “il centro piu’
inventato della Sicilia piu’ tipica”. Questa volta Montalbano – si
preoccupa peraltro di evitare la promozione a vicequestore, che
significherebbe compromissione burocratica e rinuncia ai propri
capricci investigativi – sospetta l’esistenza di un collegamento tra
due morti violente: quella di un tunisino imbarcato su di un
motopeschereccio di Mazzara del Vallo e quella di un commerciante di
Vigata accoltellato dentro un ascensore. Per Camilleri la Sicilia di
oggi e’ fonte continua di ispirazione e di scoperta, di intrecci di
romanzo poliziesco e di osservazioni su di un costume magari
inquietante ma certamente non statico; soprattutto gli suggerisce un
linguaggio, una parlata mai banale ne’ risaputa. Tutto il contrario
delle metafore viete e irritanti adoperate degli uomini dei servizi
segreti con i quali Montalbano si trova a scontrarsi duramente: figure
retoriche sempre piu’ incapaci di reggere il discorso della “ragion di
stato” quando ormai, come osserva il nostro commissario, “praticamente
serviamo due stati diversi”.
QUALE MAFIA NEI ROMANZI DI CAMILLERI?
Spesso la critica ha contestato agli scrittori siciliani, pur
riconoscendo il valore letterario di un romanzo o di un autore, di non
affrontare il problema della mafia, che, come le molte inchieste,
processi, condanne, ne evidenziano la presenza condizionante nella
vita quotidiana dei siciliani, che sono vittime di intimidazioni,
ricatti, estorsioni, delitti, minacce di morte, bambini sciolti nella
pece bollente, danni dolosi, incendi di abitazioni e danneggiamenti ai
mezzi di lavoro agli imprenditori di ogni livello. a sequestri di
persona, morti bianche e sparizioni di cadaveri, impastati nel cemento
e intombati nei pilastri delle autostrade o nel greto di vasti fiumi,
divenuti così “Cimiteri della Malavita”, dove vengono interrati membri
di famiglie malavitose, in guerra tra di loro per il dominio del
territorio o per l’egemonia degli affari sporchi nei diversi quartieri
delle città o dei piccoli centri. Tale organizzazione criminosa,
definita dai criminologi e degli studiosi del fenomeno totalizzante
del male, che gli scrittori siciliani hanno sottovalutato o
addirittura eluso come un imperdonabile negazionismo, come sottolinea
Camilleri. Nei racconti, che hanno come protagonista il Commissario
Montalbano, la mafia non appare come protagonista delle storie, ma è
innestata nelle trame, perché lo scrittore dichiara di non voler
contribuire al consolidamento del deleterio mito della mafia, perché
il romanzo finisce con il nobilitare personaggi indegni…” Attenzione!
a non fraintendere. Non sto proponendo di cassare capolavori assoluti,
come “Il padrino”. Ma è la stessa forza emotiva del romanzo che
trasforma in mito il personaggio mafioso, al di là, delle intenzioni
dello scrittore, come quello di don Vito Corleone, mafioso, ma uomo
ragionevole, padre, marito e nonno affettuoso, tanto da trasmettere al
nipotino l’amore per i fiori. La polemica del riconoscimento in
letteratura dell’onorata società rimase sempre controverso. Anche
Leonardo Sciascia che, per primo, con il romanzo “Il giorno della
civetta” (1963), affrontò coraggiosamente ed esplicitamente lo
scabroso problema, venne contestato per la figura del boss, don
Mariano Arena, percepito dal lettore come detentore di una gerarchia
di valori che gli fanno riconoscere nell’antagonista, il capitano
Bellodi, odiato rappresentante del potere statale, la sigla del vero
uomo, tra l’accozzaglia dei mezzi uomini. degli ominicchi e dei
quaquaraqua che contaminano i valori della società civile e cariano le
istituzioni. Lo stesso giudice Giovanni Falcone, dopo l’intervista
concessa alla giornalista francese Marcelle Padovani, intitolata “Cose
di cosa nostra”, venne attaccato da ogni parte, per aver affermato che
non bisogna mai dimenticare che dietro il sospettato o il mafioso, c’è
un uomo verso cui bisogna portare rispetto, affermazione che si
trasformò in aperte e agguerrite aggressioni censorie, soprattutto dai
denigratori di sinistra che accusarono il giudice, dopo la frase
pronunciata sulle motivazioni del pentimento di Tommaso Buscetta e la
sua collaborazione con lo Stato, lo accusarono di essere “stregato”
dalla mafia. Anche Camilleri dichiara di “cercare l’uomo”, come si
evince da tale espressione, pronunciata in “La linea della Palma”. Ciò
è anche dimostrato dal modo di condurre le inchieste dal Commissario
Montalbano che preferisce indagare nella realtà interiore dei
personaggi e radiografare i meandri invisibili della loro umanità,
anziché ricorrere a strategie sociologiche. Perciò, in Montalbano la
mafia rimane sullo sfondo, senza invadere la scena, che è invasa da
uomini e donne, portatori di male e di bene, del bello e del brutto,
di miserabili pigmei, e di slanci spontanei di gioia, di serenità
familiare, di solidarietà e di Amore. In questo scenario esistono
anche i mafiosi, come i Sinagra e i Cuffaro con i loro clan, attorno a
cui ruota una società asfittica, imbelle, amante del quieto vivere da
cui trarre benefici e privilegi.
Per Montalbano il problema assoluto non è la mafia, ma ciascuno dei
due riconosce l’esistenza dell’altro, senza bellicosa militanza
antimafia. Prende atto dell’esistenza dei boss, come un segmento
importante, ma non l’unico della società. Per cui, la mafia di
Montalbano non è una organizzazione rigidamente strutturata, ma
mafiosità diffusa e condiziona la quotidianità dei personaggi. Non c’è
moralismo nei racconti camilleriani, ma la società siciliana è minata
da una carica comandata dall’interno che, come lo scrittore confessa a
Bonina, il massimo studioso di Camilleri, che non solo la mafia è
responsabile di tutti i mali della Sicilia. La mafia, dice Falcone,
potrebbe essere sconfitta, se non fosse ampliata la mentalità mafiosa,
cioè di quella cultura che afferma un modo di accettare il
capovolgimento delle regole del vivere civile. Sciascia, profondo
conoscitore del sistema di Cosa Nostra, osservava che i siciliani sono
afflitti nella coscienza da una patologia antica e radicata,
purtroppo, irredimibile, perché i siciliani, sempre oppressi e
torturati dal succedersi dei conquistatori dell’isola, hanno maturato
la consapevolezza di essere inchiodati ad un immutabile destino, per
cui si è cementata in loro la diffidenza verso gli amministratori
della loro esistenza, visti ,perciò, come istituzione ostile e sempre
posizionata in difesa dei potenti. Ciò ha alimentato una fiducia
incondizionata verso i paladini difensori e protettori dei deboli e
dei perseguitati. Infatti, i siciliani, nelle loro controversie o
tentativi di sopraffazione o nel rendere giustizia ad un offeso, o
nell’urgenza di conflitti tra famiglie, ricorrevano (anche oggi) ai
boss dei quartieri o dei piccoli paesi, che si impegnavano a
riequilibrare i rapporti e far restituire il “maltolto”, per cui,
grazie a queste intermediazioni tra frodato e frodatore, per il
difeso, il boss rimaneva un mafioso, ma un mafioso dal cuore
caritatevole. Il don Tano e il don Mariano di Sciascia non son molto
distanti e ciò deriva dal fatto che i due appartengono alla stessa
generazione della Sicilia contadina di Porto Empedocle e di Racalmuto.
Ma Sciascia, nell’esplorazione dei labirinti del fenomeno mafioso, si
lascia guidare dalla sua formazione illuministica. Camilleri, invece,
sviluppa un approccio psicanalitico (come osserva il critico Francesco
La Licata, nel 2° quaderno camilleriano.) e il raffinato critico
Bonina nell’introduzione al suo volume “Tutto Camilleri”, osserva:
“Sciascia spiega la Sicilia, Camilleri la racconta, ma entrambi
ritengono la Sicilia come metafora del mondo”. Camilleri conosce molto
bene i meccanismi della mafia e della mafiosità, quelle tecniche che
spingono i mafiosi ad agire ed i poveri disgraziati a sentirsi sicuri
e protetti. Egli ha seguito la degradazione del fenomeno criminale dei
Sinagra e dei Cuffaro fino a perdere il loro alone di “galantuomini” e
a osservarne il declino, di fronte ad una nuova generazione che si è
proposta come obiettivo del suo operare, la frenetica corsa
all’arricchimento immediato con ogni mezzo, dal sempre crescente
traffico e spaccio di ogni tipo di droga, alle stragi commissionate,
allo strozzinaggio, al traffico di organi umani espiantati da bambini
rapiti o da immigrati di ogni sesso ed età, anche sulle carrette del
mare , per mano degli spietati aguzzini criminali, e venduti a
conoscenti che ne avevano urgenza. Si capovolgeva, così, la maschera
tradizionale della mafia, detta “onorata società” in criminalità
organizzata con l’obiettivo del dio denaro, a costo di orrendi delitti
con l’obiettivo di accumulare ricchezza. La degenerazione è descritta
da Camilleri, senza eccessi di indignazione moralistica, anche nel
racconto de “La danza del gabbiano”, dove il giovane Franco Sinagra
consuma rapporti sessuali con un transessuale. Gesto esecrabile ed
impensabile nella mentalità della “vecchia” mafia che gli avrebbe
impedito qualunque corsa al comando. Camilleri racconta tale
spregevole trama sentimentale, sullo sfondo senza accensione di
riflettori e senza concedergli alcuna centralità alla scena. Ne “La
gita a Tindari”, Montalbano cerca e riesce ad avere un contatto con
Balduccio Sinagra, non per sporcarsi, ma per poter trarre vantaggi per
la sua inchiesta, giustificando tale contatto come una presa d’atto
dell’esistenza della realtà che comprende anche la mafia, con un
contorno di persone viscide che la sostengono , svolgendo il ruolo
assegnato dalla “famiglia” e di cui fanno parte, medici, liberi
professionisti, primari e compiti delicati nei rapporti con le
istituzioni o con importanti personaggi delle cosche internazionali
per affari di cifre vertiginose. Sulla linea del buonismo si muove
anche padre Crucillà, un prete misericordioso che sta vicino al
vecchio boss per alleviare i suoi rimorsi. Nel 1963 si consumò la
strage di Ciaculli (caddero sette militari), di fronte agli
atteggiamenti evasivi ed omertosi della chiesa palermitana, la chiesa
valdese prese una posizione dura verso la mafia, mentre il Cardinale
Ruffini, come riportarono i giornali del tempo, rispose che la mafia
non esisteva, se non nella ideologia dei social-comunisti. Ma
Camilleri ebbe modo di osservare personalmente il radicale cambiamento
della metodologia mafiosa, nel 1986, quando, mentre beveva un caffè,
si trovò testimone oculare di una strage, con sei morti nel bar del
suo paese. Tale episodio consolidò nello scrittore la certezza che tra
la vecchia e la nuova mafia tutto era cambiato a vantaggio della
nuova. Tale affermazione suscitò reazioni forti, con l’esecrazione
verso lo scrittore per l’inaccettabilità di affermazioni che furono
interpretati come apologia dell’organizzazione mafiosa. A sostegno
delle sue convinzioni, Camilleri fece osservare che la mafia antica
aveva un codice d’onore, anche se distorto. Un vecchio mafioso,
dovendo uccidere una persona a passeggio con la moglie per le vie di
Palermo avrebbe detto alla donna “Signora si sposti”. La nuova mafia
avrebbe ucciso tutte e due, come era avvenuto in tante occasioni. Lo
scrittore racconta di aver incontrato a Roma il boss Nick Gentile (che
chiama Nicola) e che, durante la conversazione, il boss gli disse che
il rispetto si ottiene con gli atteggiamenti corretti e non con la
intimidazione. Ne “Il birraio di Preston”, il funzionario statale,
proveniente dal Nord crede che il mafioso sia come un “bravo”
manzoniano che ostenta la sua posizione con gesti distruttivi, mentre
il vero mafioso è quello che non appare, ma che, in vece sua, fa
apparire, l’evidente è il legale rappresentante del mafioso vero.
Ancora Sciascia sosteneva che nella lotta alla mafia non bisogna mai
travalicare le regole, perché in quanto Stato, non può agire come la
mafia. Ma Montalbano utilizza anche il figlio di Adekina, la cameriera
dei famosi arancini e di pasta con le sarde, un ladruncolo che
fornisce a Montalbano notizie dal carcere e della piccola criminalità,
ma il Commissario non lo aiuta ad evitare la punizione per le
trasgressioni commesse, anzi lo accompagna in carcere per espiare il
debito con la giustizia. Montalbano non ama le pastoie del potere e
della burocrazia che spesso, per non avere rogne, crea situazioni
funzionali per eludere le proprie responsabilità. Salvo che è figlio
del ’68, è impegnato a ricercare la giustizia e la verità, perché non
si accontenta della verità, spesso precostituita dai burocrati che
evitano di effettuare ricerche approfondite nelle loro inchieste, per
paura di ritorsioni personali o contro la propria famiglia o contro i
loro beni. Montalbano rifiuta di accettare conclusioni superficiali o
apparenti, come si evince dalla storia raccontata ne “La forma
dell’acqua”, in cui si cerca di accreditare una verità solo apparente:
la morte di un notabile di partito che i colpevoli tentano di far
sembrare come conseguenza di un anomalo rapporto sessuale. Salvo
intuisce che la verità è rimasta occulta e quella orchestrata è solo
come la forma dell’acqua che un oggetto invisibile si riflette
apparentemente in essa. Ma le investigazioni del Commissario approdano
alla scoperta di un’altra più autentica verità, un losco intrigo tra
mafia e potere e l’impegno morale che lo induce, per l’affiorare di un
imprevedibile sentimento umanitario a premere la mano per far
racimolare ad un povero netturbino che ha ritrovato una preziosa
collana accanto al cadavere dell’ucciso, evidente prova di
riconoscimento dell’assassino, la somma necessaria al poverissimo
netturbino per far curare il figlio gravemente ammalato. Questo gesto
di generosità non scalfisce la statura etica del difensore della
legge, perché un’altra legge, profondamente incisa alle radici del
cuore umano, trasforma l’implacabile commissario fino a fargli
compiere un gesto di carità cristiana per salvare la vita di un
bambino, laddove l’assistenza dello Stato è latitante di fronte
all’incombere dello spettro della morte di una creatura innocente e
indifesa. Al suo fidato Fazio che lo apostrofa di essere diventato un
“Comunista”, il Commissario giustifica il suo gesto di rinuncia ai
principi dell’onestà, dicendo che “La collana non era stata rubata, ma
perduta e ritrovata”. Il Montalbano severo nutre ostinata avversione
verso i potenti e gli arroganti, mentre cerca di salvare la
credibilità delle istituzioni e “eretico”, quando tratta con senso di
rispetto uomini della vecchia mafia, come “Tanu u grecu”, che si trova
a disagio di fronte ai delitti insensati o alle stragi collettive,
senza distinzioni tra colpevoli e innocenti. Ormai vecchiu, convoca in
casa sua il Commissario per farsi arrestare, in quanto è disgustato di
fronte alla spietatezza e cecità sanguinaria della moderna
organizzazione criminale, per cui ritiene più opportuno essere
rinchiuso in un carcere, che assistere alle azioni delittuose di una
ignobile umanità che impregna il mondo di sangue, spesso in maniera
inopportuna. Don Tanu vuole essere arrestato da Montalbano, “perché fu
l’unico sbirro a dargli del lei e perché è uno che le cose le
capisce”. I rapporti di Montalbano con il potere non eran idilliaci,
perché, viste le manipolazioni messe in atto per coprire i delitti
pilotati, si fidava solo di se stesso. Ciò risulta evidente ne “Il
ladro di merendine”, quando arriva a ricorrere alle maniere forti con
un funzionario dei servizi segreti che pretende una verità di comodo
per proteggere il segreto e la ragion di Stato per salvare un
pericoloso terrorista. Il Commissario, allora, medita di preparare una
trappola al funzionario invitandolo a casa sua e con un registratore
fotocamera, registra l’intero colloquio con l’agente segreto. Alla
fine, con le prove in mano, ricatta l’agente con la richiesta di
recuperare una forte somma di denaro, da destinare al futuro del
piccolo Francois, rimasto orfano e di cui si occupa amorevolmente
Livia, la sua fidanzata. Montalbano esercita la sua professione con un
evidente rigore etico, ma è pronto sempre a proteggere la dignità e
l’incorruttibilità delle istituzioni, senza provocare scandali che
farebbero scattare il malcontento dell’opinione pubblico e la sfiducia
totale verso la legge. Quando i Sinagra ne “La voce del violino” gli
forniscono una videocassetta come prova di un depistaggio compiuto
dalla Questura, Salvo, con uno stratagemma riesce ad obbligare i
colleghi a ripristinare la verità, senza rendere pubblica la video
cassetta, salvando così l’incorruttibilità dell’istituzione.
Come si deduce dagli esempi riportati, si dimostra che la mafia è
presente nei racconti di Montalbano, anche se il poliziotto non si
comporta come eroe dell’antimafia, ma con profondo senso di
attaccamento al dovere, agisce concretamente in sordina, senza voler
suscitare polemiche o cercare gloria per il suo operato. Egli non
vuole incarnare il ruolo del bene che lotta contro il male assoluto.
La rivelazione più forte di una combattiva coscienza antimafia è
contenuta forse nel “giovane Montalbano”, trasmesso recentemente in
TV, In “Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano”,
dove il giovane Montalbano mostra una pressante esigenza di giustizia,
inculcata dall’educazione familiare ed esaltata al momento della
strage di Capaci,(1992) (che rappresentò la sfida della mafia allo
Stato o un atto dimostrativo per la sigla di un patto di pacifica
convivenza tra i due poteri) quando Salvo decide di rinunciare a
seguire Livia a Genova, per restare nella sua sanguinante Sicilia,
come presidio contro la barbarie della mafia moderna che tende ad
inserirsi nello Stato, attraverso compromessi con personaggi politici,
per trarne il maggiore profitto personale. Andrea non si sottrae alla
battaglia culturale e politica, si misura con i temi più scottanti
dell’antimafia moderna, fino all’era berlusconiana
INTRECCIO POLIZIESCO E LINGUAGGIO
L’intreccio poliziesco originale e caratterizzante la creazione. dei.
personaggi, di cui il più importante è il Commissario Montalbano,
protagonista di tanti racconti, che hanno riscosso un plebiscitario
consenso di pubblico, grazie alla novità delle caratteristiche umane e
professionali .dei protagonisti servitori dello Stato, molto diversi
da quelli di oggi, che usano altre tecniche investigative, nello
svolgimento delle inchieste, ben diverse da quelle prevalenti nei
poliziotti meno invasivi e più raziocinanti e intuitivi di quelli
odierni che hanno supporti determinanti nelle telecamere e in
strutture scientifiche, come quelle dell’analisi del DNA ed altre
apparecchiature sofisticate per arrivare con maggiore celerità alla
scoperta dei responsabili del crimine Né Camilleri ricorre alla
spettacolarizzazione del crimine,per evitare di impressionare o di
rafforzare e ampliare la tendenza alla radicazione del seme del
delitto , al male e al sadico e ancora più sanguinario operare
dell’uomo, già predisposto alla violenza. Lo scenario dentro cui si
svolgono le attività criminali e le investigazioni degli agenti di
pubblica sicurezza è la cittadina costiera di Vigata, in provincia di
Montelusa. Altri nomi inventati richiamano agli ambienti di Porto
Empedocle, città natale dello scrittore, e di Agrigento- I
collaboratori di Montalbano possiedono caratteristiche ben evidenti e
inconfondibili. Il vicecommissario Augello, soprannominato Mimì;
l’ispettore Fazio, un funzionario responsabile e dinamico,
apprezzabile per le sue intuizioni perspicaci e si rivela molto utile
con le sue osservazioni ai ragionamenti investigativi del Commissario.
L’agente Catarella che, con la sua preponderante tempestività
scoordinata, ma per lui ritenuta esemplare, suscita molta simpatia. E
infine, tra i protagonisti, Livia, l’eterna fidanzata di Montalbano,
che vive a Genova, ma nei momenti di difficoltà, è sempre vicina al
Commissario e, con il suo acuto ingegno, lo aiuta a risolvere i casi
più intrigati, con nitida razionalità, senza ricorrere a compromessi,
stando sempre da parte della legalità, ma è di una ammirevole
ricchezza umana, rimanendo sempre fedele a Montalbano immersa nelle
sue attività di servizio alla giustizia, ama la lettura e la buona
cucina, ma soprattutto, Camilleri ha sommessamente profuso nei
comportamenti responsabili e nella fedeltà amorosa della donna, il
senso più profondo del vero amore consapevole del suo ruolo di saldo
legame affettivo, sempre libero e fedele, pur nella lontananza e nei
disguidi e incomprensioni che la distanza potrebbe provocare. Il
linguaggio risulta una ben amalgamata commistione di lingua italiana e
di dialetto siciliano, ma non una pedissequa trascrizione del dialetto
basso dei siciliani, ma costituisce una vera reinvenzione linguistica,
perché il dialetto usato da Camilleri è quello arcaico che tende a
scomparire, lo scrittore le ha salvare dalla dispersione del tempo,
innestandole con scioltezza nel linguaggio usato dal mondo
piccolo-borghese. In tale forma di sperimentalismo, Camilleri si
rivela discepolo di Pirandello, imprimendo immediatezza alla pagina,
per una più veloce e maggiore espressività del dialetto sulla lingua,
e conferendo ai personaggi un più evidente segno di appartenenza alla
loro terra.
LA VUCCIRIA
I colori di Renato Guttuso e le parole di Andrea Camilleri. L’incontro
tra due grandi siciliani.
“Io, Agonzio Calandrino, cordaro, che ho bottega in una via della
piazza di grascia detta Bocceria Grande… trovatomi la matina dello
cinco settembriro de lo mille e seicento e cinco inanzi alla bottega
intento a certe cassette rassettare, vidi nel negotio de davanti a lo
mio ov’è vendita di panni per vestimenti e tela d’olona una giovine
femina assai di personale aitanza e opulentia nonché mirabile per
copia e lucidezza di chiome…” Così inizia il racconto di Andrea
Camilleri La ripetizione, direttamente ispirato al famoso quadro di
Renato Guttuso dedicato alla Vucciria, il più grande e più famoso
mercato di frutta e verdura, di pesci e di carne di Palermo. “Un
narratore o un commediografo, davanti alla Vucciria, avrebbero materia
di scrittura sino alla fine dei loro giorni,” scrive Camilleri nella
sua Nota. “La vucciria la conosco bene. Negli anni ’44-’47 frequentavo
l’università di Palermo e quasi ogni giorno mi ci recavo per mangiarmi
‘u panu cu ‘a meusa di cui ero ghiottissimo. … Era un luogo che apriva
la fantasia. Perché era un luogo dov’erano possibili accadimenti
impossibili altrove.” Il libro è completato da una prefazione di
Fabio Carapezza Guttuso che racconta come venne dipinto il quadro, la
sua simbologia, e la sua collocazione finale. Il volume è illustrato
dai numerosi particolari del quadro e da diverse fotografie scattate
dallo stesso Guttuso nel mercato come preparazione al dipinto.
Nota
di Andrea Camilleri
La Ripetizione è un racconto direttamente suggeritomi dalla Vucciria
di Guttuso. Il modo che mi è più congeniale per renderle omaggio.
Giuseppina Restivo nel suo Le Soglie del postmoderno: Finale di
partita (Bologna 1991) ha incontrovertibilmente dimostrato come
appunto il beckettiano Finale di partita riutilizzi le situazioni
visive e gli oggetti contenuti nell’incisione Melencolia 1 di Dürer.
Un narratore o un commediografo, davanti alla Vucciria, avrebbero
materia di scrittura sino alla fine dei loro giorni.La vucciria la
conosco bene. Negli anni ’44-’47 frequentavo l’università di Palermo e
quasi ogni giorno mi ci recavo per mangiarmi ‘u pani cu ‘a meusa di
cui ero ghiottissimo. E spesso la sera andavo alla mitica trattoria
Panarelli col solito gruppo d’amici, Marcello Carapezza, Leo Guida,
Giuseppe Ruggero, Angelo Musco jr. e altri. Era un luogo che apriva
la fantasia. Perché era un luogo dov’erano possibili accadimenti
impossibili altrove. Quando Guttuso fa lo scherzo di chiedere a
qualcuno che ha appena visto la sua grande tela quante persone vi
siano raffigurate, ottiene quasi sempre risposte sbagliate o incerte.
E non può essere altrimenti, perché Guttuso sa bene d’essere riuscito
a suggerire il fenomeno delle apparizioni-sparizioni che vi è (o vi
era) così consueto. Per esempio, se contate le figure umane centrali,
a partire dalla donna di spalle con i sacchetti di nylon in mano, di
primo acchito vi paiono essere sei. Invece sono sette. Del settimo,
che è appena passato sotto la lampara centrale, s’intravede solo la
testa con la coppola.
Sta scomparendo o sta comparendo? Nel 1944 c’era, nella vucciria, il
negozio privo d’insegna di don Jachino. Era una cameretta a pianoterra
di quattro metri per quattro, senza nemmeno una finestra, i cui muri
erano interamente ricoperti di ripiani di legno assolutamente vuoti.
Non una scatola, un barattolo, niente. C’era anche un minuscolo
bancone che sopra aveva solo un dito di polvere e basta.
Don Jachino se ne stava sempre seduto sopra una sedia di paglia
accanto alla porta. Che diavolo vendeva? Cominciai a essere sempre più
intrigato. Misi il negozio sotto stretta sorveglianza. Così ebbi modo
di notare che ogni tanto qualcuno s’avvicinava a don Jachino e,
chinandosi, gli sussurrava qualcosa. Don Jachino non rispondeva con
le parole, con la testa faceva cenno di no o di sì e quando diceva sì,
con le dita formava un numero, tre, cinque, sei… Finalmente ebbi
fortuna. Un giorno vidi ricomparire un signore al quale don Jachino,
tre giorni avanti, aveva risposto di sì mostrando tre dita. Appena lo
vide arrivare, don Jachino si alzò ed entrò nel negozio. Si chinò,
prese da dietro il bancone un grosso pacco e lo porse al signore. Il
quale, dopo aver deposto sul bancone dei biglietti di banca, messosi
sottobraccio il pacco, si voltò, fece un passo e sparì. Letteralmente.
Restio come sono a credere alla magia, approfittai che don Jachino
indugiava a contare i soldi per infilare la testa, per un attimo,
dentro al negozio. Nella parete di destra, invisibile dalla porta
esterna, c’era una strettissima apertura che immetteva in un’altra
stanza. Che era certamente dotata di un’uscita posteriore. A farla
breve, don Jachino vendeva refurtiva su commissione. Avevi bisogno di
una pendola funzionante stile Impero? Andavi da don Jachino e lui ti
diceva entro quanto tempo te l’avrebbe fatta trovare. Per precauzione,
faceva uscire i clienti da una porta diversa da quella dalla quale
erano entrati. Tornando al racconto, dirò che per esso mi sono avvalso
non solo della memoria e di una grande riproduzione gentilmente
fornitami da Fabio Carapezza Guttuso, ma anche di due momenti
preparatori compresi nel volume Renato Guttuso. La potenza
dell’Immagine, 1967-1987, a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Dora
Favatella Lo Cascio (Roma 2007). Nel primo, uno studio, l’uomo da me
chiamato Antonello ancora non vi compare; nell’altro, un bozzetto,
Antonello invece c’è ma diversamente vestito. Per la storia d’amore
rievocata attraverso l’Inquisizione, mi sono servito di
L’Inquisizione in Sicilia di Francesco Renda (Palermo 1997) e di
Inquisitori,negromanti e streghe nella Sicilia moderna di Maria Sofia
Messana (Palermo 2007).
Il testo del racconto è alla base dell’opera Il quadro nero ovvero La
Vucciria, il grande silenzio palermitano , ideata e diretta a Roberto
Andò e musicata da Marco Betta, andata in scena al Teatro Massimo di
Palermo il 7 febbraio 2015.
DOCUMENTO
Il compagno di viaggio (SINTESI)
Il testo presentato fa parte della raccolta “Un mese con Montalbano”
(1998),30 racconti gialli da leggersi uno al giorno. Si tratta di
crimini che il Commissario deve risolvere, compiuti per amore, per
mafia o per interesse. Qui lo vediamo in un viaggio indesiderato da
Palermo verso Roma, costretto a stare in uno scompartimento-letto con
un personaggio sconosciuto che se ne sta intabarrato in un lungo
cappotto e una borsa stretta sotto il braccio. Dal comportamento
strano dell’individuo, immobile e concentrato nei suoi pensieri, il
commissario che, viaggiava controvoglia, preferiva essere solo nello
scompartimento, perché aveva le sue abitudini che avrebbero potuto
infastidire chi c’era con lui nella cabina. Aspettò a lungo sul
marciapiedi affollato e quando arrivò il convoglio, i viaggiatori
salirono e presero posto negli scompartimenti assegnati. Anche
Montalbano, entrato nella sua cabina, sperò di rimanere solo, ma
subito entrò un viaggiatore sconosciuto, incartocciato in un cappotto
e con una borsa in mano. A Camilleri non sfuggiva nessun movimento
dello sconosciuto, ma per poter avere sott’occhio tutto, si andò a
stendere sul letto di sopra e finse di addormentarsi e gradualmente di
russare sempre più rumorosamente. Il compagno di viaggio, che già fin
dalla partenza piagnucolava immotivatamente, si tuffò sul suo letto,
continuando a versare lacrime. Quando si accertò che Montalbano era
sprofondato in un sonno profondo, incominciò ad uscire dalla grossa
borsa un mucchio di carte e le scagliò fuori dal finestrino, assieme
alla borsa. Mentre si sporgeva dal finestrino, il Commissario notò un
gonfiore nella tasca posteriore del viaggiatore, che tirò fuori dalla
tasca e scagliò lontano nel buio la pistola. Capì che era una pistola.
Vide sul pavimento una carta sospetta, la prese, la nascose nella
tasca e uscì nel corridoio per leggere sul foglio. Era una cartolina,
firmata da una certa Anna che diceva “Amore mio, ti amo”. Scesi alla
stazione, sul giornale, in prima pagina si parlava del delitto di una
Anna. Il commissario, mettendo insieme i tasselli, e capì che Anna era
il nome della moglie del compagno viaggiatore e che in realtà era
stata eliminata dal marito, perché da tempo lo tradiva. A tal punto,
tutte le osservazioni convergono e i gesti del ragioniere Urso,
l’eliminazione delle lettere, della valigetta, dell’arma da fuoco, il
pianto sempre singhiozzante, il sonno agitato, la rivelazione del
fatto di cronaca letto sul giornale tolgono a Montalbano ogni dubbio
sulla vera identità del compagno di viaggio. E, scendendo dl treno:
“Buona fortuna, ragioniere”, disse Montalbano. Il messaggio del
racconto rientra nel filone pessimistica della vita, ma i gesti del
compagno di viaggio possono essere la rivelazione del pentimento del
ragioniere nel filone pessimistico della letteratura e perciò lo
scrittore evidenzia la grande umanità del commissario che affida al
dolore alla disperazione, all’angoscia e al doloroso pentimento del
colpevole, l’espiazione della colpa.
DONNE, Rizzoli, Milano
Con questo volume di racconti, aventi come protagoniste 39 ritratti
femminili, cari alla sua vita pubblica, privata e letteraria, che sono
rimaste incise nella sua memoria sia per la loro bellezza corporale,
sia per la spirituale dimensione del loro livello etico e
intellettuale. Uno dei primi ritratti si intitola Carmela, una donna
elegiaca della sua prima giovinezza, memorabile per le sue lacrime di
diciannovenne. La rassegna continua con Angelica e Zina, una raccolta
di 39 medaglioni femminili più importanti della vita dell’autore, che
le dipinge con nitide pennellate di parole. Camilleri, con la solita
abilità comunicativa e con un inedito patrimonio sentimentale,
inimmaginabili nell’umoristico scrittore racconta ora la vita nel
volto più profondo della creatura umana, mostrandosi, non come uno
scrittore monolitico, ma nella razionale stesura, emergono i nuclei
tombali delle azioni umane e i legamenti possibili della storia. Dalle
eroine della mitologia classica, alle donne reali dell’infanzia che
hanno accompagnato il percorso più sereno e più turbolento, come Elena
di Troia e Giovanna d’Arco, ai ricordi di avventurose esperienze, il
giovane scrittore siciliano fa riemergere figure di donne, descritte
dallo scrittore sensibile alla bellezza femminile. Ma per Camilleri
l’amore non è solo stimolo carnale, ma traspira un soffio di
spiritualità, declinato con affetto e stima, particolarmente con le
donne di successo, ritratte con fervore verbale, seguendole nello
slancio di emancipazione e nella voglia di successo. Lo scrittore ci
offre un aspetto inedito di Antigone che il dolore spinge ad uccidere
e ad uccidersi: angelica nel corpo e nell’anima è più credibile e
appariscente di quella virtuale rappresentata dalla tradizione. Altre
donne legate allo scrittore fin dall’infanzia, che hanno ballato sulla
terrazza sul mare di Agrigento, o che passeggiavano per le vie di Roma
affamate, durante gli anni dell’aspirante regista. Con il nome di
Elvira, Camilleri ricorda la donna che lo seguì nella gestione di
Camilleri con sincera amicizia e la nonna, una creatura da fiaba che
vive in compagnia e parla con le galline. Un libro che rivela un
mucchio di contrasti e di saggezza, magistralmente scritte da
Camilleri che così rende omaggio agli aspetti più preziosi e segreti
dell’universo femminile.
Un diario del ‘43
Un diario del 1943 ritrovato e la confessione di un atto terribile
spingono Montalbano dentro un’indagine a ritroso nel tempo a caccia di
indizi nascosti tra ricordi, vecchie carte e documenti dell’epoca. Da
‘Un mese con Montalbano’, pubblicato nella collana «La memoria» nel
2017, il racconto “Un diario del ‘43” in versione ebook.
«Sono riuscito a portare qui e a nascondere quattro bombe a mano, di
quelle piccole, rosse e nere, che si chiamano Balilla. Duce, saprò
servirmene!». Poche righe, lette in un diario del 1943 ritrovato
all’interno di un grande silo di epoca fascista che sta per essere
demolito, mettono subito in moto la curiosità del commissario
Montalbano. Un quaderno ingiallito con Mussolini in alta uniforme in
copertina su cui Carlo Zanchi, quindici anni, annotava solo i fatti
più importanti. Fino all’ultima notazione: «10 ottobre. L’ho fatto.
Sono vivo. È stato terribile, tremendo. Non pensavo che… Dio mi
perdoni!». Cosa avrà commesso di tanto terrificante il ragazzo e
perché il quaderno era nascosto in un’intercapedine all’interno del
silo? Il sangue da «sbirro» di Montalbano inizia a scorrere
velocemente fino a spingerlo dentro un’indagine a ritroso nel tempo a
caccia di indizi nascosti nei ricordi di chi quel 10 ottobre del 1943
si trovava a Vigàta. Tra vecchie carte e documenti dell’epoca,
intuizioni personali e fatti di cronaca che inaspettatamente svelano
il tassello mancante, il commissario ripercorre il filo di
un’intricata matassa all’indietro fino a ritrovarne l’origine.
MARUZZA MUSUMECI
Una favola questo racconto di Camilleri, dove appaiono i nomi degli
antichi eroi come Ulisse e ilmito delle sirene, magiche protagoniste
che parlano e cantano citando gli antichi versi greci di Omero Gnazio
Manisco non voleva essere considerato come un pidocchio di cui Dio si
scordò al tempo dell’arca di Noè e che quindi si nascose con la sua
femmina tra i capelli del piblico patriarca. Dio s’è scordato anche
dei braccianti come lui ed allora Gnazio se ne va in America in cerca
di fortuna, anche se il viaggio per mare lo atterrisce. Tra lui e il
mare, quelle montagne liquide che possono affogarti, non c’è mai stata
confidenza. Lui è un uomo “terragno”, ama la solida terra che si
affretta a comprare con i dollari messi da parte quando torna a Vigata
il 3 gennaio del 1895 Gnazio fa rifiorire quella terra fertile ma
abbandonata e da bravo muratore si costruisce la sua casetta senza
neppure una finestra che abbia la vista sul mare da cui il suo terreno
dista poche centinaia di metri. Anzi alcuni gli hanno detto che
praticamente la sua terra galleggia sul mare, come un’isola, come
l’Itaca di Ulisse. Venuto il tempo di metter su famiglia Gnazio si
rivolge alla ‘gnà Pina, una sorta di maga guaritrice e sensale di
matrimoni che gli trova una bellissima quanto misteriosa giovane che
vive insieme alla sua vecchissima bisnonna Menica. Entrambe le donne,
nota Gnazio, hanno una voce incantatrice e cantano antiche canzoni in
una lingua sconosciuta. Il giorno dell’incontro, mentre le
donne si abbandonano al canto, è però segnato da un avvenimento
funesto: un vicino, Aulisse, che lavorava temporaneamente come
potatore nel campo di Gnazio, forse impazzito, si è gettato e affogato
in mare.
Le sirene, perché questo sono in realtà, si sono vendicate dell’eroe
omerico che le offese ai tempi degli antichi dei, ma ora sono uscite
dal mare e vogliono vivere con gli uomini e procreare una nuova
stirpe. Gnazio, uomo di terra, sarà quindi con i suoi figli il tramite
tra il cielo e il mare. Il primogenito Cola che ama le stelle, diverrà
un grande astronomo mentre Resina – nome che è l’anagramma di Sirena –
la sua amatissima, inseparabile sorella vive amando il mare al quale
rivolge le sue fascinose canzoni. Cola andrà ad insegnare in una
università americana ma quando, scoppiata la seconda guerra mondiale,
decide di tornare a Vigata la sua nave affonda ed egli finirà in una
grotta sottomarina situata in una campana d’aria dove lo raggiungerà
la sua sorella marina.
Le sirene sono ormai in pace con gli uomini e non uccidono più i
marinai naufraghi come accade per il moderno naufrago della guerra, il
soldato americano che ferito muore nell’isola-campo di Gnazio
consolato dal canto di sirene.
MIRACOLI A TRIESTE
Si può essere sbirri di nascita, avere nel sangue l’istinto della
caccia, come lo chiama Dashiell Hammet, e contemporaneamente coltivare
buone, talvolta raffinate letture? Salvo Montalbano lo era e, se
qualcuno gli rivolgeva stupito la domanda, non rispondeva. Una volta
sola, ch’era particolarmente-d’umore-nìvuro,rispose-malamente-all’interlocutore:
«Si documenti prima di parlare. Lei lo sa chi era Antonio Pizzuto?»
«No.»
«Era uno che aveva fatto carriera nella polizia, questore, capo
dell’Interpol. Di nascosto traduceva filosofi tedeschi e classici
greci. A settant’anni e passa, andato in pensione, cominciò a
scrivere. E diventò il più grande scrittore d’avanguardia che noi
abbiamo avuto. Era siciliano.»
L’altro-ammutolì.-E-Montalbano-seguitò.
«E dato che ci siamo, le vorrei dire una mia convinzione. Leonardo
Sciascia, se invece di fare il maestro elementare avesse fatto un
concorso nella polizia, sarebbe diventato meglio di Maigret e di Pepe
Carvalho messi assieme.»
E poiché era fatto così, appena sceso dalla vettura-letto che l’aveva
portato a Trieste, una poesia di Virgilio Giotti, in dialetto,
principiò a risonargli dintra. Ma subito la scacciò dalla mente: qui,
nei luoghi stessi dov’era nata, la sua dizione pesantemente sicula
sarebbe parsa un’offìsa se non un sacrilegio.
Era una matinata di prim’ora, tersa, chiara, e lui, che pativa di
cangiamenti d’umore a seconda di come svariava la giornata, si augurò
di poter restare sino a sira con lo stesso stato d’animo di quel
momento, benevolmente aperto a ogni situazione, a ogni
incontro.Percorsa la banchina affollata, trasì nell’atrio, si fermò ad
accattare “Il Piccolo”. Cercò invano nella sacchetta ch’era vacante di
monete, e nel portafoglio aveva solo biglietti da cinquanta e da
centomila lire. Ne pruì uno da cinquanta con scarse speranze.«No gho
da darghe spici» fece infatti l’edicolant«Manco io» disse Montalbano,
e s’allontanò.Subito però tornò indietro, aveva trovato la soluzione.
Al giornale aggiunse due romanzi gialli scelti a caso e l’edicolante
stavolta gli diede trentacinquemila lire di resto che il commissario
infilò nella sacchetta destra dei pantaloni, non avendo gana di
ritirare fora il portafoglio. Si avviò verso il posteggio dei taxi,
mentre ora irresistibilmente, dintra alla sua testa, Saba si era messo
a cantare, con quella sua voce che aveva sentito alla televisione:
“Trieste ha una scontrosagrazia. Se piace è come un ragazzaccio aspro
e voracecon gli occhi azzurri e-mani-troppo-grandi…”
Le mani che all’improvviso gli artigliarono la giacca all’altezza del
petto non erano quelle di un ragazzaccio, appartenevano a un
cinquantino con gli occhiali, dall’ariata per niente aspra e vorace,
vestito con cura. Il cinquantino aveva truppicàto, se non si fosse
istintivamente aggrappato a Montalbano e se il commissario,
altrettanto istintivamente, non l’avesse sorretto, sarebbe andato a
finire lungo disteso a terra.
«Mi-scusi-tanto,sono-inciampato»
Fece-l’omo-virgognoso.
«Ma le pare!» disse il commissario.
L’omo si allontanò e Montalbano, oramai fora dalla stazione,
s’avvicinò al taxi di testa, fece per raprìre lo sportello e in quel
preciso momento si rese conto, misteriosamente, che non aveva più il
portafoglio.
«Ma-come?»
s’indignò.Questo era il benvenuto che gli dava una città che aveva sempre amato?
«Si decide o no?» spiò il tassinaro al commissario che aveva aperto la
portiera, l’aveva richiusa e ora la stava nuovamente aprendo.
«Senta, mi faccia un favore. Porti questa valigia e questi libri al
Jolly. Mi chiamo Montalbano, ho prenotato una camera. Io verrò dopo,
ho un’altra cosa da fare. Ventimila bastano?»
«Bastano»
fece il tassinaro che partì subito, dato che il Jolly era a due passi,
ma Montalbano non lo sapeva.Taliò il taxi finché sparve alla sua vista
e subito gli nacque un cattivo pinsèro.
«Il numero di targa non pigliai.”
Gli era venuta una botta di diffidenza, di arrifardiamento.L’omo che
gli aveva arrubato il portafoglio certamente doveva trovarsi ancora
nei paraggi. Perse una mezzorata a taliàre e a ritaliàre dintra alla
stazione e a mano a mano ci perdeva le speranze. Che gli tornarono di
colpo quando, uscito su piazza della Libertà, rivide il borseggiatore
che camminava a zigzag tra le macchine di un posteggio. Aveva appena
finito di fare la stessa sceneggiata con un signore imponente, bianchi
capelli al vento, il quale, ignaro d’essere stato alleggerito,
continuò a procedere verso la Galleria d’arte antica, maestosamente
taliàndo tutti dall’dall’alto.Il borseggiatore era sparito di nuovo. Poco
dopo a Montalbano parse di scorgerlo, si dirigeva verso corso
Cavour.Può un commissario di polizia mettersi a correre appresso a uno
gridando “al ladro, al ladro”? No, non può. L’unica era di accelerare
il passo, tentare di raggiungerlo.Un semaforo rosso bloccò Montalbano.
Ebbe così modo d’assistere, impotente, a un’altra esibizione del
borseggiatore: questa volta la vittima era un sissantino,
elegantissimo, pareva Chaplin nella pellicola Un re a New York. Il
commissario non poté fare a meno di ammirare la magistrale bravura del
ladro, nel suo campo un vero artista. Ma intanto dov’era andato a
finire? Sorpassò il suo albergo, arrivò sino all’altezza del Teatro
Verdi e qui si perse d’animo. Era inutile continuare la ricerca. E poi
in quale direzione? Chi gli assicurava che il borseggiatore non avesse
già imboccato una strada qualsiasi tra tutte quelle che si partivano
da piazza Duca degli Abruzzi o da Riva III novembre? Lentamente tornò
indietro.Trieste seppe cangiargli l’inseguimento d’andata in una
tranquilla, ariosa, passeggiata di ritorno. Si godé tutto l’odore
denso e forte dell’Adriatico, tanto diverso da quello del mare della
sua terra.La sua valigia era già stata portata in càmmara, spiegò in
portineria che il documento di riconoscimento l’avrebbe dato dopo.Per
prima cosa telefonò alla questura, spiò del commissario Protti, suo
amico di sempre.
«Montalbano sono.»
«Ciao, come stai? Sei in anticipo, il convegno inizia alle quindici.
Vieni a pranzo con me? Ti passo a prendere al Jolly, d’accordo?»
«Sì, ti ringrazio. Senti, ti devo dire una cosa, ma se ti metti a
ridere giuro che vengo lì e ti spacco la faccia.»
«Che ti è successo?»
«Sono stato derubato. Il portafoglio. Alla stazione.»
Dovette aspettare cinque minuti col telefono in mano, il tempo che
Protti riemergesse dalla risata sconquassante nella quale aveva
rischiato d’annegare.
«Scusami, ma non ce l’ho fatta. Hai bisogno di moneta?»
«Me li dai quando ci vediamo. Cerca di darmi una mano coi tuoi
colleghi a ritrovare almeno i documenti, sai, la patente, il bancomat,
la tessera del Ministero…»
Mentre la risata di Protti ricominciava, Montalbano riattaccò, si
spogliò, si mise sotto la doccia, si rivestì, fece una lunga
telefonata a Mimì Augello, il suo vice di Vigàta, e un’altra a Livia,
la sua donna, a Boccadasse, Genova.Quando scese nella hall, il
portiere lo chiamò e il commissario s’infuscò. Quello sicuramente
voleva i documenti, lì non si poteva sgarrare, quelli, in quanto a
rispetto delle regole, erano fermi ai tempi di Cecco Beppe. Che
minchiata poteva contargli per guadagnare tempo?
«Dottor-Montalbano,hanno-portato-questa-busta-per-lei.»
Era una busta grande, telata, col suo nome scritto a stampatello. Era
stata recapitata a mano, non c’era mittente. La raprì. Dintra c’era il
portafoglio. E dintra il portafoglio c’era tutto quello che lui ci
aveva messo, patente, bancomat, tesserino, cinquecentocinquantamila
lire, non mancava un centesimo. Che miracolo era? Che veniva a
significare? Come aveva fatto il borseggiatore pentito a sapere in
quale albergo abitava? L’unica spiegazione possibile era che il ladro,
capendo d’essere seguito, si fosse ammucciato e quindi avesse a sua
volta pedinato il derubato sino all’albergo. Ma perché si era pentito
del suo gesto? Forse si era accorto, taliàndo i documenti, che il
derubato era uno sbirro e si era pigliato di spavento? Ma via! Non
reggeva. La prima cosa che Protti gli spiò fu: «Me la racconti meglio
questa storia del portafoglio?»Evidentemente il garruso voleva
scialarsela ancora tanticchia, aveva gana d’altre risate.
«Ah, scusami, dovevo telefonarti subito, ma mi hanno chiamato da
Vigàta e m’è passato di mente. La tasca della giacca era scucita e il
portafoglio m’è scivolato all’interno della fodera. Falso allarme.»
Protti lo taliò dubitativo, ma non disse niente. Nel ristorante dove
l’amico lo portò, servivano solo pesce. Si fece un piatto di
tagliolini all’astice e per secondo pigliò guatti sfilettati che
difficilmente si trovano. Per mandare giù quella grazia di Dio, Protti
gli consigliò un terrano del Carso, prodotto sulle colline alle spalle
di Trieste. Al convegno erano presenti un trecento poliziotti di
tutt’Italia. Invitato ad assittarsi sul palco, il commissario, macari
per contrastare la gran botta di sonno che l’aveva assugliato dopo la
mangiata, cominciò a taliàre a uno a uno quelli che stavano in platea,
tutti col tesserino appuntato sul risvolto della giacchetta, alla
cerca di una faccia conosciuta. E la trovò, infatti, una faccia che
aveva visto per pochi secondi, ma che gli era rimasta impressa.
Montalbano sentì lungo la spina dorsale una specie di scossa
elettrica: era il borseggiatore, non c’era dubbio. Era il
borseggiatore, un malvivente che si era pigliato il gusto di fingersi
sbirro, con tanto di tesserino bene in vista (a chi l’aveva fottuto,
Madonna santa?), che ricambiava la sua taliàta e gli stava sorridendo.
Può un commissario, a un convegno di poliziotti, saltare giù dal palco
e agguantare uno che tutti credono un collega, gridando che è un
ladro?
No, non può. Sempre taliàndolo fisso, sempre sorridendo, il ladro si
levò gli occhiali e contorse la faccia in una comica smorfia. E allora
Montalbano lo riconobbe. Genuardi! Impossibile sbagliarsi, era proprio
Totuccio Genuardi, un suo compagno di ginnasio, quello che faceva
ridere la classe, ce n’è sempre uno. Già fin d’allora abilissimo con
le sue mani di velluto: una volta aveva sfilato il portafoglio al
preside e tutti erano andati a farsi uno schiticchio in una taverna.
E adesso, che fare? Quando finalmente venne dato l’intervallo-caffè,
fece per scendere dal palco ma venne fermato da un collega che gli
sottopose un delicato problema sindacale. Se ne liberò prima che poté,
ma Totuccio era scomparso. Cercò e cercò e finalmente lo vide. Lo vide
e aggelò. Totuccio aveva appena portato a termine la sua solita
sceneggiata col questore Di Salvo e si stava scusando, fintamente
imbarazzato. Il questore, che era notoriamente un gran signore, gli
batté per conforto una mano sulla spalla e gli raprì lui stesso la
porta per farlo nèsciri. Totuccio gli sorrise, gli fece un mezzo
inchino di ringrazio, uscì, si perse tra la gente.
Andrea Camilleri
CONVERSAZIONE SU TIRESIA
Andrea Camilleri sceglie Tiresia e quel che di questo personaggio ci
ha trasmesso la letteratura, la filosofia, la poesia, e lo elegge a
pretesto – come già fece Borges con molti dei suoi temi prediletti –
per investigare un pensiero da cui estrarre tracce, o prove, della sua
vita precedente. Le infinite manipolazioni subite da questa
straordinaria figura attraverso epoche e generi, costituiscono per
Camilleri uno specchio in cui riflettersi, e attraverso cui rileggere
il senso ultimo dell’invenzione letteraria. L’indovino che compare
nell’Odissea, il profeta reso cieco da Giunone (o da Atena?) punito
perché rivelava i segreti degli dei, è il protagonista di una
conversazione solitaria nel corso della quale il più grande scrittore
italiano, meditando ad alta voce sulla cecità e sul tempo, sulla
memoria e sulla profezia, parla di sé e del suo viaggio nella vita e
nella Storia. Partendo dall’Odissea di Omero, Camilleri-Tiresia espone
la sua storia, gli avvenimenti importanti della sua vita che furono
narrati dai più grandi letterati di sempre. Da Sofocle a Virginia
Woolf, da Ezra Pound a Seneca, passando per Dante Alighieri, Guillaume
Apollinaire e Primo Levi. Tiresia. Colui che fu tramutato in donna e
poi di nuovo in uomo. Colui che ebbe modo di sperimentare il piacere
di entrambi i sessi e che fu quindi chiamato da Era e Zeus per
decidere chi fra l’uomo e la donna provasse più piacere. Non
soddisfatta della risposta Era lo rese cieco e Zeus per ricompensarlo
gli diede la facoltà di prevedere il futuro. Cieco come lo stesso
Camilleri che dichiara: “Da quando non ci vedo più vedo le cose assai
più chiaramente”. Attraverso le parole dello scrittore lo spettatore
ha modo di ripercorrere il modo in cui poeti, drammaturghi, scrittori
e registi si sono appropriati del personaggio di Tiresia e lo hanno
manipolato e rielaborato. Un viaggio appassionante accompagnato a più
riprese dal flauto di Roberto Fabbriciani. Il tutto ambientato nel
Teatro greco di Siracusa, luogo in cui venivano rappresentati i più
importanti drammi classici. Prodotto da Palomar, con la regia teatrale
di Roberto Andò e la regia televisiva di Stefano Vicario,
Conversazione su Tiresia. Di e con Andrea Camilleri sarà proiettato
nelle sale italiane il 5, 6 e 7 novembre.
L’autodifesa di Caino
La stagione estiva di Caracalla 2019 si arricchisce di un nuovo Extra.
L’Autodifesa di Caino scritta da Andrea Camilleri sarà raccontata
lunedì 15 luglio 2019 dall’autore, che per la prima volta sarà
presente nello scenario delle antiche Terme. Lo spettacolo avrà la
regia di Stefano Vicario e le musiche originali di Roberto Fabbriciani
eseguite dall’autore. Il progetto è curato da Valentina Alferj. Andrea
Camilleri, il più celebre scrittore italiano, torna dunque sul palco
per raccontare la storia di Caino, del primo assassino sulla faccia
della Terra, di colui che è diventato l’emblema del Male.
“Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a
raccontare storie e alla fine del mio ‘cunto’, passare tra il pubblico
con la coppola in mano”.
Camilleri ha sempre definito la sua ambizione di scrittore simile a
quella del contastorie, del poeta ambulante che con la sua capacità
affabulatoria incanta e seduce chi lo ascolta. E grazie alla sua
capacità di narrare storie Camilleri è diventato il più letto
scrittore italiano, inventando una lingua e mettendo in condizione i
suoi lettori di comprenderla, di parlarla, di amarla. A novantatré
anni, dopo il successo di Conversazione su Tiresia, Camilleri torna a
raccontarci in prima persona la storia di Caino e del come e perché
uccise suo fratello Abele. Un racconto che si avvale molto di testi
ebraici e musulmani, discostandosi perciò dalla tradizione cattolica.
Camilleri svela alcuni aspetti inediti del personaggio biblico: Caino
è stato il fondatore di quella che è oggi la Civiltà dell’Uomo nei
suoi aspetti non solo sociali ma anche artistici. Un viaggio
attraverso la Voce di Camilleri, una voce che proviene dall’antro
della Storia e che modula il racconto sconfinando nel tempo. “Io fui
semplicemente colui che mise per primo in atto il male. Che compì
l’azione del male. Tramutando ciò che era in potenza, in atto”.
Invito in scena con delitto
Perché-Camilleri-torna-a-teatro?
«Perché sono un contastorie. In fondo non sono mai stato altro».
L’anno scorso il monologo sul greco Tiresia, adesso sul biblico Caino,
il prototipo di tutti gli omicidi, un po’ il patrono di voi giallisti.
Lei lo riabilita.
«Nella tradizione ebraica, e in parte anche in quella musulmana,
esistono una miriade di controstorie che ci raccontano un Caino molto
diverso da quello della Bibbia. Su queste abbiamo lavorato».
Che-dicono?
«Per esempio che né lui né Abele sarebbero figli di Adamo ed’Eva».
E di chi allora? «Abele dell’unione tra la donna e un arcangelo, Caino
di quella tra lei e un demonio. Se ne ricava che l’infedeltà coniugale
nacque contestualmente alla prima e unica coppia del-mondo».
Vatti-a-fidare.
«Non solo. In alcune di quelle antiche narrazioni lo scontro tra i due
fratelli ne rovescia in qualche modo le posizioni rispetto al testo
biblico. Quando vengono alle mani, Abele, che è il più grosso, sta per
sopraffare Caino che per la prima volta nella storia dell’umanità
legge negli occhi del fratello l’intenzione di uccidere». Poi però
avviene un ribaltamento. «Sì, ma uccidendo Abele, è come se Caino
dicesse: se l’avessi lasciato fare sarebbe stato lui e non io il primo
assassino dell’umanità». Facendolo fuori lo salva dall’empietà
dell’omicidio. «E lascia aperto un dubbio: forse non ero io quello
condannato al Male in quanto figlio del demonio e lui quello destinato
al Bene perché generato da un angelo. Viene fuori così la visione di
un Male che non è legato alle nostre origini come una maledizione, ma
è una nostra scelta». Pure Caino è stato un grande
incompreso.Il-processo-va-rifatto.
«C’è tutta una parte del mito che è affascinante, ma totalmente
ignorata. È quella del Caino fondatore di città, inventore dei pesi e
delle misure, della lavorazione del ferro… Ma soprattutto quella di
Caino inventore della musica. Il Caino che dice: “Ecco io so, ne sono
sicuro, che davanti a Dio l’avere inventato la musica è valso più di
ogni sincero pentimento”».
Però una volta lei ha detto: «Sono convinto che gli assassini e in
genere i delinquenti siano sostanzialmente degli imbecilli».
Ribadisce? «Assolutamente. Chi crede al delitto perfetto che cos’è se
non un imbecille? Una minima cretinata lo tradirà. E del resto a che
cosa porta il delitto? A nulla. Hai solo momentaneamente eliminato un
ostacolo. A meno di non adottare il principio staliniano secondo il
quale ogni uomo è un problema ed eliminato lui, eliminato il problema.
Era un’idea a suo modo visionaria (risata). Solo che comporta morti a
milioni».
Da regista, lei ha lasciato il teatro negli anni 70. Che effetto le fa
tornarci adesso da attore? «Sono in tensione, ma relativa. È tale e
tanto l’afflusso dell’adrenalina che non soffro più né il caldo né il
freddo».