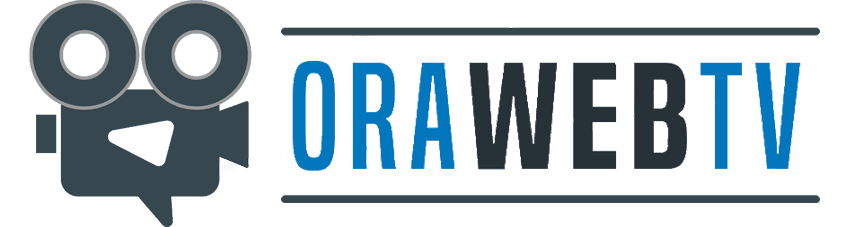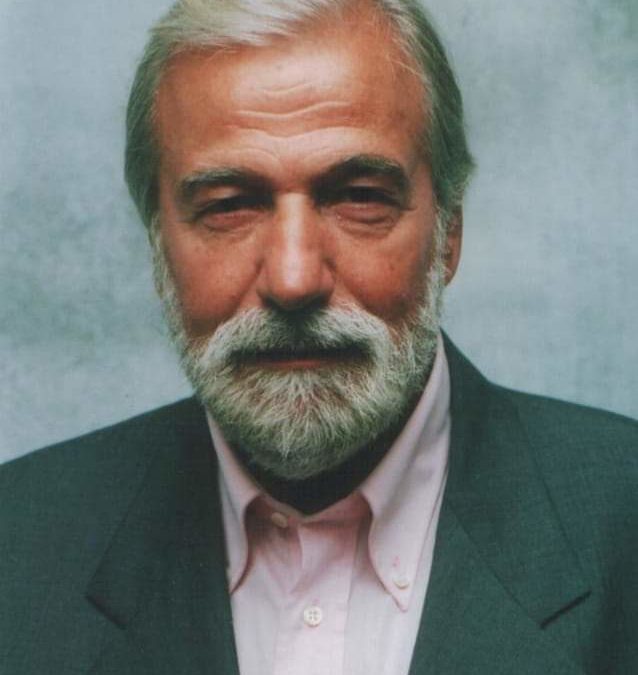Riceviamo dal Prof. Carmelo Aliberti e pubblichiamo integralmente un ritratto sulla figura di Sebastiano Saglimbeni, un grande siciliano, originario di Limina, cantore della civiltà agropastorale della nostra terra, educatore e docente al V. Madia di Barcellona, che dopo la Laurea in Lettere, si trasferì al Nord per insegnare. Fondò la Rivista MONDO NUOVSSIMO a BOLZANO e la casa editrice IL PANIERE a Verona, che pubblicò alcuni volumi di poesia dell’amico barcellonese Cosimo Pirri.
L’esordio poetico di Sebastiano Saglimbeni risale al 1950, quando
aveva appena conseguito la Licenza ginnasiale, al suo paese nativo,
Limina, una comunità nella provincia di Messina, sopra il versante
Ionio, allora di circa tremila anime.Un esordio di versi endecasillabi
e settenari, mai editi, ma che circolavano, scritti con la penna ad
inchiostro o con la matita, tra i compagni, pure autori di versi.
L’influenza arrivava un po’ dai canti popolari, un po’ dalle letture
dei poeti, dei quali si apprendevano a memoria alcuni dei loro
testi.Passeranno alcuni anni e Saglimbeni si stabilirà a Messina, dove
proseguirà gli studi per la Laurea in Materie Letterarie.
Contemporaneamente lavora come educatore all’Istituto “A. Cappellini”
della città dello Stretto. La città vantava sin dalla fine
dell’Ottocento un proliferare di periodici, di varia cultura. Alcuni
duravano a lungo, altri chiudevano battenti in breve tempo. Nel 1958,
l’insegnante di Lettere Antonio Migliardo aveva fondato il periodico
di letteratura “Eco”, dopo l’esperienza di un altro, sfortunato, dal
titolo “Selene”. Su “Eco”, Saglimbeni pubblica due sonetti nel
dialetto del suo paese, dedicati ad un amico e parente. Il tono è
classico, l’ispirazione è virgiliana, quasi ricalcata sui primi
esametri della prima egloga. Così, in uno dei due sonetti, l’esordio
edito di Saglimbeni che poetava:
Tu, caru Giuvanninu, stinnicchiatu
ti stai all’umbra di li nuciddari,
gudennu la friscura e sii biatu
cu li sacchetti chini di dinari.
Seguono altre collaborazioni al periodico con testi in lingua. Ma ci
muoviamo nell’ambito di un esercizio della scrittura poetica di
Saglimbeni, che nel 1961, alcuni mesi prima della laurea che
conseguirà a Palermo, pubblica con la casa editrice musicale di
Ancona, Farfisa, una silloge di versi dal titolo E non ho pianto. Qui
il lirismo risulta accentuato e qualche testo accattivante viene
scelto in antologie scolastiche di un certo rilievo.
Da allora l’itinerario creativo si va intensificando nel nord del
Veneto, dove Saglimbeni si trasferisce ed insegna, con la
pubblicazione di altri titoli poetici e prosastici. Giovanni
Occhipinti nel suo saggio P(r)o(f)eti dell’Isolamondo compie una
puntuale lettura della poetica di Saglimbeni (non tralasciando di
accennare alle prose de I Domineddio, de La ferita del Nord, di
Portellarossa e della commedia in tre atti Le vergini sono in
vetrina). Il saggista, a proposito della silloge E non ho pianto, si
esprime così: (…) Siamo insomma alla preistoria della poesia di
Saglimbeni, poeta, con molti altri dell’area messinese, della “
diaspora”. Il lirismo, in questo primo tempo, non è che la misura di
uno strazio esistenziale e della necessità di inseguire sensazioni e
percepirsi nei ricordi a verifica che si esiste ancora o che da
qualche parte si è esistiti… è insomma un momento del ritorno, pur
attraverso le illusioni degli affetti, alle presenze care e perdute,
ma anche alla storia o di un luogo-microcosmo ancora generoso,
nonostante tutto, di elementi vitali per una biografia interiore e
dell’anima ove attenuare l’angoscia di una condizione esistenziale
talora insostenibile: “ non ho detto ad altri / che dormono sui letti
bambagia/ le mie angosce/ per chiedere la mano…” (E non ho pianto).
Ma si dovrà giungere a I martiri hanno l’acqua in bocca, le poesie
scritte tra il ’61 e il ’64 e pubblicate nel ’65, per scoprire un
poeta la cui pacata e sicura forza interiore proprio di chi ha molto
cari gli ideali e in odio profondo i compromessi. La storia è già
presente, in questo libro, nei delitti e nella nera miseria della
guerra, ma l’attenzione è l’assillo del poeta sono rivolti al culto di
una vivissima religio larica che egli può custodire solo dall’interno
di una tradizione contadina mai rinnegata e anzi rigorosamente
custodita per tramandare ogni umore come qui, in Morte subitanea, dove
egli non rinuncia neanche a certe espressioni della parlata siciliana:
“ Tua madre contadina accolse la malanova/ sulle colline del tuo
paese: guidava le mucche nell’aia/ e stramazzò gridando/ ed atterrì le
bestie”. Ma è anche manifesto qui il disegno del poeta di tenere viva
la spiritualità della gente di Limina, quella antiavvento dei
mass-media che operarono ed operano irreversibili processi di
livellamento linguistico, a quei tempi ancora ricca di colore e di
tradizioni: intendiamo l’epoca in cui, nel microcosmo liminese, non
ancora appunto profanato dai mezzi di comunicazione, le parole avevano
dentro l’anima dell’uomo e non, come oggi, la fredda “malizia” delle
macchine; quando avevano dentro il potere e la forza della
sapienzialità della gente di campagna e non la beffa non l’astuzia non
l’inganno del consumismo; quando avevano ancora dentro l’amore per la
sopravvivenza della specie umana e non l’odio dell’oppressione e della
distruzione. Saglimbeni sente questo preciso dovere morale di serbare
per sé e per la sua gente ancora angoli edenici come per un’ultima
speranza di sopravvivenza: “… le tue vecchie/ sedute sopra scanni di
agavi/ dentro scialli antracite/ e vesti color d’erba/ di calamo fino
(…)// Miste ad onde di lana/ filavano le stoppe/ e davano occhiate/
smarrite al loro mondo/ che finiva all’orizzonte/ d’una croce greca/
del vecchio campanile” “Antica Limina”. La campagna, la natura sono
sempre partecipi della vita dell’uomo: sono l’immancabile scenario
dove afflitti protagonisti del dolore e dell’esistenza sfilano e si
dissolvono lungo gli itinerari di lontane mete: sono i personaggi
della “diaspora” che vanno con la disperazione nel cuore ma anche con
l’idea fissa e l’ansia segreta del ritorno, del nostos: “ Fatemi
andare. Prenderò/ un ramoscello di gelsomino/ che metterò
all’occhiello/ della mia vecchia giacca di poeta” (Sarò un disertore
della mia terra): motivo quasimodiano che tornerà più tardi,
diversamente e più incisivamente espresso in “Catàbasi e lezione
d’umiltà”. Ma dove meglio si apprezza l’originalità del poeta, vuoi
per le nuove acquisite capacità di invenzione vuoi per l’abilità di
manovrare e dirigere la scrittura poetica, e in “Resistenza alla terra
gibbosa”, il libro pubblicato nel ’69, scritto dal ’65 al ’68 e che,
tratteggia con molta efficacia la fisionomia di questo primo tempo di
Saglimbeni, ponendosi come conclusione di un ciclo e preludio di una
nuova e più significativa epoca della sua poesia, nella quale però
persistono, sia pure su altri più complessi e notevoli registri, quei
motivi e temi di sempre. Di questo libro colpisce, specie nella parte
introduttiva, l’andamento narrativo tipico del racconto biblico, nel
quale è tentata, attraverso l’oggettivazione dei personaggi – si badi
alla figura alquanto suggestiva di patriarca -profeta – una sorta di
genesi ironica e amara e perciò inconclusa, o, se vogliamo,
l’antigenesi di una famiglia, che per esteso è la grande famiglia
degli uomini dediti alla terra, e che alla fine deve fare i conti col
solito antieden e con la solita sorte malavogliana (ma anche
ebraico-biblica) che conduce inevitabilmente alla diaspora e quindi
alla contemplazione del nostos: alla nostalgia! Ecco, è qui la spinta
emotivo-esistenziale primaria che muove tutta la poesia di Saglimbeni.
La cui “ anarchia” non è che ricerca irritata e delusa per l’
“assenza” appunto del Deus absconditus; non è, come già appare sin
dalle prime battute, che fervore deluso ma non per questo sconfitto.
Si comprendono allora l’umanissima rivolta del poeta, però con tutto
il rispetto per la storia di Cristo, o certe impennate e sfuriate
contro la trascendenza ridotta alla stregua di un dio della terra, a
divinità campagnola che in effetti non esiste se non nel credo di una
religione semplicistica e naturalistico-contadina che tuttavia ha il
merito, legata alla credenza quasi infantile dei premi e dei castighi,
di legarci ancora al Dio nascosto. Ma in tutto questo si coglie anche
il presentimento e la pena per l’esodo dalla campagna favorito dal
miraggio del miracolo economico e dalle agevolazioni alle industrie
del Nord a discapito dell’agricoltura del Sud.
Si comprende perciò perché protagonista di questa poesia è la terra
(nel senso soprattutto di luogo di origine) con tutto ciò che di
autentico resta all’uomo. Nostalgie. Affetti, traumi, fatiche,
umiliazioni, fame qui scorrono sul filo di ininterrotte e discrete
reminiscenze che bene si adeguano alla semplicità di un dettato che sa
finalmente scuotere l’intelligenza del lettore: e in queste
reminiscenze le stagioni della campagna non sono che le stesse
stagioni dell’uomo, eroe “ della terra gibbosa ”. Sempre cara
tuttavia, anche dopo la fuga al Nord.
La corda sempre tesa dell’ironia diviene allora sintomo di un processo
di adattamento. Di ora in avanti la poesia di Saglimbeni, sino al più
recente “Catàbasi e lezione di umiltà” seguirà due direzioni: quella
del ritorno e della fedeltà alla religio larica e quella della
direttiva accesa pungente dissacrante ironia nei confronti del nuovo
ambiente, al quale egli si accosta attraverso un penoso processo di
opposizione/adesione. Cosicché, in Un’egloga per la primavera veneta,
il poeta potrà affermare: “… Per ora / laggiù la terra gibbosa ha
dato / occhi ai rovi che sento
sedere delle vostre sorelle?/ A Messina e a Reggio, sotto Roma, / i
fratelli fanno vigilanza /alle mucche, ma vanno a salire/ su altre di
razza veneta…”. Era inevitabile che, cacciato dal Nord e dal Sud (“
Bandito dal Nord e dal Sud. Sono/ un uccellaccio di bosco. Ma questa
sera/ mi sono messo a scrivere con una penna/strappata alle ali
strappate” (“Lettera a Francesco” Concini), concludesse l’amaro canto
di poeta della diaspora, questo Saglimbeni di gran lunga il meno
integrato e il più irrequieto, col recupero di quei canti popolari che
occuperanno poi un loro preciso e autorevole spazio nella sezione
dedicata ai canti popolari liminesi in “Catàbasi e lezione d’umiltà”,
il libro più nuovo e certamente uno dei più originali e validi delle
ultime stagioni poetiche italiane: una “ storia” “narrata” col
distacco di chi in definitiva senta l’amara inutilità di avviare un
dialogo, di stabilire un rapporto affettivo-sentimentale con la
terra-madre, con la propria matrice lontana. Ancora insomma il
sentimento del tempo che, tra presente e passato, tenta le tappe di
una geografia sentimentale che non ha più chiare le coordinate
dell’approdo al luogo del ritorno. Il poeta non si illude sulle
possibilità di un ritorno fisico, sa del resto che non è questo ciò
che più conta, essendo per lui Limina più che il luogo geografico dei
natali il luogo dello spirito, la dimensione perduta e vagheggiata di
un mondo come ormai inesistente, forse come esistito; e certamente il
luogo che aveva visto nascere e morire ogni ideale: c’era stato il
crollo dei sogni e quindi la constatazione del fallimento sociale
oltre che individuale, il naufragio dei progetti anche politici. Un
bilancio, dunque! E narrato attraverso i personaggi-destinatari della
sua lettera-poema con tutto il rammarico per l’approdo, invece,
inatteso e non voluto alla falsa realtà del nostro tempo. E c’è poi
quel suo modo dimesso, seppure risentito, di dire intorno all’antica
condizione del Sud: “non come laggiù dove piove/ sopra gli aborti
delle messi/ e l’acqua impotente di giugno/ è come sterco nel
pugno…”; e ancora: “ Era meglio sorella che tu restassi/ laggiù tra
l’orzo nano/ di giugno e le spighe/ magre e miserabili/ del grano…”.
Sebastiano Saglimbeni sa ovviamente, con la discrezione propria del
tono parentetico, come comunicare al lettore i propri sentimenti e
come condurre una polemica; e quel suo “ far cronaca” en passant, il
fatto,
la notizia buttati giù come occasionalmente nel corso di una
chiacchierata spontanea, alla buona, familiare rendono gradevoli
persino talune” cordiali malignità” letterarie. È forse qui il
fascino di questo rapido “ racconto epistolare ”, dove ancora disamore
indiscrezioni risentimenti, nel loro calcolato succedersi o
alternarsi, consentono uno spaccato della realtà del mondo però vista
attraverso l’ottica dello scetticismo ironico. Il discorso poetico,
sempre fortemente didascalico nello stile e nel procedimento
discorsivo, potrebbe continuare all’infinito a rivolgersi ai due
interlocutori presenti nel “tu” : al personaggio femminile e al mondo;
e del mondo il poeta diviene, talora, la stessa cattiva coscienza! Tra
fughe e ritorni, i temi scottanti almeno degli ultimi due decenni
della nostra storia vi sono trattati in sordina e senza ricorrere
all’aggressività propria del linguaggio di derivazione avanguardistica
e sperimentale: qui semmai lo sperimentalismo si potrebbe far
consistere nella novità e originalità della “ parlata” che ha tutto il
sapore e la pastosità del linguaggio che trae i suoi umori più
suggestivi dalla matrice isolana e dalla civiltà contadina. Nessuna
violenza alla parola: l’umorismo discreto, la forza ironica che
Saglimbeni deriva dalle cose come dalle situazioni storiche, sociali,
spirituali e di cronaca trovano nell’incisività della parola, nella
singolarità della sua sintassi, nella “parlata” con inflessioni non di
rado di tipo quotidiano plebeus, la forza e l’originale constatazione
di una civiltà divenuta inaccettabile ed anche – ecco la doppia
valenza del linguaggio di questo poeta – il desiderio del ritorno al
luogo dei miti, sempre vivo nei poeti cosiddetti della “diaspora”. E
in questo senso deve essere interpretata la passione che induce (si
veda l’ultima parte del libro) al recupero dei Canti popolari liminesi
anonimi: nel senso cioè di un ritorno amoroso a una tradizione che non
si vorrebbe avviata all’estinzione e in quello della contemplazione
appassionata e commossa, da un luogo sperduto dell’ “esilio”, di uno
stato naturale come eden, come impareg-giabile spazio dell’Amore.
Ricco di inventiva, Saglimbeni ama dirigere le proprie energie
emozionali verso scenari che gli restituiscono ancora una volta
l’immagine cara della sua Sicilia, sia essa la Sicilia di Teocrito o
anche la Grecia di Omero: come qui, in “Suono per la tenera fronda”
(Edizioni del paniere, ’79), dove la figura di un padre-pastore
errante, che è anche maestro di affetti, il poeta, e la figlioletta,
interlocutrice innocente di un dialogo amabilissimo, sono gli unici
protagonisti di un “racconto” permeato di finezza psicologica da
rasentare la “ favola poetica”. La memoria è il veicolo e il pretesto
delle “fughe” e dei “ritorni” nel passato mitico, che però Saglimbeni
trasferisce nel presente per farne luogo degli affetti rivisitati,
delle emozioni vissute: è ancora la campagna, è ancora la civiltà
contadina, ancora l’infanzia. E su tutto l’ombra di
un’evoluzio-ne/involuzione, di una (in)civiltà sospetta perché legata
a una lunga storia di illusioni e di inganni. Non meravigliano perciò
le sfumature amare di queste “favole poetiche” anch’esse destinate a
corrompersi insieme ai protagonisti. In fondo è questo il significato
dei sintagmi “ninnoli industriali”, “tempo eversivo”, “volatili
tecnici” e altresì della chiusa finale col ritorno a immagini care e
umili – ma quanto dense di colore! – del dialetto siciliano così
sempre vivo in Saglimbeni come la stessa terra di Sicilia.
L’epilogo non poteva avere scenario più autentico e familiare: “Sta
carusicchia dormi ‘nta sti vrazza/ si stutunu ‘nto cori li
marizzi…”.
Dopo Catabasi e lezione di umiltà, prefazionato dallo scrittore Paolo
Volponi, Saglimbeni ritorna ad interrogare il lettore con il titolo La
volta del libro e dialisi (Guanda, Milano, ’84), con introduzione di
Roberto Roversi. In appendice al titolo, viene ristampata la silloge
Suono per la tenera fronda.
Ancora Occhipinti scrive un profilo su La Volta del libro e dialisi,
che appare nel saggio L’ ultimo Novecento14, (Bastogi, Foggia, 1993)
ripreso successivamente nell’altro saggio Le confuse utopie15 e
completato con un’aggiunta riguardante, una delle ultime sillogi,
Chronicon (Edizioni del Paniere, Verona, 1990) introdotta da Giulio
Galetto.
Sebastiano Saglimbeni è tutto nell’epigrafe whitmaniana che apre il
suo “La Volta del libro e dialisi” (‘84): “ chiunque umilia un altro
anche me umilia/ e tutto ciò ch’è stato fatto a me ritorna/ infine”. E
non poteva essere diversamente: da laico, egli ha scelto una parafrasi
biblica che certamente Walt Whitman ha costruito sull’eco del
“discorso della montagna”. Qui, il poeta intraprende un cammino
interiore e ineluttabile più lucido, meno emotivo di quelli compiuti
nei libri precedenti. E se qualcosa rimane ancora, è il sentimento
dell’amarezza. La memoria non conta più, adesso: il tempo perduto è
irrecuperabile; la ragione dell’infanzia non è più il mito
identificabile nella terra lontana e nella lontananza degli affetti:
storia di vicende cruente come cruenta fu del resto la guerra che
travolse, con la Sicilia il mondo intero: “ Perché sdradicarvi/ a
Portellarossa, fondicello delizia. O/ ardervi se il pico non vi può:
vi pota/ vi educa, invece?/ Ricrescerete ad onta rigogliosi…”. Le
allusioni al dopoguerra, alle miserie, sono qui racchiuse in metafore
dense di storia privata e universale. Semmai, la Sicilia, in questa
poesia – la Sicilia più sanguigna e pregnante – è nella tendenza del
poeta a conservare la “ parlata”, quasi per un antico rispetto alla
parola d’ambiente, della quale Saglimbeni ha saputo fare buon uso in
certi suoi racconti e anche in Catàbasi e lezione d’umiltà (’79). Non
meraviglia allora la forma dialogica affabile e vivacizzata da termini
mutuati dal lessico siciliano (“non li faceva passare”: non li
promuoveva alla classe successiva: “trubuliatu”: tribolato). Siamo al
discorso che ci riporta alla civiltà contadina. Che però, in questo
libro, vive, semmai, nello spazio della civiltà della macchina: è
un’occasione per riflettere sull’attuale civiltà, così come
dall’attuale civiltà il poeta dirige certe sue riflessioni sull’antica
civiltà contadina. Questo vuol dire che ha aggiornato i suoi registri
tematici e stilistici ponendo su un piano di compresenza l’area
contadina della sua terra e l’area industriale: il serbatoio di
illuminati e illuminanti proverbi e il serbatoio di veleni
tecnologici. E tuttavia, egli è un integrato suo malgrado anche se per
sé serba uno spazio ideologico e di lotta come per una sua privata e
onesta contestazione (o adesione a quei princìpi che furono di Lo
Sardo, un suo conterraneo e “sua” creatura, avendolo riscoperto
all’attenzione della Storia). Semmai, quanto resta in lui dell’antica
sapienza contadina viene qui sviluppato in pensose riflessioni, subito
risolte in toccante sapienzialità, tanto che si potrebbe parlare di un
salmismo saglimbeniano con funzione codificante-decodificante. Da un
lato il poeta codifica aspetti di realtà e momenti di esperienza
legati alla tradizione e al colore della terra-stagione, dall’altro li
restituisce alla lettura, alla meditazione e alla sfera emotiva
altrui. Se infatti nel primo Saglimbeni, protagonista erano la terra e
il mito della terra-isola, adesso protagonista è l’uomo della terra.
Perciò cogliamo un’ansia nuova in questo poeta, ora molto meno ironico
e tagliente di prima, anche perchè nel frattempo si è fatta strada la
necessità di una mutazione salvifica che sembra sottrarci dalla
perfidia del quotidiano e dei tempi: “l’occhio s’alimenta/ persino di
ciò che selvaticamente/ rompe ed è/ spia ai limiti del perfettibile”.
O ancora: “… ma una natura non tutta/ è sbagliata: nel taglio la
lettura/ del gusto e viceversa…”. (Domanda-risposta). E questo a
sottolineare il suo splendido salmismo.
Sulla pagina culturale del quotidiano Gazzetta del Sud, Carmelo
Aliberti, si soffermava su Chronicon:
«Con Chronicon, recentemente edito con prefazione di Giulio Galetto e
disegni di Ernesto Treccani nelle E dizioni del paniere fondate dallo
stesso poeta, Sebastiano Saglimbeni, nato a Limina (Me) ed operante a
Verona, incide più profondamente la sua inconfondibile orma creativa
nella storia della poesia dei nostri anni. Senza variare la
traiettoria del suo “viaggio” dentro l’arcipelago realistico del suo
dettato, Saglimbeni opera un più verticalizzato processo di
interiorizzazione, ormeggiando all’ascolto degli echi di una sua tutta
interna e segreta storia, il ritmo travolgente della progressione del
tempo che il poeta affianca per poter sinotticamente cogliere gli
impulsi di antiche storie, le pause impolverate delle veglie, delle
fatiche, delle ansie e degli aneliti contadini, flagellati dalle nuove
barbarie della civiltà tecnologica, nel suono antico del quotidiano,
che riemergono dalla immancabile ferita del profondo, con il guizzo di
un verso inaspettato dall’assediante rifrazione bisbigliata, della
presa di coscienza del dissolvimento delle assolute certezze, della
crudele tregenda dell’effimero contingentismo. Le liriche che
compongono il volume sono prive di titolo e si susseguono con
scansione numerica, come le impronte geometrizzate dell’interiore
catabasi saglimbeniana sempre più dentro le viscere del destino delle
creature della sua terra, la Sicilia, dove l’autore nei ritorni
stagionali continua a ritrovare icasticamente inciso nella galassia
della memoria “come lacrimano/ frutti e alberi d’ incompiuto” (p. 15)
e dove le partenze si distorcono in “spartenze” dalla poesia del
paesaggio di una vita felice, metabolizzata nelle aeree scansioni
dell’anima, anche se i percorsi della nuova storia continuano a
registrare come “… s’annera/ la cronaca e si lotta l’agguato/ della
calura, il malessere addosso/ come un tronco pesante” (p. 15). I
frammenti lirici, condensati nelle sezioni “Partenza-spartenza” e “Gli
abissi del vizio” sono incominciati da un “epilogo” e corredati da da
un’appendice che ospita la traduzione (curata dallo stesso poeta della
famosa Egloga IV di Virgilio, simbolicamente utilizzata come emersione
dell’eterna utopia del poeta di una mai ripudiata palingenesi.
In realtà, le tessere delle pulsioni liriche di Saglimbeni, che
sembravano sventagliare nelle fasi più travagliate nella sua anabasi
verso le terre del Nord, dopo il più recente soggiorno estivo nelle
aree delle radici, possono essere ricondotte ad una unitaria
architettura strutturale, in quanto inguaiano in una sorta di diario
intimo il sotterraneo fiume dell’inesausta tensione della riflessione
sul male e sul dolore, sulle tossine, insomma, che avvelenano i nostri
giorni, ma anche il riaffiorare di una mai necrotizzata fiducia nella
“volta del libro”, cioè nelle umane occasioni della scrittura come
strumento gnoseologico delle più misere verità esistenziali o come
dialisi soterica all’imperversare del “cianuro del tempo” o come
impegnativo stimolo al recupero di una scintilla della folgorazione
escatologica. All’interno delle proiezioni effusive dell’io, sempre
più rastremate in rapporto alla precedente produzione e concentrate
attorno ai rapporti di rispecchiamento osmotico tra l’io e le cose,
tra la causalità degli eventi e tangibilità segnica delle stagioni,
tra l’arcaico strangolamento socio-economico del Sud che non varia
nella febbrile nostalgia dell’esilio(alla cui croce continua ad essere
suppliziato l’uomo del Meridione per il continuo accatastarsi di
errori e di colpe contro cui il poeta Saglimbeni ha sempre lottato), e
la cicatrice civile e morale che si protrae a sgocciolare assieme alla
non superflua perforazione inquisitoria contro le oscure forze che
determinano i mali dell’anima. Sulla scorta della lezione lucreziana,
che lo pilota all’interno dei materici labirinti del mistero della
natura, e con il sostegno dell’insegnamento virgiliano che permea la
sua riflessione di riecheggiamenti polidirezionali e globalizzanti
all’interno dell’oscillazione della storia, la poesia di Saglimbeni si
carica di una contenuta, quanto amara denuncia del dramma universale
dell’uomo e particolarmente della condizione di emarginazione e di
indifferenza verso il secolare dipanarsi della tragedia del Sud,
allora si può cogliere, dentro le effrazioni straziate dalla pagina
del poeta, i sussulti disperati della mai avviata a soluzione
“questione meridionale” assieme al sapore di ubriacatura della
battaglia resistenziale, inesorabilmente vista da Saglimbeni nei
risvolti disumanizzati di ogni ideale aspirazione: “…spense la
nuova/ luce degli alberi…” (p. 63); per cui anche “… si ritrassero
le api, /non vollero uscire a fecondare” (p. 63), a sigillo degli 2
abissi del vizio” della storia, di cui il poeta ha ripercorso i
capitoli idealisticamente più fulgidi o riarsi, senza tuttavia
smarrire la capacità di far vibrare ancora “suoni per la tenera
fronda”, cioè versi d’amore per gli affetti domestici e, più in
generale, un inno alla gioia di vivere per le generazioni future, la
devozione pel la sublimità sentimentale, l’attrazione per le
molteplici, morbide voci della natura, il fascino di un’era mitica
scoperta attraverso la poesia di Virgilio e riproposta con il candore
di una recuperata gioia, in simbiosi con i più alti perenni valori
della vita: “…Bambino, / incomincia a conoscere la madre, dal riso.
Inizia, / bambino: a chi non ha sorriso al suo sangue/ non ha mense di
Dio. Né letto di una dea” (p. 68). Poesia collegata emblematicamente
da un coerente filo tematico e da omogeneità di afflato lirico, che
possono sintetizzarsi nella calzante definizione di “poema
dell’anima”, attraverso cui Saglimbeni ha “letto” sia le biologie
minime dell’alfabeto esistenziale, che il senso recondito e oracolare
di un frammento della storia attuale che si dilata e scava dentro
orizzonti cosmici, alla ricerca e nella necessità del bisbiglio di un
inedito sentimento religioso della vita. Si configura, così, la
tecnica elaborativa del verso di Saglimbeni, calibratamente ancorato
ad un dettato epigrafico che s’informa, sia dell’icastica sinteticità
descrittiva, che di sinergiche e trasvolanti allusioni agli scenari
percettibili o surreali dei significati, sia dello schiudersi a
squarci di dolorosa confessione, che dell’evolversi tematico dentro
l’ermetica, apparente ruvidità lessemo-stilematica, più evidente dove
il poeta elabora bilanci sugli eventi della storia o pudicamente si
isola nell’entropia del proprio irrisolto, e forse pessimisticamente
irrisolvibile nodo del proprio pungente dolore, mas, in realtà,
vibrante di personali tessiture emozionali, percorse dalla ben dosata
duratura delle implosioni poetiche. Particolarmente adoprate
risultano, nell’impaginatura dei versi, alcune figure retoriche, tra
cui “l’enjambement” di diverse liriche, mediante la separazione
concettuali delle correlazioni sintagmatiche, serve non solo a
prolungare la pausa ritmica oltre la scansione tecnica, ma anche a
paradigmare, con più cesellata fissione, i motivi oggettuali,
avvolgendoli in più coinvolgenti iterazioni liriche. Frequente è anche
il ricorso all’epanidiplosi, particolarmente trasparente a p. 60-61,
dove l’iterazione all’inizio del verso dell’ingrediente terminale
contrappone il passaggio dalla scansione del soliloquio sentimentale
con un indeterminato alter ego lirico, all’abbordaggio del dolore
della storia listata di sopraffazioni e di lutti, di offese sociali e
di stupri ideologici ed etici, ad ulteriore conferma dell’elevata
funzione di sollecitazione e di denuncia, ma anche di edificante
progettazione, di cui la poesia, attraverso il ben noto ricorso al
“correlativo oggettivo della negatività”, può essere ancora capace».
La prosa
Alla seconda esperienza poetica del 1965, I martiri hanno l’acqua in
bocca/Le favole e la guerra, segue, a distanza di due anni, nel 1967,
quella narrativa con le prose I Domineddio (Ponte Nuovo, Bologna,
1967) con il sottotitolo, Il vino di padre don Mario e Gli accelerati
del ’64. Ne scrive una breve nota di introduzione lo scrittore
trevigiano Giovanni Comisso. Queste prose sono state ristampate
dall’editrice Fonema di Spinea-Mestre nel 1989.
Nel 1973, Saglimbeni, mentre alimenta la vena poetica, licenzia il
romanzo La ferita del Nord (Guanda, Parma, 1973). Seguono i racconti
Portellarossa, dal sottotitolo, Mandrazzi, l’Officina del corpo (Città
del sole, Verona, 1983); Operaie d’amore (Edizioni del Paniere,
Verona, 1985) illustrate da Ernesto Treccani, con una ristampa nel
1991; Cronache del poeta (Bonaccorso, Verona, 2002) con disegni di
Paolo De Pasquale. Resta inedito il romanzo Caminito amigo, scritto
nel 1990, ambientato, nella sua prima parte, in Argentina, a Quilmes,
nella seconda parte, a Verona. Sulle prose I Domineddio, Alberto
Alberti, uno dei primi che scrisse sulla genesi poetica di Saglimbeni,
scrive su “La Riforma della Scuola” una sua nota. Ma prima, dopo un
quadro sulla scuola, “l’altra scuola”, parla di altri due libri, Un
anno a Pietralata di Albino Bernardini e Le ragazze dell’Alberone di
Lia Giudice entrambi editi dall’editrice fiorentina La Nova Italia. Si
senta Alberti.
“I Domineddio di Sebastiano Saglimbeni è un libro in tre scansioni, la
prima, delle quali (quella che dà il titolo) eppure è quella che
artisticamente ci sembra più riuscita, è tuttavia di minore importanza
per il nostro discorso odierno. Viene da ricordi non remoti di un
paese siciliano, intessuti di piccoli fatti municipali,
sull’impalcatura sociale in stratificazioni di tipo feudale. Ed è
materia sanguigna che ti dà la misura di quanta strada c’è ancora
perché si attinga a livelli di civiltà e di cultura”. Le altri due
parti (“ Il vino di padre don Mario” e “Gli accelerati del ’64)
toccano più da vicino il problema della scuola in particolare, nel
momento in cui i piccoli comuni dei Peloritani fecero salti mortali (e
lo sappiamo per esperienza personale) per aprire anche “ sezioni
staccate” di scuole medie, onde garantire a migliaia di ragazzi la
possibilità di fruire di un diritto che la Costituzione aveva sancito
fin dal 1946. Qui Saglimbeni ha fatto la sua esperienza umanissima e
sofferta. Giova subito avvertire che l’intento suo non è quello di
scrivere un’opera pedagogica. Invano perciò cercheremmo suggestioni di
questa natura. L’Autore segue una sua ispirazione artistica che lo
porta felicemente a sfiorare temi scolastici. Sono i temi del primo
contatto con la scuola, la ricerca di una collocazione, l’andare
avanti ed indietro per treni accelerati; sono anche i temi della
miseria di una zona depressa, dei motivi di liberazione che
un’insegnante un po’ diversa cerca in un bicchiere di vino, della
volontà di recupero che può avere un allievo del manicomio criminale:
tessere e frammenti di un mosaico di fondo, quello costituito dai
problemi di cultura e di impegno civile che conosce una società in
crescenza, gravata ancora di pregiudizi e di disagi ma vogliosa di
scuotersi e di muoversi verso atmosfere più respirabili dove le
condizioni ufficiali non siano di ostacolo all’esplicazione delle
possibilità interiori di ciascuno. Su I Domineddio (2a edizione) una
concisa nota di Giulio Galetto appare sul quotidiano “L’Arena”17 del
25 luglio 1989.
(…) I Domineddio, un testo composto di tre prose che, pur dotate
ciascuna di una propria autonomia, si relazionano quasi come i
capitoli di un romanzo che elabora in forma narrativa una materia
insieme documentaria e autobiografica, il libro uscì nel ’67 con una
prefazione di Giovanni Comisso che diceva fra l’altro.: “Bozzetti
efficaci, originali, che risentono, certe volte, di quelle descrizioni
di Vittorini in Conversazione in Sicilia (…) L’orizzonte di un paese
siciliano, in una zona montana del messinese aspra e isolata, colto
negli anni dei cruciali cambiamenti che segnarono il dopoguerra, è
restituito con l’immediatezza di una prosa ruvida, tutta diretta ed
esplicita, insofferente di significati sottintesi e di abbellimenti
formali, scorciata con impennate e scarti di sapore naif. Si incidono
così le immagini di una umanità povera, condizionata da consuetudini
arcaiche, ma già capace di respirare l’aria dei cambiamenti,
l’insostenibilità delle antiche divisioni fra “cittadini” e “viddani”,
fra domineddio e “jurnatari”. Sono immagini che, dopo l’affresco
generale della prima prosa, diventano sfondo della più individuale –
ma ancora socialmente emblematica – vicenda del giovane professore che
va a insegnare fuori paese, che si scontra col grottesco conformismo
di modesti domineddio, che si dibatte con i nodi di un confuso ma
umanissimo “privato”. È un libro che richiama, per il bilicarsi fra
documento e narrazione, certi ricordi vittoriniani e, per i filtri
psicologici, certi echi quasimodiani; è un libro che risuscita anche i
fantasmi del neorealismo: datato, certo, da una rude, non spenta
vitalità.
Su La ferita nel Nord, senza alcuna nota introduttiva, a firma, sono
state scritte solo alcune recensioni di Giorgio Saviane, di Manfredo
Anzini e di Giuseppe Piccoli. Per le prose di “Portellarossa”,
Giovanni Occhipinti, che le prefaziona scrive: “(…) Ricordi con una
loro quasi drammatica inesorabilità, brucianti come l’incubo o come un
trauma che tarda a sanarsi. È da questo stato di sofferenza che
l’autore può muovere alla ricerca di un’identità, che ritrova nella
figura del padre(…)”. Per “Operaie d’amore”, Gualtiero De Santis,
che le prefaziona scrive: “C’è per intanto il valore di necessità
dell’oggetto rimembrato. Nel caso di Sebastiano Saglimbeni, le
immagini luminose di queste donne, povere e semplici, e però dedite
agli altri (familiari, collettività, poveri), rivelano il paesaggio
dell’infanzia e, al suo interno, l’equilibrio umano e morale che ne ha
governato le linee. Vibra insomma un’intima transitività tra le figure
della monaca, della maestra, della sorella e la situazione di chi
scrive: che non è solo psicologia, nel senso di un’incertezza
personale, e non solo riferibile al clima dominante, ideologico
politico storico, che ha oscurato la speranza di intere
generazioni(…)”. Su Cronache del poeta, ultimo lavoro in prosa, si
può leggere una breve e concisa recensione di Giulio Galetto.
Non esiste, se si vuole, ancora uno studio veramente mirato alla
scrittura prosastica di Saglimbeni. Sulle traduzioni, riguardanti le
Bucoliche, Le favole (quelle fedriane) e le Georgiche, si contano
alcune recensioni, tra cui Giulio Nascimbeni, Gianni Giolo e Giulio
Galetto scrivono sulle Bucoliche, Davide Mattellini e Galetto sulle
Favole. Beniamino Placido scrive sulle Georgiche, tradotte da
Saglimbeni:
“La poesia di Sebastiano Saglimbeni scaturisce dal profondo amore del
poeta per la sua terra natale, amore che si acuisce per la lontananza.
La produzione poetica sottolinea l’impegno sociale dell’autore che
denuncia, con un linguaggio incisivo e privo di retorica, i mali che
attanagliano da sempre la sua Sicilia.
La sua è una partecipazione sofferta ai drammi eterni della sua terra,
a cui vuole ribellarsi con tutto il trasporto e la passione tipica del
siciliano mediante il suo messaggio-denuncia. Il poeta rivive
intensamente questa triste realtà, da profondo conoscitore
dell’ambiente e della società isolana, ed adopera un linguaggio che si
piega alle sue esigenze, per approdare subito alla stesura
dell’immagine. Sullo sfondo di questa Sicilia tanto amata, ma tanto
derelitta, si inseriscono dei temi semplici, ma al tempo stesso
essenziali, di ampio respiro: l’amore, il dolore, la violenza, con
espressioni che, nella loro semplicità e nella loro estrazione
popolare, trovano grande forza espressiva : -… tua madre contadina
accolse la «malanova» / sulle colline del tuo paese : /… a lei si
fece sera / come nel tuo cuore / quando stava per staccarsi: / – ed
ancora : – le stesse messaggere di «malanova» / raccolsero dentro un
lenzuolo /… il tuo piccolo corpo di donna siciliana / vestito a
lutto / e l’adagiarono a casa / sopra il materasso di paglia d’orzo
/… Questi temi, che potrebbero scivolare nel colore locale, in un
sentimentalismo di facile effetto, sono immagini di una realtà
effettuale scevra da qualsiasi indulgenza folkloristica.
Saro’ un disertore della mia terra
Fatemi andare in questi giorni
d’agosto malaticcio
che strizza l’occhio
all’autunno.
Fatemi andare col fumo
delle frasche bruciacchiate
nel noccioleto:
le contadine con le anche
cioccolata
raccattano le nocciole.
Fatemi andare ora
che nel cielo sporco di nuvole d’acqua
il merlo saccheggiatore d’orti
lamenta i piccoli
mangiati dalla vipera.
Fatemi andare dall’isola
in questa agonia d’estate
capricciosa – ci nascose il sole –
piagnucolosa e avara
come queste terre.
Fatemi andare. Prenderò
un ramoscello dì gelsomino
che metterò all’occhiello
della mia giacca vecchia di poeta.
E la mia non sarà una licenza
d’alpino di fante d’aviere,
ma un congedo di vecchio soldato ferito
nelle punte mortali,
senza ridicole decorazioni:
sarò un disertore della mia terra
come tutti i poeti isolani
che muoiono fuori
con la nebbia sul cuore
e non vedono le rondini
pranzare insetti nell’aria.
I versi sono dettati da un’effusione sentimentale, di cui si rende
interprete il paesaggio: è una natura illanguidita, un giorno di fine
agosto che, con le sue nuvole, preannuncia di già l’autunno. Questa
atmosfera morta crea un clima di provvisorietà, in cui si inseriscono
la tristezza e la malinconia per la partenza del poeta dall’isola. È
un tema tradizionale, che ricorre spesso nei poeti isolani, il
rivivere con maggiore intensità l’amore per la Sicilia, proprio nel
momento in cui ci si allontana dall’isola. Qui, l’ossessiva iterazione
dell’anafora sgorga da un profondo sentimento di dolore del poeta che
ha convissuto la tragedia della miseria con la sua gente, in una terra
desolata, desertificata da un destino ostile, ma che, nel coatto
congedo, sente fibrillare nel suo cuore il candore dei giovani
siciliani ed è quasi sul punto di rinunciare alla partenza, anche se
sa che il distacco è inevitabile. L’iterazione insistente del “Fatemi
andare”, all’inizio di ogni gruppo di versi con i successivi richiami
di persone e del paesaggio, a lui tanto caro, esprimono chiaramente il
profondo dolore di chi non si vuole distaccare dalle cose care, ma il
poeta sa che “il congedo” è improcrastinabile “con tutti i poeti
isolani”, ma il romanzesco di gelsomino lo terrà legato alle radici
durante i giorni infiniti dell’esilio.
Il tuo piccolo fante
Te lo dissero le comari
mentre ritornavi dalla fontana del paese
con la brocca d’acqua
sopra la testa.
– Hanno tagliato le gambe
a tuo figlio Nino
in guerra!
Le gambe hanno… !
La brocca si scheggiò
e ti rimase il grido disperato
dentro la gola:
la tua faccia si fece cianuro
e misurasti la terra
sporca della tua acqua
e poi l’isterismo…
Le stesse messaggere di «malanova»
raccolsero dentro un lenzuolo
il tuo corpo svenuto,
il tuo piccolo corpo di donna siciliana
vestito a lutto
e l’adagiarono a casa
sopra il materasso di paglia d’orzo.
Scese dai colli il vento
nella notte:
picchiò alla tua piccola porta,
tu, povera morta di dolore,
sognavi il tuo piccolo fante;
il tuo piccolo fante, tra spasimi di febbre,
abbracciava una madre:
era la nordica sorella
d’ospedale, bella
al suo capezzale.
La violenza della guerra, il dolore di una madre, la vittima della
forza bruta, sono i protagonisti di questo componimento, dal costrutto
semplice e dal linguaggio quasi popolare ed incisivo. L’immagine della
madre che, alla notizia del figlio ferito, rompe il silenzio con urla
strazianti e le comari che si muovono intorno con un movimento quasi
ritmico, sembrano riprodurre le movenze del coro della tragedia greca.
È il dolore sincero, che segue però le regole esteriori, mimiche,
espressive e verbali ben definite e cristallizzate da secoli di
tradizione; anche il paesaggio, tracciato con rapidi tocchi, sembra
partecipe del dolore di questa piccola donna siciliana.
La resistenza alla terra gibbosa
Laggiù ti cercammo acqua al quinto, ma la messe
si postrò sul suolo, arso vetroso (pure questo
alla guerra ci voleva!) e al settimo dell’anno
tutto un aborto videro la terra, occhi affossati
e i sassi non divennero pani. Sonnino che aveva
la moglie paralitica, egli con mezza vita,
zappava in ginocchio, diceva parole al cielo
buone… ma dopo ci disse che il pero
non faceva miracoli e nessun albero arido
e ci alzò il bastone in faccia: «andate
a portare concime nei campi che il grano verrà,
il prete canta e il suo mestiere è questo,
concime portate!». E l’asina andava veniva
per viottoli pericolosi, con dietro un ragazzo,
scarno che aveva solo divorato un pugno di fichi
e castagne e basta fino a domani: l’asina portava
il concime, ma era affamata; il ragazzo cercava
qualche frutto dimenticato, ma gli uccelli
avevano più fame di lui… l’asina un cardo
sui cigli e ci cantava il gufo dove andavamo,
ci oscurava il cuore.
Un ombelico di terra sensibile
dopo tutto ci ascoltò e diede spighe:
Sonnino rise e ne guastò una nelle palme
baciò il grano, soffiò, mise in bocca pianse…
«questo è il Signore», ci disse. E l’aia era
una chiesa, la nostra piccola azienda, e pennuti
ci offrivano la musica classica, più bella
d’un organo di sacrestia, in cambio del grano
asportano (gli uccelli erano discreti però
non cercavano la metà come i compagni).
Questa composizione si può considerare più una prosa ritmica, che una
poesia vera e propria; lo stile è semplice, umano, privo di inutili
preziosismi e mette in evidenza la dolorosa fatica dei contadini del
Sud. Sonnino, il protagonista della «favola», che riflette una certa
amara realtà, è il simbolo dell’immutata vita nei campi del Sud, e
dello stesso poeta partecipe con sofferta tristezza di una realtà
isolana immobilizzata nel tempo, al di sopra di ogni mera e
oleografica rappresentazione folkloristica.
Incontro con Sebastiano Saglimbeni
Un Poeta Siciliano della Diaspora –
“Restare per lottare”
Sebastiano Saglimbeni, nato a Limina in provincia di Messina, vive da
molti anni al Nord. Ha pubblicato le raccolte di poesie E non ho
pianto (1961), I martiri hanno l’acqua in bocca oLe favole e la guerra
(1965), Resistenza alla terra gibbosa (1969), Catabasi e lezioni di
umiltà (1977), Suono per la tenera fronda (1980); due libri di
narrativa: I domineddio (1967) e La ferita del Nord (1973). È anche
autore di un testo teatrale. Le vergini sono in vetrina (1974).
Innumerevoli sono i suoi interventi critici sparsi sui maggiori
quotidiani italiani. Ha fondato il periodico culturale “Mondo
nuovissimo” e attualmente dirige con Sanesi le edizioni de “Il
paniere” con cui ha impresso un notevole contributo alla diffusione in
Italia della migliore poesia intemazionale della “resistenza”, dai
versi di Ristos all’urlo di Hikmet, ed ha riproposto, in agili e
moderne traduzioni, opere di Orazio, Catullo e Virgilio. Inoltre,
nella collana «presa-documento» ha riesumato inediti negletti di F. Lo
Sardo.È annoverato tra i più originali e fertili poeti siciliani della
“diaspora”.Partito da un polemico impegno meridionalistico, il suo
discorso poetico ha via via ammorbidito i toni aspri e viscerali della
aggressività primordiale, assorbendo le sanguinanti lacerazioni
sociali negli acri gironi di un ironico scetticismo, attraverso le
metaforiche trame di un racconto, in cui viene scagliata in sottofondo
la falsa realtà delle illusioni e dei miti, per una più realistica
presa di coscienza delle sperimentazioni della storia. La Sicilia di
Quasimodo, lido agognato degli assalti del “nostos”, si tramuta in
Saglimbeni in proiezione geograJBca di ima dimensione spirituale in
cui ha imperversato lo scempio della storia e che il poeta recupera in
un’esigenza di crudo e attualizzante bilancio, teso a creare le
condizioni culturali per una più equilibrata e produttiva
“resistenza”. In tale ottica si colloca anche l’attenzione del
Saglimbeni verso i “canti popolari liminesi”, “radiografati” nella
preziosità “archeologica” dell’inflessione quotidiana, quasi a voler
rintracciare nell’afflato plebeus le molteplici valenze di un intatto
patrimonio di valori, su cui poter tessere un ipotetico progetto di
redenzione.
Al poeta di Limina, nel suo recente soggiorno in Sicilia, abbiamo
rivolto alcuni quesiti, volti ad illuminare meglio alcuni aspetti
della sua intensa attività letteraria.
D. – Come si è rivelata in te l’esigenza di scrivere versi?
R. – L’esigenza di scrivere versi è venuta fuori da quando nelle vie
anguste (e che “odoravano di brodo di rape”) di Limina, mio paese
natale, si cantava e si suonava sotto le finestre delle donne, perché
queste corrispondessero. Ciò avveniva verso la fine degli anni
quaranta, all’indomani della Liberazione e c’era tanto bisogno
nell’umanità risparmiata di cantare, per alleviare le ferite create
dal conflitto mondiale. Le ferite erano le nere miserie d’origine,
raddoppiate dopo il sangue umano, inutilmente versato. Poi, avviato
allo studio, giacché la terra gibbosa e fradicia non avrebbe saziato
sebbene tanta opera educativa, ho incominciato ad assaggiare la
letteratura colta. La poesia, in potenza, come trasfusa dai canti
popolari liminesi, cominciava ad uscire dal suo primo stadio e,
diventando più espressione, si faceva anche alleviatrice di angosce,
forza interiore, speranza e, più avanti, andava riempendosi di
problematiche, di didattica.
D. – In che misura la realtà sociale della Sicilia ha inciso nella
elaborazione della tua poesia?
R. – La realtà sociale della Sicilia ha avuto costanti rivelazioni sin
dai versi di E non ho pianto, silloge esercitativa, debole, macchiata
come i primi frutti; ma desiderati, non rifiutati, una volta spuntati,
poi ne / martiri hanno l’acqua in bocca o Le favole e la guerra, in
Resistenza alla terra gibbosa, e, infine, in Catabasi e in Suono per
la tenera fronda. Certo non dovevo dimenticare la nostra area che è,
poi, come tante del mondo, lacerata, straziata da governi maligni,
contro i quali dobbiamo lottare o insorgere con l’arma micidiale
dell’espressione, come hanno fatto Lo Sardo, Gramsci, Ritsos, Hikmet
ed altri. Dovevo essere, io della Sicilia, con Quasimodo, per cantare
con lui le bestemmie di tutte le razze nell’isola. La mia poesia è
fatta di Sicilia, nonostante io abbia sentito quella di fabbrica, un
po’ quella sperimentale.
D. – Che ruolo svolge nella tua opera il mito e quale rapporto deve
cogliere il critico tra la tua “voce” lirica e la storia?
R. – In un’analisi, formulata alcuni anni fa da Alberto Alberti per la
“Riforma della scuola”, era venuto fuori il mito e la leggenda, a
proposito di alcuni spazi poetici della mia seconda esperienza I
martiri hanno l’acqua in bocca o Le favole e la guerra: per quelle mie
proposizioni calate nella storia della società siciliana, rimasta, per
certi aspetti, legata al passato. In me il mito non ha, comunque, lo
scopo di voler recuperare, disseppellire storie di estrazione
ellenica, ma di fare assurgere proprio a mito gli umili che provengono
dal popolo e per esso, veramente, si battono, senza tornacontismi, per
cui Lo Sardo, Salvatore Carnevale, le contadine che maneggiano
l’aratro, le madri che muoiono consunte per i figli che ritornano
dalla guerra senza occhi, gambe, braccia: per cui gli spaccalegna, gli
zappatori o gli educatori della terra: per cui, ancora, gli uomini dì
quella Sicilia umile, contadina, questi sono i miei santi, i miei
miti; e la poesia, che non deve indugiare nel passato per il
disseppellimento di ricordi, infanzie e innocenze perdute, come nella
stagione del decadentismo, deve contenere questo tipo di società. Sono
certo inevitabili i riposi lirici e il critico deve considerarli come
momenti poetici teneri ma che immettono nelle tematiche della storia.
D.-Anche in te, come in Quasimodo, un certo ruolo svolge il recupero
del passato. Qual è, secondo te, la differenza tra il Salvataggio
della memoria in Quasimodo e la tua proiezione memoriale?
R. – Quasimodo ha precisato, in occasione della laurea ad Honorem,
conferitagli nel 1959 a Messina, di aver lottato i decadenti. Io li ho
sentiti come protagonisti di una cultura grande, soprattutto in
Francia, e li ho studiati, ma non ho registrato gli aspetti che
propongono il passato, alla maniera
proustiana, quelli fatti di contrasto spirito e materia; forse sono
stato preso da certo sensismo, ma non dall’estetismo. Il passato, che
mi è venuto all’incontro nelle fasi delle mie formazioni letterarie,
ha giocato un ruolo storico, didattico e vuole – come è stato forse
chiarito – soprasalvare i simulacri di ieri tenuti come in cattività
dal prevalere di mode, di ideologie, di politiche inquinate. Per
questo, ultimamente, ho composto un testo per Lo Sardo, per la sua
lotta nella nostra area siciliana, per cui, non essendo stato
sopportato da una politica tirannica, viene imprigionato ed esce
morto, dopo cinque anni. Lo Sardo, da me collocato nella necropoli,
vuole assurgere a mito, recuperato dal passato, così come il padre di
Salvatore Quasimodo nel testo Al padre. E se si può aggiungere ancora
altro: in Quasimodo protagonista è la Grecia, la trasfusione di questa
che gli è pervenuta dalle poeticissime traduzioni dei lirici; in me,
epigono, è la terra, come disse, diversi anni fa, un singolarissimo
critico, Domenico Cicciò, come l’ha ripetuto, di recente, nel saggio
P(r)o(f)eti dell’Isolamondo, Giovanni Occhipinti, Quasimodo e altri,
sei considerato poeta della “diaspora”.
D. Perché anche oggi le migliori energie intellettuali fuggono dal
Sud e quale funzione positiva potrebbero ancora svolgere i poeti, la
cultura in generale per contribuire a migliorare la realtà
meridionale?
R- La mia “diaspora” ha motivi che vanno ricercati nella mia
inquietudine, non perché nel messinese non vi fosse stato il pane e la
realizzazione di formazioni culturali. Pur essendo in Veneto, qui ho
con me le ginestre, lecontadine dal viso di pece e dal naso arato; ho
il latte della mia terra. Le migliori energie intellettuali fanno
anabasi perché in esso non trovano la forza, la insistenza di
“realizzarsi”, come si suol dire, e che manca il senso della vera
lotta, delle iniziative. In questo modo, non serve parlare, come non
serve, resistere senza salpare, e fare studi, forti, rigorosi per
rimanere solo cibati di erudizione fatta di grammatiche per poeti o la
cultura in genere potranno determinare risorgimenti, perché ancora noi
siamo sotto il potere della ragion di stato, scellerato, crudele,
sadico nei confronti del bole; potrà la poesia o la cultura in genere
migliorare la realtà meridionale, se, dove nemo propheta, si continua
a fare resistenza alla società che si ciba di pregiudizi e non ama i
poeti, gli uomini che sentono di crescere con nel cuore i fiori, lo
studio. Il meridione si riscatta, resistendo nel meridionale: vedi
come Sciascia a Palermo è instancabile operatore: scrittore, e uomo
politico, seppure non accettato dal sottoscritto nel suo ruolo di
politicante. Basta, in altri termini, scrivere e non dormire, non
farsi prendere dal troppo riposo e dalle mosche “del meriggio”.
D. – Nel 1967 con I domineddio hai esordito anche come scrittore. In
quale area della narrativa contemporanea si può collocare la tua
ricerca e particolarmente quali parallelismi esistono tra il tuo
lavoro e quello di Sciascia?
R. – Con I domineddio, prosa scarna, godibile, nonostante sciancata
qua e là, ho voluto fermare una situazione sociale in Sicilia in un
periodo durante il quale si cercava di ricostruire l’Italia
sgangherata; ho fatto forse prosa neorealistica; per le tre denunce
riguardanti il paese Limina e la sua storia medievale e le due
esperienze d’insegnamento in due paesi del messinese. Per un rapporto
tra me e lo scrittore Sciascia, debbo dire che io avevo allora povera
vita culturale, ma iniziavo ad adoperare le mie armi del sapere. In
Sciascia, se posso un po’ riempire il quesito, v’era entrata la vita e
l’anima di certa Sicilia, in me incominciavano ad abbozzarsi discorsi
di denunce sulla storia del paese, accusato di malandrineria e di
delitti, sulla economia, sui costumi, sugli usi, sulla cultura
popolare, quella che mi nutrì con latte poetico.
D. Che cosa pensi della produzione letteraria di questi anni e quali
accuse muoveresti?
R – La produzione è vasta e tanto fradicio, dilettevole, commerciale
v’è in questa, ma si elevano opere, come quella narrativa di Stefano
D’Arrigo, Volponi, Moravia, mentre per il settore poetico penso che,
dopo Quasimodo, Ungaretti, Montale, tanti della IV generazione non
siano veri poeti, ma sono le loro case con il loro mare magnum
pubblicitario che li fanno apparire validi; la V generazione sta
lottando per avere recezione di critica. Tanti titoli non determinano
negatività, vuol dire che vi sono tanti che si dedicano
all’espressione in luogo di altro, magari deleterio. Le accuse vanno
verso quella forma culturale falsa, confusa, che vuole camminare di
pari passo con l’astrattismo, quello irrazionalistico, fatto per
apparire nuovi, ma non si è né tantomeno si sa fare la forma: meglio
il parlare latino, agevole, che, poi, non è di tutti.
* * *
Sono caduti nell’ossario del tempo sedici anni da quando scrissi su
Sebastiano Saglimbeni quanto sopra; il mio interesse ora per l’uomo,
il poeta, lo scrittore, il saggista e il traduttore, di recente, di
Virgiho e di Fedro, si intensifica di crescita bibliografica
saglimbeniana. Sebastiano Saglimbeni, dopo il 1981, ha continuato,
sino al 1993 a sviluppare le sue Edizioni del Paniere con titoli di
storia, poesia, saggistica, teatro e grafica. E debbo ricordare il
densissimo volume dell’Epistolario dal carcere di Francesco Lo Sardo,
I Discorsi che il grande umanista e politico Concetto Marchesi
pronunciò alla prima e seconda legislatura della rinata Repubblica
dopo la resistenza di cui fu sostenitore con scritti eccellenti e
lotte nell’ateneo di Padova. Sia l’Epistolario che I Discorsi sono
usciti a cura di Saglimbeni, di cui, a proposito, scrisse Guido
Gerosa, scrittore e storico, su “Il Giorno” del 24/8/86 che ”
Sebastiano Saglimbeni è un uomo di grande fascino, organizzatore
appassionato come pochi, poeta di stile elegante, speleologo di rarità
e finezze letterarie, creatore di fulgide occasioni poetiche…”.
Saglimbeni, come poeta, dopo Catabasi e lezione di umiltà, ha
pubblicato, con prefazione del poeta bolognese, Roberto Roversi, La
volta del libro (Guanda, 1984), le prose Operaie d’amore (Ed. del
Paniere, 1989) con prefazione di Gualtiero De Santi, saggista
urbinate, Chronicon (Ed. del Paniere, 1990) con prefazione di Giulio
Gaietto e Mielifìca la rosa (Ed. del Paniere, 1992) con prefazione di
Massimo Carbone, mentre come saggista Federico Garda Lorca (Ed. del
Paniere, 1988), Il Fiore e l’intenso – Il Garofano di E. Vittorini
(Ed. del Paniere, 1991). Su consiglio del latinista Mario Geymonat,
Saglimbeni ha pubbHcato una versione poetica delle bucoliche
virgiliane e le favole fedriane; sia l’uno che l’altro classico con
testo a fronte ed editi con la casa editrice Newton Compton, ’94-’95.
Chronicon – come ho scritto sulla “Gazzetta del Sud” – è un’opera con
la quale Saglimbeni “incide più profondamente la sua inconfondibile
orma creativa nella storia della poesia dei nostri anni” (13 novembre
1991). Pongo, dopo questi sedici anni e alla luce della sua nuova
posizione nella cultura itahana ed europea (Saglimbeni è stato
tradotto in Russia, in Francia e in Grecia), un quesito.
D. – Che cosa riesci a dirmi su questo fine secolo che si spegne
nebuloso, con scarse probabilità di impiego per la classe giovanile?
R. – Il secolo non si spegne nebuloso, né foriero di tragiche vicende
nella nuova società dei giovani, ma sì spegne con la ripetitività, che
sembra crudele, delle vicende di sempre, ad iniziare dalle palafitte
al recente ieri dei grattacieli. È la tecnica ch’è mutata, ma
l’Animale (o Uomo), dopo che vive un po’ in pace con se stesso e con
gli altri, vuole battersi con gli altri, perché è carente di qualcosa,
di protagonismo, ad esempio, ed è la forza della bieca natura, che né
leggi, né religioni riescono a mutare, anzi, spesso, peggiorano.
L’uomo, tuttavia, può essere lo stesso se riesce ad elevarsi
ributtando il “troppo” e il “vano”, ma non è sempre agevole. Allora,
da parte degli uomini che preferiscono la luce alle tenebre, occorre
opporre resistenza affinché prevalga, il più possibilmente,
l’equilibrio nei comportamenti umani. Ma non voglio dire altro, perché
potrei fare trita filosofia. (1997)
BIBLIOGRAFIA
Opere poetiche:
E non ho pianto (Ancona, 1961; I Martiri hanno l’acqua in bocca/Le
favole e la guerra (Firenze, 1965); Resistenza alla terra gibbosa
(Bologna, 1969); Catabasi e lezione d’umiltà Milano, 1977, con
ristampa nel 1979); La volta del libro (Milano, 1984); Cronicon
(Verona, 1990 Mielifica la rosa (Verona, 1992).
Opere di prosa:
I Domineddio – racconti- (Bologna, 1967; ristampa (Mestre, 1989); La
ferita nel Nord- romanzo- (Parma, 1973) Portellarossa- racconti-
(Verona, 1983); Operaie d’amore- racconti- (Verona, 1989), ristampa
(Verona, 1991); Cronache de poeta (ibidem, 2002); Caminito amigo (in
corso di stampa).
Saggi:
Ritratto d’uomo e d’opera di W. Whitman in Fogle d’erba (Verona,
1984); Federico García Lorca (Verona, 1986); Il fiore e l’intenso / Il
Garofano di Elio Vittorini (Verona, 1991), Larga vina (Vino in
abbondanza) Nei classici e negli autori contemporanei (Possidente –
PZ- 2004), Mal di caffè / Uomini e Caffè d’Italia (Possidente, 2005).
Teatro:
Le vergini sono in vetrina -commedia in tre atti- (Verona, 1974).
Traduzioni:
Bucoliche di Virgilio con testo a fronte ed illustrazioni di Ernesto
Treccani (Verona 1993), seconda edizione, (Roma, 1994); Le favole di
Fedro con testo a fronte (Roma, 1995); Georgiche di Virgilio, con
testo a fronte ed illustrazioni di Ernesto Treccani (Gallarate, 2002);
in corso di stampa Eneide, con testo a fronte; in corso di stampa
Liriche e frammenti di Saffo con testo a fronte.
Ha curato per l’editore Niccolò Giannotta Giustizia di Mario Rapisardi
(Verona, 1978) e Diari di esilio I – II di Ghiannis Ritsos, (Verona,
1978-1979). Con le Edizioni del Paniere, di cui è stato fondatore, ha
curato l’Epistolario dal carcere di Francesco Lo Sardo e I discorsi,
pronunciati alla Camera dei deputati da Concetto Marchesi. È autore
del manuale parascolastico Storia dell’arte (Dalla Preistoria all’arte
romanica – Vol. I – Dall’ Arte gotica all’Arte contemporanea – vol.
II), (Seregno, 1979). Alcuni suoi testi poetici sono stati tradotti in
lingua francese (Losanna, 1986); in lingua russa (Mosca, 1986). Testi
della raccolta E non ho pianto, I Martiri hanno in bocca, Resistenza
alla terra gibbosa e Catàbasi e lezione d’umiltà sono stati tradotti
in greco moderno da Crescenzio Sangiglio, (Salonicco, 1984).