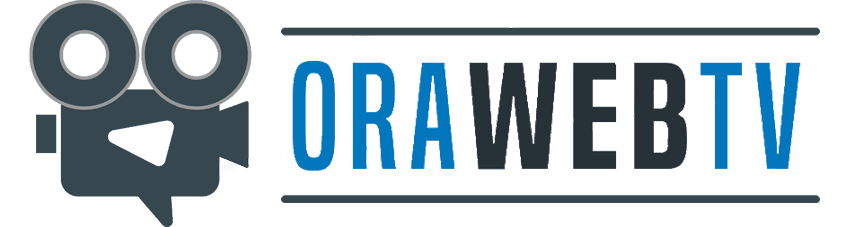Riceviamo dal Prof. Carmelo Aliberti e pubblichiamo integralmente questo scritto dedicato all’artista barcellonese di fama internazionale Emilio Isgrò. Buona lettura.
Poeta, pittore, scultore, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e regista, è nato a Barcellona di Sicilia nel 1937, ma dal 1956 vive e lavora a Milano, con una parentesi di sei anni a Venezia, dove ha curato le pagine culturali del Gazzettino, allora diretto dal messinese Giuseppe Longo. Intellettuale poliedrico, dissacratore ed eccentrico, oscillante in tutte le sue operazioni artistiche tra radiografia realistica degli eventi e deviazione nelle forme della parodia, ogni sua opera rappresenta un diverso capitolo dei drammi e delle distorsioni dell’Italia di oggi, di cui esplora euforie effimere, smagliature, malversazioni e insidie di categorie sociali e politiche furbesche che, sotto la maschera del perbenismo, coprono vizi, camaleontismi e follie di vario genere.
Una nuova poetica.
Come poeta, esordì giovanissimo con Fiere del Sud (Schwarz, 1956), dove ancora la forza della parola è animata dalla memoria degli eventi quotidiani della sua prima giovinezza, osservati come oasi felice di conforto e di idealità e dotati di un linguaggio trasparente e originale, che già induceva il lettore a prefigurare nell’opera esordiente di Emilio sviluppi imprevedibili. Infatti, erano gli anni delle operazioni artistiche della Neoavanguardia, raccolte nella prima Antologia della poesia visiva curata da Lamberto Pignotti, dove la o j m. “poesia visiva” non risultava ancora definitivamente consacrata, ma appariva in dilemmatico rodaggio. Con le raccolte Uomini e Donne (Sampietro, 1965) e L’età della ginnastica dell’anno successivo (1966), Emilio Isgrò appare coinvolto nel movimento delle operazioni sperimentali che dilaga nella nostra letteratura, spesso sottesa da valenze ideologiche contestatrici del sistema di potere alto-borghese.
I poeti nuovi, in un clima di neocapitalismo e di alienante consumismo, volevano tracciare le linee di una rivoluzione che svuotasse di pregnanza contenutistica la parola, per impedire ad essa sia la possibilità di darsi un ordine logico-espressivo, tendente adappiattire la mente, che di esprimere inutili messaggi di palingenesi o trasmettere subdole comunicazioni capaci di attutire ancora di più la spinta delle masse, febbrilmente affamate di edonismo, alla ragione. Si trattò di un esperimento non totalmente riuscito, come oggi la stessa critica riconosce unanimemente. Ma a questa linea, inchiodata al foglio come strumento di contestazione globale, si affiancò in maniera originale Emilio Isgrò che, nel tentativo sia di reazione allo strapotere borghese, sia di salvare il ruolo propedeutico della poesia, si accorse che la parola “straniata” non poteva essere più lo strumento privilegiato dell’operazione poetica, ma doveva trasformarsi in evento estetico, in cui il segno verbale poteva coniugarsi con il segno iconico e creare così una poesia visiva, in cui il momentaneo equilibrio ritrovato fosse prefigurazione e bellezza.
In effetti, il concetto, teorizzato particolarmente da Isgrò, divenne l’epicentro di una nuova poesia come arte generale del segno, con strutture estetiche in cui coesistevano cifre tratte da codici diversi. Così al segno verbale si affiancarono quello pittorico, il manifesto, le spezzettate parole del discorso e le lettere dell’alfabeto, caoticamente disposte sulla pagina bianca. Se prima i fili della cultura alto-borghese e di quella piccolo-borghese non erano totalmente interrotti, con il radicalismo libero dell’opera di Isgrò (soprattutto con L’età della ginnastica, che rifiutava il “collage” di altre 168 linee avanguardistiche, in quanto si rivelava forte ancora la capacità di trasmettere messaggi) la rivoluzione della poesia visiva non era più una arbitraria incongruità, ma si imponeva come lo scatenarsi di ogni potenzialità di comunicazione e, senza rinnegare il valore dell’arte, proponeva uno strumento divulgativo di nuovo conio, carico di molteplici ipotesi di lettura. Il dibattito su tale motivo fu intenso, ma il poeta di Barcellona impose la sua poetica come la più rispondente, nella sua globalità, alla richiesta sociologica e artisticamente rivoluzionaria del tempo. Così il suo nome passò alla storia letteraria con l’etichetta della creazione poetica scandita dalla tecnica della “cancellatura” e sostanziata del potere effrattivo della “visività” di lessemi selezionati e più idonei alla immediata trasmissione di messaggi. Ciò rappresenta il risultato di una mentalità naturalmente anarcoide, ma anche un progetto ideologico di saldatura comunicativa di rapporti tra oppressori e oppressi.
Nelle altre opere, sia in quelle teatrali, scritte in versi, come L’Orestea di Gibellina (Feltrinelli 1983-85), sia nei suoi romanzi, quali Marta de Rogatis,(Feltrinelli, 1987), Polifemo (Mondadori, 1989), L’asta delle ceneri (Camunia 1994), sia nella raccolta di versi Oratorio di ladri (1998), Isgrò non si allontana da questo suo teorema di impasto storico-semantico-linguistico e, se attorno al tema centrale sviluppa quello prevalente di un’operazione dissacratoria dei formalismi codificati della civiltà di massa, tutte le sue opere abbondano di tanti ingredienti culturali, popolari, giullareschi, drammatici, ironici e tragici, con un’operazione circolare di strutture, di contenuti e di linguaggi che fanno di ogni opera un microcosmo inventivo.
Tra pittura e letteratura
Accanto all’opera letteraria, Isgrò sviluppa anche l’arte pittorica e dà vita a mostre, come quella ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo o la precedente grande esposizione all’Università di Parma nel 1975, che hanno riscosso un plebiscitario consenso, collocando l’artista tra i maggiori maestri della pittura contemporanea. Isgrò mira a potenziare la parola e l’immagine attraverso il loro contrasto, per cui egli parte dallo studio del significato dei segni per imprimervi finalità poetiche. Sul piano tematico, emblematica è Jaqueline, uno dei capolavori artistici, che rappresenta il tema dell’assenza e del silenzio, che Isgrò concepisce in maniera radicalmente opposta rispetto ai concettualisti. Infatti, mentre questi sembrano rassegnati all’impossibilità di comunicare, Isgrò suggerisce di scoprire, nel dramma della comunicazione negata, la necessità della comunicazione come un fattore irrinunciabile per l’artista.
Anche lui, intellettuale della diaspora, custodisce nel cuore sempre la sua Sicilia, particolarmente la sua Barcellona, dove frequenti sono le sue discese, quasi a voler riossigenarsi per poter ridonare i valori che la sua terra gli ha impresso nell’anima. Così, ha voluto impiantare, nella piazza della stazione vecchia, un gigantesco seme dorato che, con la sua punta affilata rivolta verso l’alto, sembra invocare il cielo, simbolo del seme dell’arte, della vita, di tutto ciò che di positivo è esistito o potrà nascere nella sua terra natale. Tale segno storicamente simboleggia l’attività tradizionale degli “spiritara” locali, che a Barcellona hanno creato la ricchezza e il benessere economico della città; su scala siciliana esprime, oltre che l’operosità della gente di Sicilia, anche il simbolo sublime e incommensurabile della vita stessa che si sviluppa, matura, perisce ed eternamente si rinnova sotto il calore dorato del Sole, espressione del grande Artefice dell’universo. Sono racchiusi in questo seme storia e leggenda, gioia e dolore, vita e sogno, arte e mito, insomma la memoria globale di una terra, di cui Isgrò anela la rinascita sotto la luce dell’Arte e della cultura.
In tal senso, la conclusione è scontata: oggi, in quest’epoca di imprevedibili cambiamenti in cui l’uomo ha stravolto la propria identità, solo l’Arte può far rinascere l’Essere, esaltare quel piacere di vivere che è piacere creativo. Nel romanzo L’asta delle ceneri, in un’Italia sfasciata e corrotta, conflitti leghisti e superiori interessi, assistenzialismo siciliano e neocapitalismo lombardo, formazione e informazione, malignità grottesche e false tragedie traspaiono dalla rivelazione di un Gesù reincarnato in incognito, accanto a un sociologo esperto di erari e di modernità, a un senatore e a un commerciante messinese che scoprono di avere un malavitoso, donne e mogli in comune, e conferiscono al romanzo un’atmosfera esilarante e al tempo stesso inquietante. Il viaggio in un’Italia torpida e lacerata coglie il disorientamento di una stagione cupa e decadente,in cui la storia italiana non riesce a liberarsi dalle tentazioni di meschinità, disonestà e di squallore che scandiscono le vicende della vita intristite nel buio della ragione. Le pagine risultano disseminate di situazioni paradossali, di incisi provocatori e di risposte audaci che implicano soluzioni beffarde, attraverso cui dispiega il volo un assoluto bisogno di libertà totale dello scrittore, che estende l’avventura creativa fino alla discesa psicologica, alla circoncisione sociologica e alla degenerazione in atteggiamenti bizzarri, come quello di Feminò Zammara che si reca in Chiesa ad invocare santi declassati a mediocri comparse, privi del tradizionale potere miracolistico e faticosamente impegnati in azioni normali.
L’io narrante (l’alter ego di Isgrò) opera perforazioni nel guscio delle finzioni o nelle superfici del reale, sempre pronto all’ascolto, pur nei molteplici travestimenti in fiammifero, biscotto, orologio a cucù, in un raggomitolarsi esplosivo di intrecci in cui alla fine trionfa la cifra surreale della beffa. L’ordinarietà fattuale si carica di timbri burleschi e di eroi comici rabelaesiani e la cronaca accorda i segmenti della vita e della natura con le vibrazioni della magia e della favola. In tale contesto, si inseriscono personaggi come il pittore De Angelis, “grande specialista dello schiaffo”; il Buonarroti, “seduto nel suo sarcofago in Santa Croce”; l’imperatore del Cipango, ex ballerino e attore, intento a “mettere il freno a Dio”; Galilei, vigilante sull’universo con i fili della sua barba; Daniele Berchet, convinto sostenitore che i Siciliani sono in guerra tra loro anche per una cassa da morto. Scorre un caleidoscopio di stravaganza che l’io coglie sia tra i vivi che tra le ombre, dove si susseguono personaggi ambigui e vicende divaganti e divertenti. In tale registro si muovono anche i protagonisti del romanzo Polifemo, tra il reale, il comico, l’aristofanesco e il grottesco. Polifemo Zammara è l’eroe, o antieroe, di questo moderno “romanzo comico”, che si oppone al suo antagonista Ulisse. Isgrò vede nella figura di Ulisse l’esponente più alto della civiltà: egli, l’astuto, è visto come un “pretore di legno”, un “giudice bisbetico”, “un fantasma enciclopedico”. Il romanzo si colloca in un infinito presente, quasi a voler cancellare ogni prospettiva di crescita. Col suo “occhio televisivo”, Polifemo è in grado di riscattare figure come Reagan e Gorbaciov, Eugenio da Messina e Madame Bovary, in una Sicilia planetaria in cui gli spettri del passato sembrano meno ingombranti dei fantasmi del futuro.
Un alto vigore inventivo, che ricorda l’ultimo Palazzeschi, fa proliferare continuamente una serie innumerevole di episodi, scene e battute, attraverso cui lo squallore del presente viene indagato con l’occhio ironico e disincantato di un emblematico protagonista, attualizzato, del mito. Frequenti richiami tra realtà e mito caratterizzano particolarmente le opere letterarie di Isgrò, come nell’Orestea di Gibellina, che ricorda il titolo della trilogia intera di Eschilo, con l’assassinio di Agamennone per opera di Clitennestra. Ai personaggi e agli intrecci tradizionali, l’autore aggiunge altri personaggi (come il Carrettiere e l’Arciprete), che imprimono all’opera una valenza emblematica di notevole attualità. Composta per metà in italiano e metà in siciliano, lo scrittore trasforma la tragedia in un sogno, e il grande conflitto tra Agamennone e Clitennestra risulta come una conturbante epopea consumata nella società contemporanea. Il testo, perciò, nella consapevolezza della impossibile riproposizione del mito greco, nella originaria versione, punta alla rappresentazione di una storia di terremoti (e Gibellina fu l’epicentro del terremoto del 1968 nella Valle del Belice, in Sicilia), di esilio e di tradimento che ripropone in termini nuovi la tragedia antica, vista con l’ottica della sicilianità attuale.
Con L’oratorio dei ladri, Isgrò ritorna alla sua primordiale vocazione alla poesia pura. Tuttavia, non si tratta di un recupero tecnico, ma sullo spazio poetico egli riesce ad assorbire altre esperienze del suo percorso creativo, in particolare il teatro. Nel poemetto di apertura, Gibella del Martirio, il poeta ricorda i quindici anni trascorsi dopo il terremoto del Belice. È un poemetto originale che, al di là della oralità, si presta anche alla rappresentazione scenica. Il componimento si incentra su una figura femminile fisionomicamente mutante, che si muove e recita tra disastro e creazione, spinta a credere alla rinascita della vita nella terra sconvolta dal terremoto. Notevole la conclusione, in sintonia con l’intera opera di Emilio Isgrò, di un presente che tende a seppellire l’arte: con i suoi strumenti di bellezza e di denuncia, l’autore esprime una reazione, quasi biologica, che riafferma il primato assoluto della poesia e la lodevole arte del “puparo”, incarnazione emblematica dell’attività del poeta. Ultimamente è uscito, di Isgrò, Brindisi all’amico infame. Si evidenzia qui un Isgrò ancora sorprendente e rivoluzionario. Egli che, ai tempi del Gruppo ’63, s’è inventata, nell’alveo dello sperimentalismo, una via sua mediante un crogiolo di parole tratte dalla stampa quotidiana e collegate in maniera apparentemente senza senso, come gli anni confusi della contestazione giovanile, con questo nuovo libro sorprende ancora, non solo in senso tecnico-metrico-stilistico, ma anche nell’uso di uno strumento espressivo ancora autonomo e innovativo, testimonianza di una poesia simmetrica alla post-modernità. Come dice la scheda editoriale, sono “tre poemetti” dove Emilio Isgrò, giocatore di parole e di metafore, mette in scena storie di una terra, la Sicilia, troppo addolorata per essere sincera, e dove anche la commedia degenera in tragedia”.
Fantasiosa e parodica, drammatica e ironica, la poesia di Isgrò orchestra memorie senza elegie di una infanzia edenica, diventata a poco a poco apprendistato luttuoso della vita. Per cui si può affermare che il brindisi si trasforma in requiem e il requiem in brindisi Emilio Isgrò nell’Autocur-riculum, preparato per i suoi ottant’anni, un particolare ricordo incuriosisce il lettore. È un ricordo della sua infanzia siciliana, una proiezione del Rigoletto cinematografico interpretato da Tito Gobbi e Lina Pagliughi in una copia tanto deteriorata che, scrive Isgrò, «restava quasi niente, ma quel niente era sublime». Proprio come accade nelle famose “cancellature” susseguitesi in oltre mezzo secolo attraverso un’opera di sottrazione e sovrapposizione che ha interessato ritagli di giornale e l’Enciclopedia Treccani, i Detti di Confucio e la Bibbia, fino al recente intervento sui Promessi Sposi. I segni neri o le tracce di vernice bianca scandiscono una lettura sorprendente riecheggiante, del tutto una discendenza siculo- greca, come suggerisce il barcellonese Isgrò. Dal sofista Gorgia a Pirandello, sintetizza svagatezza apparente l’artista. «Perché nel dopoguerra per noi giovani siciliani la montagna che ci stava di fronte era lui, Pirandello», aggiunge. A Milano, Isgrò vive dalla metà degli anni Cinquanta, ad eccezione del periodo in cui, non ancora trentenne, ha diretto le pagine culturali del Gazzettino di Venezia. A proposito della polemica con l’ex Pink Floyd Roger Waters smussa la lieve controversia, nata dalla tecnica della cancellatura tra il musicista, che sulla copertina di un suo cd, aveva usato la tecnica della cancellatura. e lo stesso Isgrò «Sotto la cancellatura – dice l’artista – la parola non scompare, ma continua a brulicare con più forza. Non si cancella per negare il testo, ma per capirne meglio ils ignificato, per accorgersi di che cosa c’era prima. È un modo per esaltare la parola, non per contestarla. Questo, del resto, è il senso del mio Cristo cancellatore, ora entrato nella collezione permanente del Centre Pompidou a Parigi. Attribuire al Cristo la facoltà di cancellare significa riconoscere in Lui il giustiziere e, nello stesso tempo, il redentore. In maniera più o meno consapevole, si cancella sempre per mettere in salvo, per custodire».
Anche nelle conversazioni Isgrò si rivela un maestro, Si proclama ignaro di teologia, ma all’inizio della sua attività di artista visivo si trova il quadro – che all’epoca fece scalpore – nel quale Dio, nella sua perfezione, viene paragonato a «una Volkswagen che va… e va… e va…». Isgrò sorride, sottolineando come a lamentarsi, in quel lontano inizio degli anni Sessanta, furono più che altro i portavoce della casa automobilistica. «Oggi come allora – aggiunge – farei una certa fatica a sostenere di non credere in Dio, forse perché tra fede e ragione non sono mai stato capace di tracciare un confine preciso. Lo so che sembrerà singolare, come molto di quello che dico e che faccio, ma sono convinto che l’arte mi abbia salvato da Dio: non perché mi abbia allontanato da Lui, ma perché mi ha permesso di credere in un altro modo, molto diverso da quello sperimentato da sant’Agostino o da San Tommaso d’Aquino. Qualche critico, bontà sua, ha voluto riconoscere nelle mie cancellature un’attitudine mistica. Non mi spingo a tanto, ma di sicuro l’interrogativo sulla trascendenza è presente da sempre nel mio lavoro. In forma un po’ intermittente, lo ammetto. Ma chi si interroga sulle parole e sulle immagini non può fare a meno di chiedersi se e come la ragione possa mai cancellare la fede».
Esordiente come poeta già nel 1956, Isgrò ha pubblicato romanzi e firmato importanti testi teatrali, in particolari per le Orestiadi svoltesi a Gibellina – la città-simbolo del terremoto del Belice – nei primi anni Ottanta. «Per me anche l’arte visiva è stata la prosecuzione della poesia con altri mezzi – racconta –. Non avevo messo in conto di diventare un pittore, ammesso che lo sia veramente diventato. Il giornalismo, nel quale ero entrato giovanissimo, era un lavoro che mi piaceva molto e che, ne sono convinto, avrei continuato a ritenere appagante anche con il passare del tempo. A volte ho l’impressione che, da un certo momento in poi, tutto mi sia capitato un po’ per caso, anche se si tratta di un caso che io stesso avevo in buona misura predisposto. Molto ha influito il contesto storico. Nell’Italia del boom economico si stava ponendo una nuova questione linguistica, rispetto alla quale le immagini rivestivano un ruolo sempre più rilevante. All’improvviso era come se le parole non bastassero più e la poesia, di conseguenza, dovesse trovare nuovi modi per esprimersi: il cinema nel caso di Pasolini oppure l’arte visiva in quello mio e di molti altri. Ma non è stata una resa delle parole alle immagini, semmai il contrario. Pensi a quello che è accaduto in pittura. Una volta, se si voleva liquidare un artista figurativo lo si definiva “letterario”, come se fosse un limite. Oggi la proliferazione delle immagini rende sempre più indispensabile il ricorso alla parola. Se non ci fossero le didascalie, per esempio, come faremmo a distinguere una guerra dall’altra? L’immagine ha trionfato omologandosi. Per recuperare il senso bisogna passare di nuovo dalle parole, specialmente da quelle che credevamo di aver cancellato».
La pittura, il cinema, ma anche il melodramma, come in quell’antica proiezione dell’evanescente Rigoletto (a proposito, nella sua carriera Isgrò vagheggiato la realizzazione di un film che si cancellasse da sé sotto gli occhi degli spettatori). «Sì, il mio lavoro è stato un mezzo per restituire alla lingua italiana una dimensione internazionale simile a quella garantita dalla diffusione del melodramma – ammette –. Ma dal punto di vista linguistico la cancellatura ha anche la funzione, non meno preziosa, di portare alla superficie ciò che accomuna persone e culture differenti. Che cosa fanno, mettiamo il caso, un italiano e un tedesco quando si incontrano e non conoscono l’uno la lingua dell’altro? Vanno a cercare le parole o a volte addirittura i suoni comprensibili a entrambi. Cancellano tutto il resto e si soffermano su quelle schegge di senso che rendono possibile la comunicazione e la condivisione». Come quelle che il mediterraneo Isgrò ha isolato in un’opera ispirata a Meister Eckhart, il grande mistico del Medioevo germanico. Una successione di tratti neri che risparmiano qualche segno di interpunzione e due sequenze di frase. La prima è «solo la mano che cancella», la seconda «può scrivere il vero».
Prof. Carmelo Aliberti