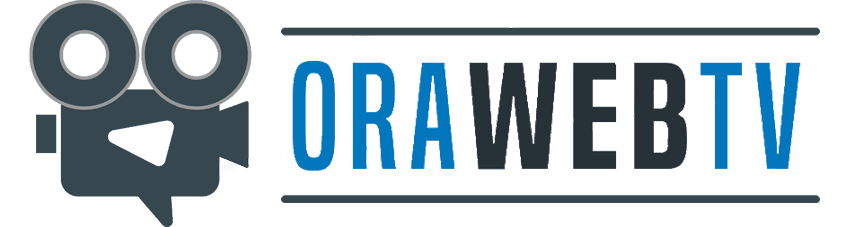Salvatore Quasimodo nacque in provincia di Ragusa, a Modica, il 20 agosto del 1901. Il padre Gaetano era capostazione delle Ferrovie dello Stato e, per questo motivo, l’infanzia di Salvatore fu caratterizzata da un peregrinare abbastanza frequente nelle province siciliane. Il primo trauma della sua giovinezza lo ebbe a sette anni, quando un tremendo terremoto colpì Messina (28 dicembre 1908). Subito dopo questo tragico avvenimento, il padre di Salvatore fu trasferito nella città dello Stretto; la famiglia lo seguì e vissero, provvisoriamente, in un vagone merci fermo su un binario morto della stazione.
Gli studi nelle scuole elementari e medie li condusse in modo regolare; successivamente, s’iscrisse all’Istituto Tecnico Matematico-Fisico, prima a Palermo, poi a Messina, all’incirca tra il 1916 e il 1917.
È in questi anni che il giovanissimo Quasimodo inizia a scrivere: sono poesie caratterizzate da un’influenza dannunziana e pascoliana, ancora senza un linguaggio proprio, ma con un lessico caratterizzato dall’uso di parole sciatte e povere. Egli, molto probabilmente, non conobbe da subito i grandi poeti del tempo. Era noto che, in quel periodo, la Sicilia, essendo un’isola, era caratterizzata da un certo isolamento culturale. Ancora nel 1917 fondò una rivistina letteraria, che chiamò “Nuovo Giornale Letterario”, sul quale pubblicò le sue prime composizioni. Nel 1919 si trasferì a Roma per iscriversi al Politecnico. Vennero subito a galla le difficoltà di carattere economico, per le quali non riuscì a pagarsi gli studi.
Decise allora di lavorare e studiare contemporaneamente; ma i frutti
del suo lavoro saranno utili solamente per la sua sopravvivenza e lo
costrinsero ad abbandonare gli studi. Egli lavorò anche come impiegato
alla Rinascente, dalla quale venne “licenziato come organizzatore ed
esecutore dell’ultimo sciopero italiano (il giorno precedente l’applicazione della legge fascista contro gli scioperi)”, come disse lui stesso, che amò gloriarsi dell’episodio da vero antifascista.
Nel 1926 è assunto come geometra dal Ministero dei Lavori Pubblici e
assegnato al Genio Civile di Reggio Calabria. Qui riprese anche la sua
attività letteraria. Più tardi, Quasimodo si trasferì a Firenze presso il cognato e scrittore Elio Vittorini, che ebbe la fama di “scopritore di talenti”. Egli fece conoscere a Salvatore due amici anch’essi letterati: Eugenio Montale e Alessandro Bonsanti. Quest’ultimo si interessò molto alle opere di Quasimodo, tanto che ne fece pubblicare 3 (“Albero”, “Prima” e “Angeli”) sulla rivista “Solaria” nel marzo del 1930. Nello stesso anno e sulla stessa rivista, apparve la prima
edizione di Acque e terre. La versione definitiva della raccolta è del 1942; essa parla della terra dell’autore, la Sicilia, la stessa della favolosa infanzia che egli rimpiange.
Nel 1931 Quasimodo fu trasferito
al Genio Civile d’Imperia. Qui collaborò con la rivista “Circoli”, dove pubblicò le poesie che andranno a costituire il prestigioso Oboe sommerso, uscito poi nel 1932 per le edizioni “Circoli”. Questa raccolta ebbe un successo incredibile, tanto da consacrare Quasimodo come uno dei più grandi poeti del tempo. Con questo libro ci si trova in pieno clima ermetico e, sarà più tardi molto discutibile se Quasimodo sia l’iniziatore dell’ermetismo, o se tale paternità sia da attribuire a Montale e/o Ungaretti. Nel 1934 si trasferì a Milano,
dove non trascorse un bel periodo. Nonostante ciò, in questa città
trovò l’ispirazione necessaria alla stesura della raccolta Erato e Apòllion che uscì nel 1936. Intanto dopo aver studiato il latino e il greco, tradusse in italiano alcuni libri dell’Eneide di Virgilio, di Orazio, ma, soprattutto, i frammenti rimasti dei maggiori poeti greci, rielaborati in maniera personale e confluiti nella raccolta I lirici
greci (1940). I tempi mutarono: ormai si era in piena guerra. Lui fu un antifascista convinto e, perciò, fu malvisto e controllato. Dopo l’8 settembre visse in semiclandestinità e si trasformò in poeta della guerra e della Resistenza.
La sua poesia fu conosciuta in tutto il
mondo come quella ispirata dalle macerie e dai corpi dei compagni
martoriati dai fascisti e dai nazisti, di cui una prima testimonianza
è rappresentata dalla raccolta Ed è subito sera (1942). Giorno dopo
giorno (uscita nel 1947) è in questo senso la raccolta più intensa e
autentica del dopoguerra italiano e, forse, europeo: le venti poesie
che la compongono, infatti, sono state scritte fra l’inizio del ’43 e la fine del ’45, il periodo cruciale della guerra. Nel 1945 Quasimodo si iscrisse al Partito Comunista Italiano (PCI), ma ci militò per poco tempo. La sua adesione fu più emotiva che altro, anche se Quasimodo resta sempre un uomo di sinistra, legato al comunismo. Tra la fine degli Anni Quaranta e gli Anni Cinquanta, pubblicò La vita non è sogno (1949); Il falso e il vero verde (1956). Nel 1958, vinse un viaggio in URSS grazie al premio Viareggio aggiudicatogli per La terra
impareggiabile. In questo Paese fu colpito da un infarto, che lo
costrinse ad essere ricoverato in ospedale fino alla metà del 1959. Il
1959 è l’anno della più bella affermazione del poeta: il 10 dicembre,
a Stoccolma, gli fu assegnato il premio Nobel per la letteratura. Ma
tale riconoscimento gli fu molto contestato, soprattutto da una certa
critica del Nord, che giudicò la sua poesia immeritevole
dell’importante Premio, accusandola di provincialismo.
Ciò turbò molto il poeta che, nel 1963, mise a tacere i suoi denigratori con la
raccolta conclusiva “Dare e avere” (1965), nella quale affrontò gli eterni conflitti dell’uomo, trafitto dal male cosmico e sospeso sulla dolorosa scena del mondo, in difesa della dignità dell’uomo, di fronte
ad un destino di sconfitta. Salvatore Quasimodo morì per infarto a
Napoli nel 1968. Dopo la morte, Mondadori pubblicò in un grosso libro Tutte le poesie, contenente anche il “Discorso sulla poesia”, pronunciato nella circostanza dell’assegnazione del Premio Nobel, in cui il poeta, reindossando i panni del poeta-vate, lanciava il messaggio della
necessità, dopo i disastri materiali e morali provocati dalle guerre,
di ricostruire l’uomo, una nuova società, liberata dagli odi e fondata
sull’amore universale, con le armi della poesia.
La poesia – Le opere
Nell’avviare operazioni esegetiche della poesia di Quasimodo, la
critica è rimasta spesso condizionata da una pregiudiziale impressione
negativa o settaria, per cui, nonostante il Nobel assegnatogli nel
1959 e la vasta fortuna di pubblico riscontrata a livello nazionale e
internazionale, l’opera del poeta siciliano è rimasta spesso vittima
di giudizi sommari, non sempre suggeriti da valutazioni obiettive, ma
per lo più ispirati da ragioni di gruppo politico, da diversità di
teorizzazioni estetiche o da meschine e arroganti invidie verso l’uomo
del Sud, trasmigrato altrove con la valigia di cartone e con quattro
versi in tasca. Sul piano squisitamente letterario, l’etichetta di
ermetismo, che gli è stata a lungo sinonima, relegava la sua
produzione lirica nel guscio restrittivo di una stagione marginale,
individualistica e provinciale della nostra storia letteraria e perciò
ne riduceva l’interesse tematico nell’ambito dei circuiti autarchici
della nostra cultura, eludendo volutamente la carica ribellistica e
catartica del suo messaggio. In realtà, occorre subito evidenziare che
l’appartenenza del poeta all’ermetismo fu soprattutto registrata
nell’ambito della parola, particolarmente in talune peculiarità
linguistico-strutturali del codice ermetico, come l’insistenza
metaforica, l’uso della preposizione “a”, astrattamente scandita con
plurime variazioni semantiche, l’invadenza dell’apostrofo all’interno
della novità metrica e prosodica, governata da una mineralità segnica
e da una inedita musicalità interna, riconducibili alla lezione
innovatrice di Ungaretti, ma che, intrecciatasi in Quasimodo con le
ragioni della storia, si tramuta in operazione poetica, priva di
preziosismi espressivi e scevra di ogni forma di indecifrabilità
ideale, per privilegiare, invece, la solennità della poesia drammatica
sotto l’impulso di una tentazione epica moderna, sostenuta dal
vigoroso linguaggio del reale e, perciò, non facilmente catalogabile
in una formula lapidaria definitiva. Già, dopo le prime prove, la
critica tendeva a non riferire più la poesia quasimodiana all’area
dell’ermetismo, ma la ricollocava sul pentagramma della poesia pura
contemporanea. Carlo Bo, con estrema autorevolezza critica, affermava che «le cose, a distanza di tempo, hanno preso un altro rilievo e, al contrario di quanto è stato sempre superficialmente divulgato, il
Quasimodo ci appare come un compagno di strada dell’Ermetismo, come uno che si è trovato a vivere in un dato momento e per spirito di
cameratismo ha creduto di dover condividere motivi critici e posizioni
che in fondo contrastavano con la sua vera natura. Quasimodo (continua
Bo) non vive legato, com’è stato in ogni momento del suo lavoro, al
mondo dell’infanzia e soprattutto al patrimonio delle memorie
naturali, di cui restano documenti capitali le liriche per la madre
(“Lettera alla madre”) e per il padre (“Al padre”) e tutto il repertorio dei luoghi familiari che, per una rara capacità di
identificazione, conservavano per lui un potente significato culturale». Se in Acque e terre (la raccolta dell’esordio comprendente le poesie composte tra il 1917 e il 1930), traspariva una certa
temperie provincialistica con evidenti influenze dannunziane e pascoliane, tuttavia già allora il Nostro rivelava una grande capacità di ripiegamento e di lettura delle proprie radici interiori e un affilato sentimento del reale, attraverso cui filtrava, come afferma
Giuseppe Zagarrio, “La misura storica della provincia siciliana” e la
provincia dell’anima, quella cosiddetta “metastorica e platonico-agostiniana”, dove il male della terra si fonde con la
trepida vocazione alla morte, perché sciolga il poeta da tutte le
creature e lo liberi dall’inferno, in cui questi si riconosce condannato a vivere.Soprattutto in “Vento a Tindari”, il vertice più alto della raccolta, il poeta riesce a sollevare la cronaca di un
autobiografico frammento temporale, realisticamente vissuto e
favolosamente vagheggiato, a un canto di una triste intensità lirica
mediante la griglia di una parola limpidissima, librata in un clima di
trasparente assolutezza, dove elegiacamente si accumulano le note
desolate dell’irrisolto dissidio “vita-morte” e dove il “topos”
geografico, Tindari, diventa metafora dell’angosciosa condizione di
esilio, fisico e spirituale, del poeta dalla sua isola ed
emblematicamente da una più cooptante dimensione metafisica.
L’evocazione dell’ideale lacerto topografico, carica di ambiguità e di
indetermina-tezza, è percorsa da riferimenti mitologici, cari alla
fantasia del poeta, in cui si evidenzia già quella tendenza al mito,
che solleva in un’atmosfera di vaghezza e universalità la poesia del
“primo Quasimodo”, scandita da uno stile denso di armonie,
aristocratico, anche se vigoroso e allusivo:
VENTO A TINDARI
“Tindari, mite ti so
tra larghi colli pensile sull’acque
dell’isole dolci del dio,
oggi m’assali
e ti chini in cuore.
Salgo vertici aerei precipizi,
assorto al vento dei pini,
e la brigata che lieve m’accompagna
s’allontana nell’aria,
onda di suoni e amore,
e tu mi prendi
da cui male mi trassi
e paure d’ombre e di silenzi,
rifugi di dolcezze un tempo assidue
e morte d’anima.
A te ignota è la terra
ove ogni giorno affondo
e segrete sillabe nutro:
altra luce ti sfoglia sopra i vetri
nella veste notturna,
e gioia non mia riposa
nel tuo grembo.
Aspro è l’esilio,
e la ricerca che chiudevo in te
d’armonia oggi si muta
in ansia precoce di morire;
e ogni amore è schermo alla tristezza,
tacito passo nel buio
dove mi hai posto
amaro pane a rompere.
Tindari serena torna;
soave amico mi desta
che mi sporga nel cielo da una rupe
e io fingo timore a chi non sa
che vento profondo m’ha cercato”.
Sincronicamente trascritto o memorialisticamente ricreato, il
componimento, oltre che collocarsi come la sintesi tematica della
ricerca iniziale di Quasimodo, come sopra indicato, riflette anche
quella tendenza alla mitizzazione della vicenda autobiografica, in cui
Quasimodo rinviene, nel suo itinerario affettivo e formativo, quella
ristretta cerchia di amici, tra cui spiccano i nomi di Salvatore
Pugliatti (futuro rettore dell’Università di Messina), Giorgio La
Pira, Vann’Antò (Giovanni Antonio di Giacomo), Antonio Saitta,
Vincenzo Palumbo, Nino Pino e altri pochi intimi, primi estimatori e
successivamente entusiasti sostenitori della grandezza poetica di
Quasimodo, con i quali il Nostro ebbe modo di confrontare e, nel
contempo, consolidare, oltre che la sua dimensione lirica, anche gli
ingredienti della sua formazione culturale di impronta laica,
nostalgicamente carente di un punto di riferimento metafisico nelle
istanze esegetiche della cosmologia, come si può dedurre dalle
eterogenee culture degli elementi del “gruppo” e come meglio traspare
dal carteggio Quasimodo-La Pira, a cui disperatamente confessava:
«Beato tu, che hai una fede. Io, purtroppo, non posso credere». Nel
travagliato contesto di una correlata temperie spirituale, nel 1932,
all’uscita di Obòe sommerso, la critica, dentro il rosario figurale e
tecnico di un apparente parnassianesimo, individuò la ferita
sensibilità del poeta nelle istintuali fiocinate ultrafaniche, le
sillabate cadenze di un autentico tormento, propulsionato dalla crisi
etica dell’uomo contemporaneo, contrapposto alla scoperta, alla radice
della propria angoscia, di un ordine di più marcata estrazione
pascaliana, trapassando da una convinta, anche se effimera, conoscenza
di se stesso, al desiderio incontenibile di “un’eterna” presenza. In
realtà, sul diagramma dei motivi sviscerati dalla critica, è possibile
cogliere, nelle complesse variazioni temporali e spaziali, del
rapporto tra micro e macrocosmo, credibili ipotesi di collegamento tra
mondo della storia e infinita spazialità del Cosmo, tra creature umane
colte nella precarietà esistenziale e nella plenaria assolutezza di
Dio; per cui Giuseppe Zagarrio vi scorge un momento del “romanzo
lirico del tema religioso”, evidenziando come il termine “Signore”
diventi vocabolo emergente del lessico quasimodiano, dentro cui si
dipana il dramma delirante dell’io che precipita irreversibilmente
nella voragine temporale della solitudine, nella brace del dubbio e
del dolore, dopo aver sofferto la disgregazione di una concezione
ideologica, tesa a identificare l’essenza di Dio con il movimento
dinamico del Cosmo, in una consustanziale ottica misticistica
dell’esistenza. Allora il poeta, che avverte dentro di sé la
combustione dei conati metafisici e l’incenerimento delle ideologie
allora apparentemente più evolute, si muove ora nell’area di uno
straziante dualismo di sapore kierkegardiano, per cui percepisce il
simulacro divino oltre gli orizzonti dell’umano e constata che l’uomo
è solo con il suo tormento di esistere e di vivere la morte
quotidianamente fuori di Dio schiacciato dal “tedium vitae” e dal peso
della sconfitta dinnanzi al mistero:
LA MIA GIORNATA PAZIENTE”
La mia giornata paziente
a te consegno, Signo
non sanata infermità,
i ginocchi spaccati dalla noia.
M’abbandono, m’abbandono,
ululo di primavera,
è una forestanata nei miei occhi di terra”
(“La mia giornata paziente”)
In Erato e Apollion (1936), Quasimodo si ricollega più direttamente a
Montale per quello straziante sentimento di decadimento e di aridità,
di staticità lacerante per un destino segnato, che balena nello
scintillio delle luci e nelle apparenze delle figure, dei paesaggi e
dei colori evocati, dove è impossibile porsi in ascolto di un’eco di
consolazione allo strazio della terra. Nuovo e suo è invece quella
propensione all’inermità, alla rassegnazione e alla resa dinnanzi alle
insondabili direzioni del cosmo, percorsa da un acre rigore morale e
articolato con una immediatezza espressiva che traduce struggentemente
le alternanze del sentimento di tristezza dell’uomo solo in un’urgenza
di fuga verso l’area mitica dalla patria del bene e del male della
terra, alla ricerca di una mai rinnegata innocenza:
Del peccatore di miti
ricorda l’innocenza o Eterno; e i rapimenti,
e le stimmate funeste.
Ha il tuo segno di bene e di male,
e immagini ove si duolela patria della terra”.
(“Del peccatore di miti”)
Accanto a questa linea tematica centrale, vibrano le schegge
inquietanti delle intermittenti discese nell’endoterra della sua
realtà isolana, attraverso cui la riemersione di un paesaggio fisico e
creaturale, gravido di segrete sinergie lirico-spirituali, si tramuta
in occasioni di accostamento simbiotico al plasma diacronico dei suoi
mutamenti interiori, al paradiso perduto dell’infanzia, richiamato
alla coscienza lirica dall’avventura memoriale dei ritorni e riciclato
nella pregnanza delle contingenze quotidiane, costellate di
problematicità, di incertezze, di infernali cadute e di abissali
naufragi, con la elegiaca atmosfera della favola. Qui, all’interno
della dialettica delle opposizioni “morte-amore”, “vita-morte”,
“patria-esilio”, “bene-male”, “isola-geografica”, “isola-uomo”,
incominciano a delinearsi nitidamente tutti i miti del poeta,
univocamente fusi nella costante quasimodiana dell’atteggiamento
mitico di decrittazione e di valutazione della realtà:
“Mio amore, io qui mi dolgo
senza morte, solo”.
(“Canto di Apòllion”)
“Un’eco ci consoli della terra
al tardo strazio amata;
o la quiete geometrica dell’Orsa”
(“Sul colle delle Terre Bianche”)
Il poeta di Ed è subito sera (1942), accanto alla sua storia interiore
di strazi, di dubbi, di sconfitte, di inferni, di solitudine, di
esili, di ansie e di slanci mitici, andava maturando anche la
coscienza inquieta di una resistenza passiva dinnanzi ai disastri
politici della tragedia europea delle dittature e della guerra, scorge
in realtà l’uomo impegnato a proseguire la ricerca di una verità
interiore, con cui riempire il vuoto storico, attraverso un rigenerato
rapporto del poeta con le cose. Particolarmente in Nuove Poesie si
avverte un certo mutamento di rotta tematico e sintattico-espressivo,
con una trasformazione per gradi, senza repentine inversioni teoriche.
Ora il poeta si accosta più concretamente alla realtà e quella poesia
trobadorica ricettiva delle proprie esperienze spirituali, scandite
con elitari strumenti significanti e racchiuse nelle classiche
risonanze delle pause, ora si popola di ben definiti ingredienti
realistici, di specifici luoghi geografici, quali l’Adda, il Serchio,
Piazza Fontana, ecc., e della presenza di persone reali, di sofferte
meditazioni sulla miseria sociale della Sicilia che non è più l’Eden
dell’infanzia e dei miti, ma quella dei tempi più bui e dolorosi della
sua storia, anche se l’anima antica della sua isola palpita ancora
nella dolcezza dei suoi e nella musicale risonanza del paesaggio:
“Il marranzano tristemente vibra
nella gola al carraio che risale
il colle nitido di luna, lento
tra il murmure d’ulivi saraceni”.
(“Strada di Agrigentum”)
Qui persistono ancora frammenti di tematiche ermetiche, accanto a
sciolti legami sintattici, ma il periodo risulta più articolato grazie
all’introduzione delle subordinate, il verso obbedisce ad una metrica
quantitativa, in cui si coagula la lezione classica
dell’endecasillabo, pausato con una ben orchestrata accentazione, e si
innestano abilmente allitterazioni, variazioni foniche con cadenze
piane in fine di verso che producono armonie diverse, palpitanti
messaggi nuovi e più profondi. Si fa strada nell’universo poetico
quasimodiano la coscienza del tempo dei mostri della storia europea e
mondiale, contro l’astratta poetica della parola pura e contro le
teorie della metafisica assenza dell’io, ma affiora anche l’utopia di
un nuovo messaggio etico e sociale per la rigenerazione umana del
mondo. Con Giorno dopo giorno (1947), dinnanzi allo scenario
pietrificato della guerra e della morte che turbano profondamente la
coscienza del poeta, s’innalza l’ira di rivolta contro la mostruosità
del presente in componimenti di elevata resa ascetica, talvolta
inficiata dall’intonazione oratoria. Ora i fantasmi degli antichi miti
lirici si sono disfatti e la storia delle vittime e dei carnefici
richiede nuovi miti e più alte utopie, come la fede nella poesia in un
mondo che l’ha rinnegata, come forza vitale per la resurrezione
dell’uomo che la storia ha tradito, torturato, oltraggiato e ucciso,
come superstite speranza oltre ogni razionalità che il poeta ora
continua a coltivare come “operaio di sogni”, in un rinnovato impegno
civile, in cui la Sicilia riappare come metafora del “male di vivere”
e come simbolo di un’umanità irredenta. Sul mondo si è abbattuto il
cataclisma della guerra e il poeta transvola dall’indignazione del
cuore alle macerie delle città, ai brandelli dell’uomo trucidato ai
“pali del telegrafo” e il dolore storico fornisce al poeta gli
strumenti espressivi della quotidianità, dell’universalità dei
catastrofici rivolgimenti, per cui la melica monodia prosegue e si
discioglie nella coralità del canto, il monologo viene sostituito da
una discorsività dialogata con l’obbligata sostituzione della
metafisica dell’io alla formulazione teorica del dialogo apicizzante
con finalità etico-didattiche di severa condanna della straripante
follia fratricida:
“E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento”.
(“Alle fronde dei salici”)
… S’è udito l’ultimo rombo
sul cuore del Naviglio. E l’usignolo
è caduto dall’antenna, alta sul convento,
dove cantava prima del tramonto.
Non scavate pozzi nei cortili:
i vivi non hanno più sete.
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:
lasciateli nella terra delle loro case:
la città è morta, è morta”.
(“Milano, agosto 1943″)
Versi che s’incidono quasi come un epitaffio sul veloce scorrere
dell’uomo verso la morte, la morte dei sogni e la morte cosmica, in
cui si espande l’estrema verità del mondo, individuato come sepolcro
metastorico della morte storica e, sull’onda del negativismo della
disperata denuncia, irrompe un viscerale urlo di ribellione che
all’epica della solitudine associa l’antimito del sentimento
dell’università del dolore, all’insegna di una sillabata aspirazione
al moralismo che, nel senso utopico della speranza, anela
all’inveramento di un modello di società più libera e giusta, fondato
sulla pietà con cui si identifica la religione laica di
Quasimodo.L’apparente semplificazione della strumentazione tecnica,
con una sintassi parametrata sulle comuni sintesi del linguaggio
parlato, non esente tuttavia da formule ermetiche e risolta spesso in
una prosa irta e ad alta densità poetica, idonea a scandire le
profetiche proiezioni dell’impegno civile, rappresenta il modo nuovo
di far poesia del Nostro.Alla ricorrente distinzione, operata dalla
critica tra un Quasimodo ermetico della prima stagione, ripiegato a
captare le angosciose rifrazioni dell’io, e un secondo Quasimodo,
quello della poesia civile, impegnato a versare lacrime sulle macerie
della tragedia umana e animato dall’ostinata volontà di “ricostruire
l’uomo”, in realtà si può contrapporre una coerente evoluzione
tematica e formale: i contrassegni specifici del suo linguaggio
ermetico permangono, infatti, nelle più liriche, concrete e
realistiche esperienze della sua poesia successiva, caratterizzata
ancora dal gusto insistente per le analogie e le metafore e dalla
persistenza delle traslazioni mitiche e simboliche, dalla scansione
delle sinestesie e dalla simbiotica fusione di ambiguità semantiche,
lapidarie ellissi e sintagmatiche vaghezze allusive, anche se i nessi
sintattico-strutturali risultano illimpiditi e la parola si carica di
fosforescenti sinergie profetiche che imprimono alle intenzionalità
palingenetiche l’essenzialità e il realismo lirico-ritmico-stilistico
della comunicazione epica. Uno degli agenti più determinanti per
l’acquisizione di un diverso sentimento della parola, intesa in senso
di pregnante qualità lessicale, e non come estetizzante segno panico,
mitizzata, cioè, nella concreta assolutezza lirico-espressiva, fu
certamente la traduzione dei Lirici greci, che sospingono i percorsi
creativi e linguistici del poeta, sia verso la conquista di una
umanizzante coscienza poetica, che verso mete di maturità espressiva
ed estetica. Perciò, dalla poetica dell’assenza, del monologo, del
doloroso distacco dal contesto sociale con il conseguente rifugio in
una fendente solitudine, Quasimodo, attraverso la mediazione
teorico-pratica della lirica classica, recupera le radici della
propria voce e della propria cultura mediterranea, imboccando il
tracciato di quella poesia nuova, percorsa da sconvolgenti
interrogativi, non più incentrati sulla variabilità del lamento, del
vuoto e del nulla ma sulla pietrificata condizione delle sere sommerse
nella contestuale realtà coeva, con l’ausilio di procedimenti
espressivi, spinti al confine delle illuministiche operazioni di
voltairiano riscontro, paradigmate su una diversa linea poetica,
correlata al recupero della forza icastica della parola, riassorbita
nella sua antagonistica funzione di tutte le forze ostative di una
nuova resistenza per una ideale trasformazione della storia. Così,
alla poesia del frammento, tipica dell’Ermetismo, al crocianesimo
dell’intuizione lirica, alle fulgurazioni del Decadentismo, al
cronachismo neorealistico, alla disgregazione della struttura logica e
ideologica della parola delle sperimentazioni neoavanguardistiche,
alla tanta produzione poetica dell’evasione aulica di un tardivo
petrarchismo o del post-romanticismo, Quasimodo, grazie
all’appassionata frequenza con i lirici greci e i poemi classici (da
Saffo, ad Alceo, a Pindaro, a Omero, a Virgilio, al Vangelo, ecc.) e
all’influenza della poesia europea e mondiale sull’illimpidimento del
proprio linguaggio, approdò alla creazione di quel sistema
antropocentrico,
collocabile.come.sintesi.del.passaggio.dall’individualisti ca tastiera
lirica, ad una poetica pluralistica dell’uomo, fondata su sentimenti
di solidarietà e di fratellanza, coincidente con le connotazioni della
“pietas” dei classici, e, attraverso la semplificazione dei nessi,
delle figure retorico-stilistiche e dei collegamenti
sintattico-linguistici, è riuscito ad operare un’assolutizzazione
semantica della parola, capace di scandire con cristallinità di
immagini e una genetica musicalità dei ritmi, il già delineato
universo poetico di Salvatore Quasimodo. Nelle nove poesie di La vita
non è sogno composte tra il 1948 e pubblicate nel 1949, la poesia
civile si tramuta in acceso moralismo, espresso in toni epici, avvolti
di elegia, in cui letteratura e solidarietà umana si fondono ad
esprimere, la religiosità umanistica del poeta che riscopre i propri
simili, nelle loro miserie, nelle loro sofferenze e nelle loro
sconfitte e li avvolge in un irrefrenabile canto di amore e di morte,
dove la verità poetica non coincide ancora con la verità storica e i
dubbi, le risposte incompiute sull’etica umana e la storia,
ripropongono le coppie oppositive e particolarmente mito e storia, la
Sicilia e Milano, “Tanatos-Atanatos” che continuano a tormentare
sempre Quasimodo, ma che ora, tuttavia, appaiono riconciliate nella
conquista di una più realistica presa del reale, in cui la celerità
espressiva della tradizione letteraria lombarda si amalgama con la
semplicità lessicale dell’utopia poetica, insita nella quotidiana
ansia di rinascita del tempo esistenziale.Si leggano, a proposito, i
testi esemplari “Lamento per il Sud”, “Thànatos-Athanatos” e “Lettera
alla madre” dove il ritmo è scandito dalla disposizione verbale
coincidente con la struttura logico-descrittiva nell’ambito del verso
con poche variazioni in tal senso, con rari “enjambement” che
distendono in più versi la scansione logica delle riflessioni, e con
una sintetica capacità di capzione oggettuale della casa, della vita,
degli atteggiamenti affettivi e delle cose che scandiscono il rapporto
tra madre e figlio, in cui la semplicità degli espedienti tecnici
produce una linearità orizzontale di canto, priva di incrinature
superflue e perciò di elevata resa poetica. La raccolta Il falso e
vero verde pubblicata nel 1956, contiene quattordici poesie composte
il ’49 e il ’55 e distribuite in quattro gruppi: Il falso e vero
verde, Dalla Sicilia, Quando caddero gli alberi e le mura, di quattro
poesie ciascuna, e Epigrammi di sole due poesie. Nell’anno di uscita
del volume, in seguito alla denuncia dei crimini di Stalin operata da
Kruscev e all’invasione militare dell’Ungheria da parte dell’URSS che
troncò con i carri armati la rivolta ungherese, evidenziando una nuova
linea politica di stampo imperialistico, si determinò una crisi
ideologica nel gruppo degli intellettuali italiani di sinistra (tra
cui Quasimodo), che negli anni della Resistenza si erano illusi di
realizzare nella nuova società le loro istanze di rinnovamento. In
Italia, l’esplodere del miracolo economico genera la società del
benessere che, con la creazione della nuova mitologia consumistica, si
avvia a demolire i sogni resistenziali, esaltati particolarmente dai
poeti, sostituendoli con la logica edonistica dell’accumulo economico
borghese che riduce le masse proletarie ad una più totale schiavitù
nei confronti dell’imperialismo capitalistico.In tale clima di
restaurazione dell’ordine costituito, secondo tecniche e modalità da
“ancienne regime”, il poeta è riassalito dal dubbio di poter assistere
alla nascita del nuovo regno profetizzato, e, per non sentirsi
totalmente annientato dai soprassalti della disgregazione ideologica,
oppone un rifiuto ideale alla corrosione della propria epica del
“secondo Risorgimento” e dilata nell’eden della memoria il mito della
lotta popolare per la liberazione dell’umanità dal servaggio della
dittatura. Ora i temi lirici della “privacy” del poeta ritornano a
fondersi con i motivi dell’epopea popolare, attraverso una
strumentazione tecnica simile a quella della produzione precedente,
caratterizzata dalla varietà della versificazione, ora di breve ora di
lunga stesura, dallo spontaneo ritagliarsi del pensiero nell’armonica
cadenza dell’endecasillabo. Tali peculiarità appaiono evidenti nelle
poesie più emblematiche del clima della tragedia
bellico-resistenziale, quali Ai fratelli Cervi, Ai quindici di
Piazzale Loreto, mentre il tono di indignazione morale e il sentimento
di pietà collega la parola poetica all’orribile condizione umana del
“lager” in “Auschwitz”:
………………………………………………………
Da quell’inferno aperto da una scritta
bianca: “Il lavoro vi renderà più liberi”
uscì continuo il fumo
di migliaia di donne spinte fuori
all’alba dai canili contro il muro
del tiro a segno o soffocate urlando
misericordia all’acqua con la bocca
di scheletro sotto le docce a gas.
Sulle distese, , dove amore e pianto
marcirono e pietá, sotto la pioggia,
laggiù, batteva un no dentro di noi,
un no alla morte, morta ad Auschwitz,
per non ripetere, da quella buca
di cenere, la morte”.
Ora la consueta problematica esistenziale quasimodiana oscilla tra due
opposti luoghi geografici: la Sicilia, che s’insedia come meta del
viaggio della memoria mitica, come in “Tempio di Zeus ad Agrigento” e
nei componimenti della sezione “Dalla Sicilia”, in cui riaffiorano
immagini di invasioni e di guerra, mescolate ad intarsi naturalistici
di zagare e di fanciulle, assieme a fotogrammi di sottosviluppo e di
miseria della realtà presente; Milano, che riscatta tragicamente nella
visionarietà dei sogni dissolti con la concreta quotidianità dei suoi
ritmi e dei suoi strazi di morte, di incertezze e di silenzio, dove il
falso e vero verde dell’aprile evidenzia la drammaticità che tormenta
la coscienza dell’essere, dinnanzi ad un passato e presente di dolore
e di disumanizzazione e ad un futuro che non si riesce a ristrutturare
in una dimensione razionale e umana, dissennatamente bilanciato
soltanto dal residuo, demenziale conato di fede nell’attonita lotta
con le armi della poesia:
“Resta il pudore di scrivere versi
di diario o di gettare un urlo al vuoto
o nel cuore incredibile che lotta
ancora con il suo tempo scosceso”.
(“Il falso e vero verde”)
Dove la storia è vista, come osserva Giorgio Barbèri Squarotti, «come
un documento umano doloroso e crudele, per quanto della debolezza
interiore, ma anche dell’accettazione a pagare di persona per i propri
principi e i propri errori». La terra impareggiabile comprende
venticinque poesie, scritte tra il ’55 e il ’58, anno della
pubblicazione in volume, e divise in quattro sezioni: Ancora
dell’inferno, Dalla Grecia, Visibile, invisibile e Domande e risposte.
È il periodo in cui trionfa l’euforia consumistica e straripa lo
strapotere del capitalismo, mentre sul piano letterario, al tramonto
dell’impegno del neorealismo subentra una certa stanchezza provocata,
oltre che dagli sviluppi del XX Congresso del Partito Comunista
Sovietico e dai fatti di Ungheria, anche da una certa paura per
l’incombere della guerra fredda e del disastro atomico. In questi
nuovi versi, non mutano le ragioni poetiche di Quasimodo, anche se la
prevalenza dell’endecasillabo non ostacola l’alternarsi di versi più
distesi o contratti a comporre lasse di varia misura, attraversate da
fulgori lirici e coaguli ritmico-verbali in spiralizzazioni
prosastiche, assorbite in un linguaggio in evoluzione, idoneo a
variare dalla cronaca alla mimesi della metafisica personale, dalla
necessità di immediatezza comunicativa, all’essenzialità espressiva
dell’im-pegno metapolitico per l’uomo. Al progetto di riscatto
dell’uomo, frodato dall’inganno della storia, Quasimodo è sempre
rimasto fedele, continuando a captare i più indecifrabili messaggi del
reale e a tradurli in segnali di ipotetica, anche se illusoria
innovazione.Il razionalismo, che strutturava la pietà laica della
religiosità del poeta nelle opere precedenti, ora frugando
nell’efferatezza della cronaca o nel carattere rivoluzionario di
alcune conquiste scientifiche, pur in preda ad una irrisolta crisi
esistenziale, alimentata dal dilemma delle consuete antinomie,
vita-morte, miseria-opulenza, visibile-invisibile, si tramuta in inno
alle capacità intellettuali dell’uomo, riuscendo a far sopravvivere il
poeta nel nuovo neoilluministico mito dell’Uomo che, con la forza
della ragione, riesce a riconciliare la vita con il mistero
esistenziale, il visibile con l’invisibile, la civiltà dell’atomo con
la paura del dissolvimento planetario.È un canto, come osserva
Gilberto Finzi, vagamente foscoliano, di laica attesa virile, quello
che Quasimodo dedica appunto alla “terra impareggiabile”, in cui il
poeta vorrebbe sentirsi:
“Più vicino al cielo… alla lucente
immaginazione degli astri, più lontano
da terra che l’uomo teme da vivo o da morto”
“Dare e avere”, una raccolta di ventidue poesie scritte negli anni
sessanta, dopo il riconoscimento del Nobel, ed edite nel 1966, già nel
titolo che prefigura un bilancio esistenziale, contiene un presagio di
morte, in un animo che sembra pacificato con se stesso, dopo la
denuncia delle offese storiche arrecate all’uomo, e dopo gli urli
sociologici del dopoguerra. Così la mitopoietica, che è l’antica forma
del suo mito personale, si alterna alla metapolitica, che è invece la
forma ultima estratta dalle istanze sociali e dalle preoccupazioni del
poeta sui “destini generali”, per cui la metapolitica si traduce in
illuministica rivolta dello spirito contro ogni forma di repressione,
in particolare contro il politico che, con la sua gestione irrazionale
delle istituzioni, rende invivibile e disperata la vita. Un sentimento
di fraternità sconfinata e un messaggio di solidarietà fra gli uomini
di ogni sorte e di ogni colore, dominano i versi di “Varvàra
Alexandrovna”:
“… Sei la Russia umana
del tempo di Tolstoj o di Majakovskij,
sei la Russia, non un paesaggio di neve
riflesso in uno specchio d’ospedale
sei una moltitudine di mani che cercano altre mani”.
In questa ulteriore evoluzione della visione del destino
dell’individuo e della collettività che il poeta vuole riscattare da
ogni forma di costrizione e di irrazionalità, l’ultima utopia poetica
rimane il mito della libertà che conclude la storia umana di
Quasimodo, mentre la storia della sua poesia è sigillata
dall’aspirazione dell’individuo-poeta all’immortalità attraverso la
memoria eterna della poesia, simboleggiata dal tiglio, al quale, in
Ungheria, presso il lago Balaton, è stato dato il suo nome. Una
utopica conclusione foscoliana di un poeta che è rimasto fedele alla
poesia, intesa come il solo strumento capace di trasformare il mondo e
di donare a ciascuno la liberazione totale da ogni storica e inconscia
catena dell’io. Poesia, pertanto, come nota Carlo Bo, che è la vera
religione di Quasimodo, il suo primo e ultimo mito, la sua più
incarnata e razionale utopia.
POESIE
Ed è subito sera
(da Acque e terre, 1930)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.
Guida alla comprensione del testo
Salvatore Quasimodo, a differenza di Ungaretti che da “uomo di poesia”
diventa “uomo di fede”, e di Montale che canta la disarmonia della
vita e della storia, tra sentimento di pietà, accenti satirici e
ironici, presenta un maggiore tormento, che talvolta si trasforma in
grido, invettiva e lamento, imprimendo al suo stile soluzioni formali
ed espressive più solide e laceranti. Uomo fortemente travagliato
dalla convinzione dell’assenza di Dio, la sua disperazione diventa
spesso acuta, soprattutto quando si sporge sulla voragine esistenziale
e scopre l’abisso del cuore, senza il conforto di alcuna metafisica
scheggia di luce.
La lirica si può suddividere in tre sequenze, corrispondenti a tre
stazioni della vita dell’uomo, internamente unificate dalla
delineazione di un unico percorso esistenziale.
Nella prima sequenza, è espressa la condizione dell’uomo, prigioniero
di un destino di solitudine e di inutile ricerca di speranza. Nella
seconda sequenza, il sole perde il significato di elemento
vivificatore e assume l’accezione di precarietà e di dolore,
diventando luce solo per un attimo, in cui sembra accendere
l’illusione del sogno per dissolverlo improvvisamente, lasciando
l’uomo “trafitto” da un’inguaribile ferita. Nella terza sequenza, il
sipario della morte cala implacabile come epilogo della vita, dove la
luce del sole evidenzia un rapporto di continuità con il termine
“sera”. Il sole e la sera diventano metafora della crudele sconfitta e
del trionfo perenne della morte sulla vicenda terrestre. Nei tre versi
liberi, di regolare misura, in cui è strutturata la poesia, la parola
poetica risulta scarnificata, resa idonea ad esprimere, in un angusto
spazio verbale, i vari momenti della vita umana. Gli stessi verbi sono
il risultato di un processo selettivo, teso ad evidenziare il concetto
di immobilità e di sclerosi del percorso esistenziale della creatura
umana.
Uomo del mio tempo
(da Giorno dopo giorno, 1947)
Sei ancora quello della pietra e della fionda54,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga55,
con le ali maligne, le meridiane56 di morte,
t’ho visto – dentro il carro di fuoco57, alle forche58,
alle ruote di tortura59. T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa60 allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
Quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
Salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
Guida alla comprensione del testo
La lirica annuncia la barbarie dell’uomo di ogni tempo, dal primo
crudele e assurdo fratricidio biblico, fino alle stragi etniche
dell’età contemporanea, quando anche la “scienza”, idealmente
portatrice di progresso, è diventata simbolo di regresso e strumento
di efferata crudeltà.La linea poetica si evolve su concetti di
negatività e il poeta esprime angoscia, sdegno, ammonimento, fino
all’accorata esortazione finale, affinché i figli di Caino rifiutino
il testamento di morte, lasciato dai padri, anzi li rinneghino, per
essersi macchiati di delitti terrificanti, che hanno insanguinato nei
secoli la terra, da dove ora continuano idealmente a sollevarsi nuvole
di quel sangue. Nelle loro tombe le ossa dei padri “affondano nella
cenere” delle vite che hanno stroncato con tanta mostruosità. La tomba
che, in Ugo Foscolo, aveva una funzione simbolico-affettiva,
generatrice di eterni valori e garanzia di immortalità per gli uomini
grandi, da Quasimodo è vista come luogo di morte spirituale e di
implacabile cancellazione dei vivi malvagi, la cui memoria i figli
disperderanno al vento, perché i padri hanno loro lasciato in eredità
solo gli “uccelli neri”, luttuosa immagine di morte ed espressione di
un sanguinante percorso della storia. La lirica, in versi liberi, è
contrassegnata da un linguaggio vibrante e appassionato, dove le
iterazioni martellanti rendono più tragico il sentimento della morte e
la sinestesia “sangue-odora” (v. 10) imprime alla morte per violenza
altrui l’odore vivo ed orroroso del sangue, che nella seconda guerra
mondiale (alla fine della quale nacque la poesia), allagò l’intero
pianeta.
Alle fronde dei salici
(da Giorno dopo giorno, 1947)
E come potevano noi cantare
Con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.
Analisi del testo
Il componimento “Alle fronde dei salici” è tratto dalla raccolta
Giorno dopo giorno (1947), il cui primo nucleo intitolato Dieci
poesie, uscì nel 1942 durante la guerra.
La raccolta segna il “secondo tempo” della lirica quasimodiana, dopo
la fase ermetica degli Anni Trenta (Acque e Terre, Oboe sommerso,
Erato e Apollonion) e registra la sua conversione da poeta lirico a
poeta civile, passando dall’individualismo della produzione
precedente, infarcita di miti, ad un piano di testimonianza umana, in
un momento tragico della storia.Il poeta si interroga sul significato
della poesia in un periodo storico, in cui la guerra, dopo aver
prodotto irreparabili devastazioni e, particolarmente tra il
1943-1945, quando, dopo l’8 settembre, si trasformò in guerra civile,
di partigiani contro nazifascisti sul territorio italiano, dove i
fratelli massacravano i fratelli con atti di atrocità belluina anche
contro creature innocenti e bambini e ognuno dovette farsi i conti con
la propria coscienza.
Anche molti intellettuali e poeti furono costretti a ripensare al loro
modo di rapportarsi con la società e con le istituzioni, durante il
periodo della dittatura e con la loro aristocratica posizione di
astrazione dall’impegno, si resero involontari complici del
consolidarsi di quel regime tirannico che trascinò il popolo al
disastro bellico. Di questi artisti, Quasimodo in questa poesia opera
un esame di coscienza, affidando a quel “mai” iniziale un segnale di
volontà, ampiamente diffusa, di superare la chiusura ermetica dell’io
e di contribuire alla rinascita etica collettiva. Ora che hanno
assistito allo sconvolgimento dell’occupazione tedesca («con il piede
straniero sopra il cuore») e alle atrocità commesse contro i
combattenti per la liberazione, con barbariche rappresaglie («i morti
abbandonati nelle piazze» (v.3): «il lamento d’agnello dei fanciulli»
e «l’urlo della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul
palo del telegrafo» (vv. 4-7), i poeti non riescono più a parlare, per
denunciare col canto l’amore che li ha strozzati.Perciò hanno scelto
il silenzio, per unirsi al dolore comune. Nel secondo Quasimodo, lo
stile ermetico si è evoluto, sciogliendo la parola sigillata in
lamento più aperto e disperato, per rivelare, con estrema chiarezza,
un sentimento di solidarietà e di pietà prima inespressa e
trasformandosi in portavoce dell’inconsolabile sofferenza di tutti gli
uomini. Dell’ermetismo rimangono immagini simboliche e locuzioni
ossimoriche, collocate sulla tastiera risuonante della tragedia.Le
analogie sono ancora persistenti, come i rimandi alla tradizione
bellica, l’esilio degli Ebrei da Babilonia, l’agnello sacrificale, il
crocifisso, preso dalla tradizione cristiana e le atrocità
nazifasciste, che innalzano la drammatica realtà contemporanea, in una
dimensione di significato universale.
Il lessico risulta semplificato e le sinestesie, spesso più
controllate ed efficaci, cedono talvolta ad un’apparente accentuazione
di retorica, come l’immagine del “piede sopra il cuore”, o “lamento
d’agnello”.Alcune dichiarazioni, rese da Quasimodo nel 1946, sulle
rovine della guerra in una Milano sconvolta, sottolineano la
“conversione” al nuovo ruolo di impegno del poeta: “Oggi dopo due
guerre, nelle quali l’eroe è diventato un numero sterminato di morti,
l’impegno del poeta è ancora più grave, perché deve “rifare” l’uomo,
quest’uomo disperso sulla terra, del quale conosce i più oscuri
pensieri, quest’uomo che giustifica il male come una necessità, un
bisogno dal quale non ci si può sottrarre, quest’uomo che aspetta il
perdono evangelico tenendo in tasca le mani sporche di sangue […]”. La
posizione del poeta non può essere passiva nella società, egli deve
contribuire a modificare il mondo.Le sue immagini forti, quelle create
battono sul cuore dell’uomo più che la filosofia e la storia. La
poesia si trasforma in etica proprio per la sua resa di bellezza. In
parte è tale quando non rinuncerà alla sua presenza in una data terra,
in un tempo esatto, definito politicamente. Per quelli che credono
alla poesia come a un gioco letterario, che considerano ancora il
poeta un estraneo alla vita, uno che sale di notte le scalette della
sua torre per speculare il cosmo, diciamo che il tempo delle
“speculazioni” è finito.Rifare l’uomo, questo è l’impegno (S.
Quasimodo, Poesia contemporanea in Poesia e discorso sulla poesia,
Mondadori, Milano, 1971).
Lettera
Da Giorno dopo giorno (1947)
Questo silenzio fermo nelle strade,
questo vento indolente che ora scivola
basso tra le foglie morte o risale
ai colori delle insegne straniere73…
forse l’ansia di dirti una parola
prima che si richiuda ancora il cielo
sopra un altro giorno, forse l’inerzia,
il nostro male più vile… La vita
non è in questo tremendo, cupo, battere
del cuore, non è pietà, non è più
che un gioco del sangue, dove la morte
è in fiore. O mia dolce gazzella,
io ti ricordo quel geranio acceso
su un muro crivellato di mitraglia.
O neppure la morte ora consola
più i vivi, la morte per amore?
Analisi del testo
Questa poesia, tratta dalla raccolta Giorno dopo giorno, pubblicata
dopo la fine della seconda guerra mondiale, rappresenta un frammento
di vita vissuta tra gli orrori del conflitto bellico. Appartiene,
perciò, al tempo della fine dell’impegno civile del poeta, come quello
contenuto in tutta la raccolta. Esprime la consapevolezza,
interiorizzata dal poeta, dell’impossibilità di pronunciare parole
d’amore o di poesia, nello sbalordimento di immagini, di distruzione e
di orrore, provocati dalla paura. In tale atmosfera di devastazione e
di strage, non c’è posto per consolazioni, neppure “la morte per
amore” può sostenere la speranza nei vivi.
Questa poesia è dominata da un sentimento cupo, è una lettera scritta
da un luogo da intendersi come “topos” simbolico del regno della
morte, dove anche il vento (altro elemento simbolico della tragica
realtà estesa anche all’intera natura, pure vittima della guerra) è
“indolente” e l’amore sembra essere, non solo tra gli uomini, ma
particolarmente nel cuore del poeta, soltanto vaga reminiscenza di un
tempo svanito. Ora, solo la morte (con un’immagine tipica
dell’amplificazione retorica di altre liriche quasimodiane) fiorisce
nel sangue, come un geranio dipinto sul grigiore di un muro dagli
schizzi di sangue dei corpi di uomini fucilati.
Lamento per il Sud
(da La vita non è sogno, 1949)
La luna rossa, il vento, il tuo colore
di donna del Nord, la distesa di neve…
Il mio cuore è ormai su queste praterie
in queste acque annuvolate dalle nebbie.
Ho dimenticato il mare, la grave
conchiglia soffiata dai pastori siciliani,
le cantilene dei carri lungo le strade
dove il carrubo trema nel fumo delle stoppie,
ho dimenticato il passo degli aironi e delle gru
nell’aria dei verdi altipiani
per le terre e i fiumi della Lombardia.
Ma l’uomo grida dovunque la sorte di una patria.
Più nessuno mi porterà nel Sud.
Oh, il Sud è stanco di trascinare morti
in riva alle paludi di malaria,
è stanco di solitudine, stanco di catene,
è stanco nella sua bocca
delle bestemmie di tutte le razze
che hanno urlato morte con l’eco dei suoi pozzi
che hanno bevuto il sangue del suo cuore.
Per questo i suoi fanciulli tornano sui monti,
costringono i cavalli sotto coltri di stelle,
mangiano fiori d’acacia lungo le piste
nuovamente rosse, ancora rosse, ancora rosse79.
Più nessuno mi porterà nel Sud.
E questa sera carica d’inverno
è ancora nostra, e qui ripeto a te
il mio assurdo contrappunto
di dolcezze e di furori,
un lamento d’amore senza amore.
Dentro il testo
Dopo l’assegnazione del Nobel, molte furono le polemiche dei critici
sulla produzione poetica del poeta siciliano. Esse non furono
suscitate solo da interpretazioni di provincialismo della poetica del
Nostro, ma, in molti casi, da faziosità campanilistiche di una critica
prezzolata dalla stampa filo-montaliana che, in importanti quotidiani
del Nord, aveva la sua “roccaforte”. A distanza di anni, le polemiche
possono essere agevolmente ridimensionate, in quanto ad una lettura
completa delle opere di Quasimodo, possono considerarsi pretestuose,
per la divisione in tempi della lirica quasimodiana, ermetica la
produzione degli anni Trenta, civile quella della guerra e
dell’immediato dopoguerra, etica ed apertamente umana, e perciò
universale, quella posteriore all’assegnazione del Nobel.In realtà,
nella poesia del poeta di Modica, nella parola ermetica, ricca di
mistero e al di fuori del tempo, può cogliersi quel dramma del poeta
che riflette nel suo il dramma dell’uomo, sigillato nel proprio
tormento esistenziale, come una monade leibnitziana, mentre nella
poesia successiva, negli anni dell’apocalisse della storia, il grido
del poeta, ormai privo di ogni speranza di resurrezione, si dilata in
espansioni colloquiali più vaste, in cui Quasimodo proietta su più
ampi orizzonti il proprio “male di vivere”, nella convinzione
dell’assurdità del male storico, accomunato al dolore universale. Il
male individuale diventa riproduzione allegorica del male generale e
il sentimento nostalgico del poeta per la sua terra e il dolce ricordo
della madre lontana, diventano metafora dell’uomo che, nel periodo
della perdita di identità dell’essere, ricerca, (come Pirandello o
Vittorini in altri modi), la serenità delle proprie origini
esistenziali e dei propri inestirpabili affetti. Nascono, in tale
dimensione interiore, le intense liriche, come Lamento per il Sud.
Lettera alla madre
(da La vita non è sogno, 1949)
«Mater dulcissima, ora scendono le nebbie,
il Naviglio urta confusamente sulle dighe,
gli alberi si gonfiano d’acqua, bruciano di neve;
non sono triste nel Nord: non sono
in pace con me, ma non aspetto
perdono da nessuno, molti mi devono lacrime
da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi
come tutte le madri dei poeti, povera
e giusta nella misura d’amore
per i figli lontani. Oggi sono io
che ti scrivo.» – Finalmente, dirai, due parole
di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto
e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore
lo uccideranno un giorno in qualche luogo. –
«Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo
di treni lenti che portavano mandorle e arance,
alla foce dell’Imera, il fiume pieno di gazze,
di sale, d’eucalyptus. Ma ora ti ringrazio,
questo voglio, dell’ironia che hai messo
sul mio labbro, mite come la tua.
Quel sorriso m’ha salvato da pianti e da dolori.
E non importa se ora ho qualche lacrima per te87,
per tutti quelli che come te aspettano,
e non sanno che cosa. Ah, gentile morte,
non toccare l’orologio in cucina
che batte sopra il muro
tutta la mia infanzia è passata sullo smalto
del suo quadrante, su quei fiori dipinti:
non toccare le mani, il cuore dei vecchi.
Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà,
morte di pudore. Addio, cara, addio, mia dolcissima mater.»
Guida alla comprensione del testo
Lettera alla madre ed altre, sono testimonianze della affettività del
poeta, sottolineata da un linguaggio folgorante e tuttavia calibrato,
carico di suggestioni emotive, di strazio sentimentale e di intensa
lucidità.In questa fase “colloquiale”, filtrata anche attraverso
l’esperienza della traduzione dei Lirici greci, affiora un’apertura
interiore che salda il dolore dell’esule Quasimodo, al destino di
altri esseri che vivono in esilio, per diventare metaforicamente
esilio assoluto dell’uomo, condannato a vivere lontano dalla patria
mitica della nascita, o dalla mitica patria del cielo. Pertanto la
Sicilia di Quasimodo diventa la Itaca di Ulisse, ma anche la patria
interiore dell’uomo, corrosa dal gomitolo dei sogni infranti e dalla
perduta memoria dell’infanzia felice. Cadono così le barriere
convenzionali delle fasi della poesia quasimodiana e, quando in Dare e
avere il poeta scandirà il conto della vita e delle cifre del dare e
dell’avere sul sentimento della solidarietà universale di fronte alla
morte, oltre ogni cortina ideologica, la voce del poeta acquisterà la
sua omogeneità e aprirà il suo poetare a vie nuove, dove ancora c’è
spazio per un diverso futuro. “Mater dulcissima”, anastrofe iterata
all’inizio e alla fine della lirica, sottolinea la sacralità
dell’affetto del poeta per la propria madre, ma nella sua reminiscenza
biblica, ripetuta nella liturgia ecclesiastica, la commozione
individuale esprime, per estensione simbolica, un sentimento religioso
che è patrimonio di tutti gli uomini (al di là della pregnante
presenza nella sua Sicilia). Qui le piccole cose, gli oggetti comuni,
i luoghi memoriali della fanciullezza, creano un clima in cui l’intera
umanità può riconoscersi e il dolore del distacco, come anche il
tormento dell’impossibile “nostos”, esplodono nell’apostrofe sacrale
della morte che, se riuscirà a cancellare ogni traccia di ideale
presenza, non riuscirà a strappare dal cuore del poeta le radici di un
amore immortale, anche se alimentato dal disinganno del tempo e del
destino.
BIBLIOGRAFIA
Poesia:
Acque e terre, Firenze 1930; Oboe sommerso, Genova 1932; Odore di
eucalyptus e altri versi, Firenze 1933; Erato e Apollion, Milano 1936;
Ed è subito sera, ivi 1942; Con il piede straniero sopra il cuore, ivi
1946; Giorno dopo giorno, ivi 1947; La vita non è un sogno, ivi 1949;
Il falso e vero verde, ivi 1954; (poi 1956); La terra impareggiabile,
ivi 1958; Orfeo-Anno Domini mcmxlvii, ivi 1960; Dare e avere, ivi
1966.
Saggistica e prose varie:
Francesco Messina, Milano 1938; Petrarca e il sentimento della
solitudine, ivi 1945; Il poeta, il politico e altri saggi, ivi 1960;
Scritti sul teatro, ivi 1961; Un anno di Quasimodo, Genova 1968;
Traduzioni:
Lirici greci, Milano 1940; Il fiore delle Georgiche, ivi 1942;
Dall’Odissea, ivi 1945; Catulli Veronensis Carmina, ivi 1945; J.
Ruskin, La bibbia di Amiens, ivi 1946; Il Vangelo secondo Giovanni,
ivi 1946; Sofocle, Edipo re, ivi 1946; Eschilo, Le coefore, ivi 1949;
W. Shakespeare, Romeo e Giulietta, ivi 1949; Id., Riccardo III, ivi
1952; Neruda, Poesie, Torino 1952; W. Shakespeare, Macbeth, ivi 1953;
Sofocle, Elettra, Milano 1954; W. Shakespeare, La tempesta, Torino
1956; Il fiore dell’antologia palatina, Parma 1958; W. Shakespeare,
Otello, Milano 1959; Dalle “Metamorfosi” di Ovidio”, ivi 1959;
Euripide, Ecuba, ivi 1964; W. Shakespeare, Antonio e Cleopatra, ivi
1966; Euripide, Eracle, ivi 1966; P. Eluard, Donner à voir, ivi 1970.
Epistolari:
Le lettere d’amore di Quasimodo, Milano 1970; Lettere d’amore a Maria
Cumani (1936-1959), prefazione di D. Lajolo, ivi 1973; S. Quasimodo-G.
La Pira, Carteggio, a cura di A. Quasimodo, ivi 1980; A Sibilla,
prefazione di G. Vigorelli, ivi 1983.
Poesie e discorsi sulla poesia sono raccolti nel volume de “I
Meridiani” di Mondatori, con introduzione di G. Finzi, e prefazione di
C. Bo, Milano, 1971 (VI ed., ivi 1983).
Studi:
M. Tondo, Lineamenti di una storia della critica quasimodiana, Bari
1969, pp. 773-99. Acque e terre: primi recensori E. Montale, in
“Pegaso” del n°3- 1931. Oboe sommerso, recensioni G. Ferrata, in
“Solaria” del 6-1932. S. Solmi a Erato e Apòllion e Ed è subito sera
(Milano 1942) in Scrittori negli anni, Milano 1963, M. Valgimigli,
Poeti greci e “lirici nuovi” (1946), a cura di C. Bo e S. Quasimodo,
Giorno dopo giorno, Milano 1947. G. Pampaloni, Salvatore Quasimodo,
“La vita non è sogno”, in “Il Ponte”, VI (1950), pp. 424-25;F. Flora,
Quasimodo: preludio sul lessico della poesia d’oggi (1951), in Id.,
Scrittori italiani contemporanei, Pisa 1952; B. Pento, Lettura di
Quasimodo, Milano 1966; M. Tondo, Salvatore Quasimodo, Milano
1970-1976) G. Finzi, Invito alla lettura di Quasimodo, ivi 1972; E.
Salibra, S. Quasimodo, Roma 1985. S. Quasimodo. La poesia nel mito e
oltre, Atti del Convegno Nazionale di studi su Salvatore Quasimodo
(Messina, 10-12 aprile 1985), a cura di G. Finzi, Bari 1986; O. Macrì,
La poesia di Quasimodo, Palermo 1987; C. Aliberti, La poesia di S.
Quasimodo, La Procellaria, Reggio Calabria, 1999.C.Aliberti,
Letteratura Siciliana Contemporanea, Pellegrini, 2998, Cosenza.
C.Aliberti, L’Altra Letteratura Siciliana contemporanea, La Medusa
Editrice, Marsala, 2013, C.Aliberti, Blog Terzomillennio, C.Aliberti,
Rivista Internazionale di letteratura, n° giugno. 2014